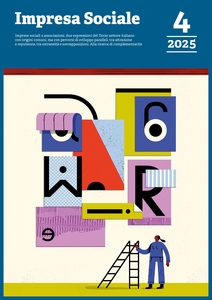Numero 4 / 2025
Cambiare si può. Esperienze associative in contesti istituzionali
Cristiano Caltabiano, Cecilia Ficcadenti
Abstract
A partire dagli studi sui tiny publics portati avanti specialmente dal sociologo americano G.A. Fine che mettono a fuoco come l’aggregazione in piccoli gruppi possa costituire un livello meso che connette le istituzioni e la società civile, si indaga come le pratiche associative di civic engagement riescano ad entrare nei processi di cambiamento istituzionale. L’articolo si basa su nove casi di studio in diversi contesti istituzionali, quello della salute mentale, del lavoro nel settore della cultura e della scuola, attraverso l’utilizzo di tecniche d’intervista e di osservazione. I principali risultati mettono in luce come l’attivazione dei destinatari di queste esperienze associative (giovani studenti, lavoratori precari, persone con disagi psichici), attraverso pratiche di socializzazione e riconoscimento, generi degli spazi di produzione di nuovi saperi oltreché legami solidaristici e cooperativi, ovvero un campo di possibilità per l’azione collettiva territoriale.
1. Introduzione
Negli studi sulle organizzazioni non profit, tanto in Italia che all’estero, si è registrata negli ultimi decenni una convergenza verso la nozione di ibridazione, un concetto che aiuta a spiegare l’evoluzione della variegata platea di enti riconducibili al Terzo settore (ETS) nelle democrazie tardocapitalistiche (Reggiardo, 2022). L’idea è che, per quanto siano portatori di istanze radicalmente diverse rispetto al mercato e allo Stato, questi attori (associazioni prosociali e di volontariato, imprese sociali, altri soggetti filantropici, mutualistici, di matrice caritativa o di altra natura) finiscano in qualche modo con l’assumere tratti simili alle burocrazie pubbliche e alle imprese for-profit, proprio perché non operano in un “vuoto sociale”, essendo piuttosto coinvolti in una trama di rapporti all’interno della società, che ne condizionano lo sviluppo.
Guardando alle relazioni con la sfera politica, si tende a parlare di isomorfismo, seguendo gli assunti dell’analisi neoistituzionale delle organizzazioni complesse (Powell, Di Maggio, 1991), per cui gli ETS, partecipando stabilmente alla costruzione sul territorio dei servizi di welfare (e di altre policy pubbliche) avrebbero progressivamente assunto la postura delle amministrazioni locali, irrigidendosi nel proceduralismo, ovvero andando incontro a processi di burocratizzazione (Corchia, 2011; Eliasoph, 2009; Papakostas, 2011). Per altri versi, sul versante degli intrecci con il mercato, si assisterebbe ad una professionalizzazione o aziendalizzazione del mondo della solidarietà organizzata, laddove un numero crescente di ETS sarebbero spinti ad adottare sempre più modelli business like, caratterizzati dall’enfasi sul project management, sulla performance e sul marketing sociale, con il rischio di snaturare le proprie finalità (mercatizzazione), un esito alquanto paradossale per istanze e pratiche nate spesso proprio per dare una risposta (seppur non risolutiva) alle contraddizioni più stridenti del neoliberismo, fra tutte la necessità di includere le persone fragili o svantaggiate che restano nelle retrovie della società (Roy, Eikenberry, Teasdale, 2022).
Vi è senza dubbio un fondo di verità negli scenari dell’ibridazione del Terzo settore, in quanto sarebbe fuorviante presumere che vi sia una netta separazione dell’associazionismo e dell’imprenditorialità sociale rispetto alle sfere dello Stato e del mercato, trascurando il dato di fatto che vi è un intreccio di rapporti (più o meno fitto) che lega gli enti della solidarietà organizzata ai poteri economici e pubblici, locali e nazionali. Ma alcune disamine sugli effetti di questa contaminazione (o condizionamento) convincono francamente meno, soprattutto la tesi secondo cui gli ETS si sarebbero depoliticizzati a causa dell’abbraccio fatale con le logiche tipiche dell’economia e del sistema politico-istituzionale, in conseguenza del quale vi sarebbe stata una perdita complessiva della carica trasformativa rispetto alla realtà esistente (Busso, 2018, 2020). È persino scontato osservare che nel Terzo settore convivano prassi e organizzazioni talmente variegate da rendere la normalizzazione politica una dinamica pur sempre relativa: accanto ad esperienze civiche che col trascorrere del tempo possono diventare meno incisive, limitandosi ad agire in un’ottica riparativa o semplicemente conformandosi al sistema vigente, si affermano di continuo anche iniziative sociali mosse dall’ambizione di innescare dei mutamenti significativi nelle comunità locali dove operano.
Spesso si fa fatica a cogliere l’effervescenza della società civile, forse perché si concentra troppo l’attenzione sulle funzioni che l’associazionismo di promozione sociale, il volontariato, l’impresa sociale e la filantropia svolgono nella nostra società, volendo misurare gli effetti che questi (ed altri) attori creano nei differenti contesti in cui agiscono (Vitale, 2024). Studi di questo genere portano a fare un bilancio sui costi-benefici, per capire se con l’apporto degli ETS la qualità e l’efficienza dell’offerta dei servizi alla persona siano migliorate, oppure mirino a valutare l’impatto sociale delle iniziative poste in essere dagli soggetti solidaristici sul territorio o, in ultima analisi, cerchino di monitorare l’andamento dei volontari e degli attivisti nel corso del tempo, per scoprire se l’associazionismo e il volontariato offrano ancora spazi e occasioni per coltivare la cittadinanza attiva. Non c’è nulla di sbagliato nel rispondere alla domanda “A cosa servono gli ETS?”, ma forse sarebbe anche opportuno chiedersi come e perché le esperienze associative continuino a generarsi nel tessuto della società civile[1].
Oltreoceano, da qualche tempo, ci si è resi conto della scarsità di ricerche sui meccanismi interni di formazione delle azioni civiche che prendono corpo nella società. Alcuni autori hanno cambiato decisamente prospettiva nello studio del non profit, andando oltre gli approcci macro (studi comparativi internazionali e cross-settoriali sul profilo organizzativo e i vincoli sistemici che affrontano tali soggetti collettivi) e le prospettive d’indagine micro (ricerche demoscopiche o etnografiche sulle motivazioni e i comportamenti delle persone che si impegnano a titolo gratuito o lavorano in tali organizzazioni). Si punta in tale ottica a riesaminare la dimensione meso nella società civile, soffermandosi soprattutto su come si formano e con quali logiche operano le associazioni solidaristiche o i soggetti dell’economia sociale[2].
In un influente articolo apparso circa dieci anni fa, Lichterman e Eliasoph hanno proposto una visione alternativa dell’azione civica, fondata su resoconti etnografici di scene associative, mutuando apparati concettuali e strumenti di osservazione dall’interazionismo simbolico e da Goffman (Lichterman, Eliasoph, 2014). Questa metodologia qualitativa è stata peraltro ripresa anche da Citroni, che l’ha utilizzata di recente per ricostruire il repertorio d’azione di alcune realtà organizzative del Terzo settore in Lombardia (Citroni, 2022). In una prospettiva simile si muovono anche le riflessioni e le ricerche del sociologo Fine (2012), il quale ha sostenuto che è necessario indagare la genesi e i processi di mobilitazione dei gruppi che si formano incessantemente nella società civile, recuperando una tradizione di ricerca che affonda le radici tra gli anni ’40 e gli anni ’60 dello scorso secolo: dai lavori pionieristici di Whyte sulle subculture urbane (Whyte, 1943) agli studi sperimentali di Sherif sulle relazioni intergruppo (Sherif et al., 1961), passando per la rilettura sistematica di questa letteratura empirica ad opera di Merton, da cui è scaturita la teoria dei gruppi di riferimento (Merton, Rossi, 1950). Fine sostiene che ha ancora un senso approfondire la funzione svolta dai gruppi associativi (formali e informali) nelle democrazie contemporanee, afflitte dall’astensionismo elettorale e dai rigurgiti neopopulisti, nella misura in cui questi corpi intermedi sono ambienti socio-cognitivi dove i cittadini possono generare risorse per l’azione collettiva e in tal senso costituiscono un ponte (una cerniera, per usare la metafora dell’autore) tra l’individuo e la sfera pubblica (Fine, 2014).
Nel presente articolo ci si muove nel solco tracciato da tali filoni di ricerca, riesaminando le evidenze empiriche emerse in nove studi di caso realizzati nell’ambito del Decimo Rapporto sull’Associazionismo Sociale[3]. In particolare, sono state analizzate diverse esperienze associative che operano in tre contesti fortemente istituzionalizzati[4]: il mercato del lavoro artistico-culturale, la salute mentale e la scuola. La scelta è stata quella di esaminare contesti particolarmente strutturati dove l’associazionismo si confronta con norme, gerarchie e codici culturali vincolanti (benché possano essere espressi in modo latente o vagamente manipolatorio). Si vuole in tal modo capire se, in che misura e come questi gruppi riescano comunque a perseguire gli obiettivi per cui si sono formati, affrontando problemi pressanti e contraddizioni stridenti, senza rinunciare all’ambizione di migliorare la condizione delle persone che aggregano (o a cui si rivolgono), oltre a voler contribuire al progresso sociale della comunità, per quanto in una prospettiva inevitabilmente limitata. Il che non esclude che tali enti associativi possano subire fasi di stallo nel loro percorso di sviluppo, essendo non di rado costretti a rinegoziare valori e istanze costitutivi, sotto la pressione di condizionamenti esterni.
Come si può vedere dalla tabella sottostante si tratta di organizzazioni molto eterogenee, sia in termini di longevità, sia sul piano della strutturazione interna: pur essendo nate tutte negli anni 2000, vi sono enti come Redacta, Tramiti, La Ricostituente e Arca che si sono costituiti durante o dopo la pandemia, mentre altre realtà come i collettivi dei maestri e degli artisti di strada sono venuti alla luce più di dieci o vent’anni fa; accanto a ciò, cinque di queste formazioni hanno assunto una veste formale dal punto di vista giuridico, essendo anche iscritte al RUNTS o comunque avendo depositato un atto costitutivo, mentre tre sono forme associative del tutto informali.
Tabella 1 - I casi esaminati nella ricerca
|
Denominazione e raggio d’azione |
Anno di costituzione |
Configurazione del gruppo |
Membership |
|
Advocacy freelance settore della cultura |
|
|
|
|
Redacta e Tramiti (Associazione Acta) Milano, Bologna, Firenze |
2020/23 |
Gruppi informali all’interno di una associazione senza scopo di lucro |
Circa 20-30 associati In ciascuno dei due gruppi |
|
Mi riconosci? Raggio d’azione nazionale |
2019 |
Associazione di promozione sociale iscritta al RUNTS |
70 associati (10 sedi territoriali) |
|
Associazione Artisti di Strada Milano (ASM) |
2013 |
Gruppo informale |
12 associati |
|
Salute mentale |
|
|
|
|
Sentire le Voci Raggio d’azione Nazionale |
2019 |
Associazione di promozione sociale iscritta al RUNTS |
165 associati |
|
Arca Reggio Emilia e Lucca |
2023 |
Associazione di promozione sociale iscritta al RUNTS |
30 associati |
|
Club SPDC No Restraint Trento |
2011 |
Gruppo territoriale all’interno di un’associazione nazionale costituita come OdV e iscritta al RUNTS |
10 associati c.a. |
|
Scuola |
|
|
|
|
Maestri di Strada Napoli (quartiere Ponticelli) (MdS) |
2003 |
Associazione, Onlus |
circa 30 |
|
Associazione Un mondo nel cuore Roma (quartiere Corcolle) |
2016 |
Associazione di promozione sociale iscritta al RUNTS |
46 |
|
La Ricostituente Rete nazionale |
2020 |
Progetto promosso da due cooperative sociali |
4 cooperatori (200 giovani coinvolti) |
Il livello di formalizzazione e i meccanismi interni di governance contano solo fino ad un certo punto, in formazioni sociali che si muovono negli interstizi della società, proponendosi di dare voce a territori dimenticati o a persone/categorie sociali tendenzialmente svantaggiate. Qui l’associazione va intesa non tanto (o non solo) come formula giuridica quanto come forma di “sociazione”, ovvero l’interazione stabile che col passare del tempo si instaura fra persone che allacciano legami di reciprocità (Simmel, 2018) e per questo si identificano in un gruppo. Nei casi considerati in questo scritto la spinta associativa non viene veicolata esclusivamente da Aps o OdV, molto dipende dalle situazioni (ostacoli e facilitazioni) vissute nella quotidianità degli attivisti, di fronte alle questioni per cui questi hanno deciso di impegnarsi in un collettivo. Così può capitare che un progetto come La Ricostituente venga orchestrato da due cooperative che per anni sono state attive nell’housing sociale e nell’inserimento lavorativo di persone con disagi sociali, sebbene sia incentrato sulla partecipazione giovanile, un tema che di solito vede in prima fila l’associazionismo di promozione sociale e il volontariato organizzato. Allo stesso tempo, le mobilitazioni dei lavoratori autonomi della cultura non hanno trovato una sponda in un sindacato o in un’organizzazione professionale, piuttosto sono state veicolate da sodalizi e associazioni portatori di culture distintive. Dietro alla scelta di una configurazione organizzativa si annidano perciò molteplici fattori e concause, che debbono essere studiati in modo accurato. Nel mondo della solidarietà organizzata i confini sono destinati a sfumare proprio perché si agisce in aree liminari nelle quali bisogni, aspettative e risposte si intrecciano costantemente, assumendo caratteristiche inedite, che per di più evolvono nel corso del tempo. Ad ogni modo, nei casi indagati la membership non supera mai i 200 affiliati, essendo spesso contenuta nella soglia di poche decine di attivisti, il che vuol dire che vi è ampio spazio per condividere esperienze e progetti nella dimensione relazionale di gruppo.
Nei prossimi paragrafi si approfondirà il profilo di tali attori collettivi, a partire dalle pratiche (schemi ricorrenti di azione e risorse comuni) che questi mettono in campo mentre si districano in un groviglio di difficoltà legate all’ambito istituzionale in cui agiscono; tra queste attività ripetute nel tempo, la possibilità di incontrarsi e comprendersi vicendevolmente gioca un ruolo di primo piano, proprio per vincere una condizione di isolamento e marginalità (paragrafo 2). Il passo successivo sarà quello di dipanare le loro culture, ossia l’insieme di rappresentazioni con cui i membri di tali gruppi danno senso a ciò che fanno, sviluppando sentimenti di comunanza e forme di identificazione sociale, tra cui assume rilievo la contaminazione fra sapere esperto e sapere esperienziale (paragrafo 3); in seguito verranno esplorate le strategie con cui questi gruppi si attivano nei rispettivi ambiti di intervento, immettendo nello spazio pubblico le loro istanze, con esiti radicalmente diversi (piccole conquiste, delusioni momentanee, veri e propri fallimenti) e rapporti altalenanti con gli interlocutori istituzionali e altri stakeholder locali (paragrafo 4). Nelle conclusioni si tenterà invece di riannodare i fili emersi nel percorso di analisi, riflettendo sulla capacità trasformativa dei soggetti del Terzo settore.
2. Decodificare le pratiche associative
Le realtà associative esaminate nella ricerca si cimentano in attività concrete cercando di dare risposte ai problemi (piuttosto urgenti) per cui sono nate. Si deve perciò partire dal loro modo di operare nella quotidianità per capire come si configurano in quanto entità collettive. Da questo punto di vista può essere utile guardare alla dimensione delle pratiche che vengono sviluppate all’interno di tali gruppi, una nozione che è entrata nel mainstream delle scienze sociali grazie alla formulazione originale di Pierre Bourdieu (1994). Con tale termine l’intellettuale francese intende gli schemi di riferimento, più o meno ricorrenti, che orientano l’azione di individui e gruppi sociali, consentendo a ciascuno di interagire in diverse situazioni con margini di libertà variabili. In tale costrutto teorico si incrociano almeno quattro livelli di analisi (Doise, 1980): intrasoggettivo, i processi cognitivi con cui gli individui incorporano le norme di comportamento; intersoggettivo, ossia le dinamiche mutevoli con cui si dispiegano i modelli che regolano i comportamenti (habitus); interposizionale, ovvero i rapporti (conflittuali o cooperativi) fra gli attori in un determinato campo[5]; ideologico o culturale, che consiste nelle rappresentazioni sociali predominanti in una determinata comunità. In questo lavoro di ricerca ci si concentrerà soprattutto sulle ultime tre dimensioni concettuali, seguendo l’ipotesi di lavoro che le pratiche associative siano radicate nel campo da cui emergono, ovvero che possano essere comprese in un gioco di rispecchiamento con l’ambito istituzionale in cui prendono corpo.
Il primo spazio d’azione considerato in questo paragrafo viene presidiato dalle associazioni dei freelance che lavorano nel settore della cultura. Questi lavoratori autonomi, privi di tutele[6], svolgono un’attività apparentemente creativa in qualità di artisti, traduttori, editor, grafici, tecnici dello spettacolo, operatori dei beni culturali; ma in realtà sono costretti troppo spesso ad accettare paghe basse e il sovraccarico lavorativo; ciò è dovuto principalmente al fatto di essere degli outsider rispetto alle aziende da cui vengono ingaggiati, che fissano arbitrariamente tariffe orarie e serrate tabelle di marcia di consegna degli elaborati, attraverso una negoziazione individualizzata, in cui il lavoratore è normalmente la parte debole del rapporto contrattuale, non potendo fare affidamento su reti di protezione e su un corpus consolidato di diritti. Per cercare di superare queste condizioni assai penalizzanti i freelance della cultura condividono un’esperienza informale di mutualismo, fuori dai circuiti sindacali e dalle organizzazioni professionali. Mattia Cavani, co-fondatore di Redacta, un collettivo informale di partite iva e collaboratori parasubordinati attivi nell’editoria libraria, conosce bene le asperità di occupazioni che fanno largo ricorso al cottimo: “È un lavoro dove è quasi impossibile definire la variabile tempo […] il cottimo è la realtà dominante, i compensi si abbassano e si richiede grande flessibilità sulle mansioni, soprattutto ai più giovani”. Per portare allo scoperto la fragilità di questi prestatori d’opera nei cicli di produzione editoriale (dalla correzione intelligente di bozze, all’editing di manoscritti di saggistica e narrativa, al ghost writing) Cavani e i suoi colleghi hanno organizzato nel 2019 un’inchiesta, raccogliendo opinioni e informazioni sul vissuto di 300 lavoratori occupati in regime di outsourcing nelle redazioni delle case editrici. Il sondaggio è servito a creare consapevolezza su una condizione lavorativa poco conosciuta e a cementare un sodalizio di circa 20-30 attivisti che si incontrano periodicamente (più o meno una volta al mese) a Milano, Bologna e Firenze per pianificare le loro iniziative. Dal loro impegno è nata una strategia multiforme e pragmatica che si propone di far uscire questi lavoratori dal cono d’ombra in cui sono confinati; innanzitutto, si riuniscono e scambiano punti di vista sulle proprie biografie frammentate e solitarie, cercando di individuare forme di resistenza comuni; la dimensione della socialità è fondamentale, per coltivare legami solidali, ma anche per dare un senso alla propria esperienza lavorativa; il gruppo pubblica, inoltre, articoli in rete e in riviste scientifiche, per sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi che questi lavoratori vivono sulla propria pelle. L’attivismo di Redacta sembra indirizzarsi più che altro verso la sfera simbolica, mirando a sovvertire la narrazione vagamente apologetica sulla “classe creativa” (Florida, 2003): non tutti gli “analisti dei simboli” (Reich, 1991) compiono un’ascesa meritocratica facendo carriera nelle piattaforme del capitalismo digitale, molti di loro rimangono ai margini dei processi di accumulazione di ricchezza e reputazione, sopraffatti da logiche vagamente vessatorie che conducono all’impoverimento dei “ceti medi riflessivi”[7]. Le persone che sono confluite in Redacta hanno imparato a proprie spese cosa voglia dire intraprendere una libera professione nel lavoro creativo, restando escluse da diritti fondamentali, a cominciare dall’equo compenso per il servizio prestato ai committenti. Il gruppo partecipa molto spesso a seminari e festival culturali laddove si discute sui destini dell’editoria, per perorare la causa delle partite iva e dei collaboratori esterni, che hanno pochi appigli per interporsi alla controparte datoriale, essendo formalmente dei liberi professionisti. La battaglia per i diritti di queste persone passa certamente per la promozione di un dibattito pubblico permanente con case editrici, università ed altre realtà istituzionali per chiedere nuove misure di welfare per lavoratori che ne sono in massima parte sprovvisti. Tuttavia, il gruppo non si ferma alle lotte simboliche, essendo piuttosto attivo nella costruzione di strumenti pratici di cui possano avvantaggiarsi gli associati, tra cui risaltano per importanza la compilazione di un mansionario delle prestazioni svolte e la definizione di paghe orarie minime, oltre all’implementazione di un’App (Redalgoritmo), che i singoli freelance possono usare per calcolare preventivi adeguatamente remunerati da sottoporre ai committenti, evitando così di cadere nella spirale del lavoro sottocosto. In Redacta si possono scorgere alcuni tratti delle comunità di pratiche professionali (Wenger, 2006): attraverso l’aiuto reciproco e la partecipazione volontaria i freelance editoriali hanno maturato un know how specifico sui temi connessi alla loro condizione professionale, generando apprendimento collettivo; ciò ha consentito di creare un repertorio di risorse condivise che possono rafforzare ulteriormente i legami associativi.
Questo modo di operare è rintracciabile per certi versi nelle altre associazioni dei lavoratori della cultura, sulle quali ci si può soffermare solo brevemente per motivi di spazio. Tramiti (Traduttrici e traduttori multimediali italiani) trae origine da una chat nella quale alcuni traduttori hanno cominciato a scambiare informazioni sulle condizioni di lavoro capestro imposte dall’agenzia per cui curavano la traduzione di serie e spettacoli di intrattenimento trasmessi in streaming. Da quella cerchia di tecnici che si sono opposti alla malversazione (circa 20) si è formato un nucleo più ristretto di militanti che sono anch’essi entrati a far parte di Acta, costituendo una sezione tematica in seno all’associazione dei freelance. Anche per i traduttori la possibilità di socializzare è stata un fattore di aggregazione, perché tra colleghi si può sviluppare fiducia, mutua comprensione e solidarietà, volendo fare qualcosa per tutelare una categoria di professionisti che gode di scarsa visibilità sociale. Tra le istanze più urgenti vi è la richiesta di riconoscimento dei credit accumulati nella traduzione dei contenuti delle piattaforme di intrattenimento. Appare per molti versi più strutturato il percorso compiuto dalla ASM - Associazione degli artisti di strada (musicisti, attori, giocolieri, acrobati e comici), che da oltre un decennio esiste sulla piazza di Milano (2013). Dopo aver promosso e ottenuto dalla giunta guidata dal Sindaco Pisapia nel 2012 un regolamento sulle postazioni in cui esibirsi, oggi l’Associazione sembra entrata in una fase di consolidamento delle proprie attività, nella quale si chiede alla membership il rispetto di regole (in primis, il divieto di fare spettacoli abusivi nella città lombarda), per non vanificare la reputazione acquisita nel rapporto di collaborazione stabilito con l’amministrazione comunale. Responsabilità in cambio di riconoscimento, questa sembra la priorità odierna di ASM, per non perdere gli spazi pubblici conquistati faticosamente da un manipolo di artisti indipendenti che hanno scelto la via legalitaria. Per quanto si sia costituita formalmente nel 2019, anche l’Associazione “Mi riconosci?” ha alle spalle un decennio di militanza civile per legittimare le istanze dei professionisti dei beni culturali, attraverso attività editoriali e proposte volte ad allargare il perimetro dei diritti per chi si occupa a vario titolo di cultura nel settore pubblico (ma anche in quello privato). Il 6 ottobre del 2018 il movimento ha portato in piazza circa duemila persone. In seguito, l’Associazione si è trasformata in una Aps, realizzando studi e avanzando misure di policy con l’apporto di 70 associati, suddivisi in dieci gruppi territoriali. Un esempio di questa attività di advocacy è stata la presentazione in Parlamento nel 2017 di un Patto per il lavoro culturale, per evitare che nella privatizzazione dei servizi di gestione di siti di interesse culturale vengano demansionate figure quali i mediatori culturali o gli educatori museali. A ben vedere, nelle istanze promosse dai gruppi dei freelance della cultura si possono intravedere diverse analogie con le culture e le prassi sviluppate tradizionalmente dal movimento della cooperazione di produzione e lavoro, le quali si prefiggono di migliorare le condizioni di vita dei lavoratori e di rendere più equi e democratici i processi decisionali in un vasto arco di attività di servizio. I lavoratori autonomi di Redacta, Tramiti, ASM e Mi riconosci? non sembrano tuttavia intenzionati a costituire un’impresa cooperativa, almeno per ora. Il loro impegno si canalizza piuttosto verso una forma spontanea di organizzazione mutualistica per difendersi dalla precarizzazione della loro professione.
Anche le associazioni attive nel settore scolastico si rendono artefici di pratiche tipiche, nel tentativo di innescare dei cambiamenti nei contesti in cui si manifesta il loro impegno. Contribuire alla crescita di una comunità educante non è mai facile, specie quando si ha a che fare con la povertà educativa o con bisogni speciali che insorgono tra bambini e ragazzi. Le istituzioni scolastiche solo di rado si lasciano contaminare virtuosamente dagli apporti esterni della società civile, soprattutto se le associazioni si propongono di rivisitare la didattica convenzionale. I Maestri di Strada (MdS) hanno cominciato la loro avventura sul finire degli anni Novanta, quando alcuni educatori, attraverso un progetto finanziato con i fondi della legge 285/1997, hanno avviato le prime scuole popolari nei quartieri spagnoli di Napoli, per arginare il fenomeno degli abbandoni scolastici, scegliendo i docenti non dalle liste dei supplenti degli uffici territoriali del Provveditorato, quanto piuttosto in base alla loro capacità di instradare gli “adolescenti difficili” verso percorsi di studio e riscatto sociale. Oggi, a distanza di venticinque anni, questa sfida si rinnova nell’area orientale del capoluogo campano, a Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio, quartieri operai deindustrializzati, dove numerose aziende importanti (MecFond, Ansaldo, Ergom, ecc.), hanno chiuso i propri stabilimenti nella lunga crisi dello scorso decennio. Non è facile crescere in un luogo impoverito e alquanto disgregato (Salmieri, 2018), laddove una quota significativa di bambini e ragazzi vengono segnalati ai servizi sociali, vivendo in famiglie vulnerabili e problematiche. Col trascorrere degli anni, i MdS (circa 30 fra educatori, psicologi, esperti di didattica laboratoriale, sociologi, pedagogisti, assistenti sociali) hanno sperimentato un’ampia gamma di metodi per intervenire dentro e fuori le aule scolastiche: laboratori nelle scuole elementari e medie per stimolare la creatività e l’autoconsapevolezza dei bambini e degli adolescenti in classe, percorsi di arte-educazione realizzati nel Centro Polifunzionale di Ponticelli con i minori “difficili”, gruppi di ascolto dei genitori e degli insegnanti all’interno delle scuole, incontri multivisione (riunioni periodiche in cui i membri dell’Associazione dialogano sull’andamento del lavoro educativo). Gli esiti di questa lotta contro la dispersione scolastica non sono sempre positivi, ogni percorso educativo intrapreso con i minori può arrestarsi bruscamente, principalmente perché i genitori decidono che il figlio debba andare a lavorare (non di rado in nero) prima di prendere un diploma superiore di qualche genere; allo stesso tempo, non è detto che le relazioni con le scuole dove gli MdS sono presenti siano fluide o collaborative, ma l’Associazione prosegue nella sua azione pervicace sul territorio per strappare un numero importante di ragazzi alla strada[8]. Nel 2009, quando i fondi della Legge 285/2017 si sono esauriti, Cesare Moreno[9] e gli altri membri di questo gruppo di tenaci educatori hanno dato prova di essere resilienti, trovando una Fondazione di Verona disposta a sostenerli nel loro complesso mestiere pedagogico svolto nelle periferie della città. Da quel momento si sono dedicati anche all’attività di progettazione sociale, per dare maggiore continuità alle attività intraprese.
La Ricostituente nasce durante la pandemia per volontà di Francesca Paini, cooperatrice sociale che in quel frangente concepisce l’idea di dare seriamente voce agli studenti delle superiori (e ai loro coetanei che vivono in comunità terapeutiche e di accoglienza) sul futuro del nostro Paese. Il punto qualificante dell’iniziativa è spingere le nuove generazioni a riscrivere gli articoli della Costituzione, facendole ragionare su uno scenario di medio-lungo periodo (il 2050), come del resto avevano fatto i componenti della costituente che tra il 1946 ed il 1947 riuscirono nel non facile compito di definire principi e prassi fondamentali nel dettato costituzionale, raggiungendo una sintesi avanzata tra posizioni ideologiche contrastanti, tale da proiettare per decenni la nostra nazione verso la democrazia e la modernità. Non a caso l’operazione proposta da Paini nasce a Cartosio, paesino di 743 anime in provincia di Alessandria, rifugio preferito di Umberto Terracini, fondatore del PCI e presidente della costituente. Il progetto si basa su due intuizioni fondamentali: da una parte, elaborare un format laboratoriale per stimolare i 17-19enni a riformulare la carta costituzionale, un metodo che combina l’analisi dei megatrends dei future studies[10], nozioni di base di educazione civica e una tecnica di scrittura collettiva, per compendiare il pensiero degli studenti in un testo che li rappresenti tutti[11]; dall’altra, l’organizzazione di un festival nazionale che si tiene ogni anno agli inizi di giugno, nel corso del quale circa duecento giovani vengono chiamati a riflettere sul futuro dell’Italia e della società globale, sempre attraverso la riscrittura di leggi fondamentali o di trattati internazionali. La caratteristica di questo festival è di non prevedere l’intervento di studiosi di fama, influencer o personaggi dello spettacolo, invitati per dispensare ai giovani pillole di saggezza, quanto piuttosto di far esprimere questi ultimi sul futuro che li attende, incoraggiandoli a trovare nei laboratori soluzioni per affrontare la tripla transizione (digitale, ecologica e sociale) in atto nella società contemporanea. Forse è per questo che la reazione del mondo degli adulti a questo festival, sia di quanti occupano ruoli di rilievo nel settore pubblico che negli ETS, è stata piuttosto tiepida, al di là di alcune eccezioni, come ha sottolineato la stessa Paini, non andando oltre un sostegno generico alla manifestazione. Per questo, la piccola squadra che gestisce la rete (quattro persone, compresa la Paini, che operano nelle cooperative Tikvà di Como e Impressioni Grafiche di Aqui Terme) ricomincia da zero ogni anno per reperire il budget (circa 75mila euro) necessario a ospitare i giovani e organizzare in loco le attività del “controfestival”. Nonostante le ristrettezze economiche l’incontro è giunto alla quarta edizione[12] e dovrebbe proseguire su basi itineranti nei prossimi anni, con una larga partecipazione soprattutto dei minorenni che vivono nelle comunità residenziali. Andando a visitare il sito de la Ricostituente si possono passare in rassegna gli articoli della costituzione riscritti dai ragazzi: fa un certo effetto vedere esempi di giovani che si sono espressi su questioni fondamentali quali la salute, il lavoro, la libertà d’espressione, la discriminazione, la cittadinanza, l’ambiente. Una piattaforma di valori e spinte ideali che è raro vedere in un Paese come il nostro, da cui i ventenni e i trentenni partono di frequente, ingrossando e perpetuando la fuga dei cervelli, senza avere l’occasione di dire la loro sulla nazione dove sono nati e cresciuti. Per questo Paini e gli altri attivisti insistono sulla costruzione di spazi partecipativi dove gli studenti possano esprimersi sulla società in cui vorrebbero vivere negli anni a venire.
L’ultima realtà associativa che agisce sul fronte scolastico è localizzata a Corcolle, quartiere periferico del VI Municipio di Roma. Si tratta di un centro abitato dove vivono circa 6.600 abitanti, in case edificate per lo più in modo abusivo, in assenza di infrastrutture urbanistiche adeguate, per cui si creano spesso allagamenti e smottamenti quando sopraggiungono precipitazioni. Gli attivisti di “Un mondo nel cuore” hanno fatto quasi tutti parte del comitato di quartiere, ente che dà voce alle istanze dei residenti. Danilo Proietti e altri sei volontari erano abituati ad affrontare in quel consesso questioni legate alla riqualificazione urbanistica del luogo in cui risiedono. Nel 2014 però la routine dell’insediamento viene spezzata da un episodio di cronaca che provoca un certo clamore; la Prefettura decide di spostare quaranta rifugiati in uno stabile di Corcolle provocando la reazione scomposta di alcuni manifestanti del posto. La protesta non passa inosservata e sui giornali il quartiere si ritrova annoverato fra le periferie più roventi della capitale, dove covano pulsioni xenofobe o razziste. In quel frangente Proietti e coloro che lo avevano affiancato nel comitato di quartiere si rendono conto che non basta l’impegno nelle istituzioni comunali; ci vuole un quid in più per lenire il senso di abbandono avvertito da chi vive in quella realtà periferica. Nella borgata romana mancano soprattutto servizi essenziali, oltre alle attività solidali e di interesse culturale. La Aps viene creata per sopperire a tale carenza. I volontari di Corcolle iniziano a organizzare cene benefiche e cineforum. Poi, con il concorso del centro anziani, del gruppo archeologico e della parrocchia, il progetto si espande, alimentato da rassegne teatrali e presentazioni di libri. L’Associazione diventa sempre più visibile sul territorio e la preside dell’Istituto scolastico San Vittorino (elementari e medie) coinvolge il gruppo guidato da Proietti nella progettazione sul bando comunale “Scuole Aperte” (2022-2023). Danilo, assieme alla cerchia ristretta dei soci fondatori, propone di realizzare alcune attività extracurriculari quali l’aiuto compiti nel doposcuola, corsi di scrittura creativa, teatro e di musicoterapia, un percorso di alfabetizzazione alle materie STEM, un servizio di supporto alla genitorialità. Il progetto viene approvato per due annualità consecutive e le iniziative dell’Associazione si ampliano tra il 2023 e il 2024. I soci così crescono fino al numero ragguardevole di 46, potendo beneficiare di prestazioni di utilità sociale a titolo gratuito o comunque a prezzi popolari (solo quando è necessario coprire costi aggiuntivi[13]). I servizi e i corsi vengono erogati da una struttura organizzativa agile, che fa largo appello al volontariato, ad eccezione di qualche collaboratore occasionale. La gestione ordinaria delle attività è in capo ai sette soci fondatori dell’Associazione, che si coordinano attraverso call serali. Il gruppo dirigente della Aps si confronta spesso manifestando differenti punti di vista sul valore, l’esito e l’organizzazione delle iniziative intraprese; ciascuno dei militanti più attivi ha la libertà di proporre una nuova iniziativa, sapendo che verrà spalleggiato da tutti gli altri, potrà dedicarsi ad essa a tempo pieno, prendendosi una pausa quando avrà esaurito le proprie energie. Le risorse partecipative vengono, quindi, dosate accuratamente, per evitare il burnout fra i volontari più coinvolti nell’Associazione, così come vi è un esame costante di quel che viene realizzato per capire quale impatto abbia avuto sui residenti. I militanti di “Un mondo nel cuore” non usano metodologie e tecniche sofisticate di monitoraggio e valutazione delle azioni progettuali, ma riesaminano incessantemente il proprio operato, correggendo il tiro se necessario. Non c’è bisogno di codificare queste pratiche riflessive in un piccolo gruppo informale, è sufficiente esercitarsi nell’arte dell’ascolto attivo per rispondere ai bisogni di una comunità e convergere su obiettivi comuni (Sclavi, 2003), per il resto ci si affida alla forza dei legami prosociali.
La scuola e il mercato delle nuove professioni culturali sono arene istituzionali complesse, ciascuna con una propria struttura di opportunità (Wahlström, Peterson, 2006) che condiziona le forme di auto-organizzazione della società civile, come si avrà modo di vedere più avanti. I soggetti associativi analizzati in questo paragrafo cercano di adattarsi ai contesti in cui agiscono, sviluppando pratiche peculiari: schemi ricorrenti di partecipazione, artefatti simbolici, piattaforme per l’azione e quant’altro. Resta da capire come queste risorse collettive possano diventare fonte di identificazione e leve di cambiamento.
3. Le culture di gruppo
Il concetto di cultura di gruppo è una chiave analitica cardine nelle scienze sociali nella misura in cui consente di mettere in luce le forme non materiali che danno struttura ad un gruppo, generando identità tra gli appartenenti e orientando l’azione collettiva (Fine, 2012). Riprendendo la teorizzazione di Goffman sull’ordine dell’interazione (1998), Fine (2014) sottolinea che la cultura di un gruppo è l’esito della stabilizzazione di pratiche attraverso le relazioni intersoggettive all’interno del gruppo stesso agendo come cerniera connettiva tra individuo e società. Analizzare la cultura di gruppo di organizzazioni, formali e informali, che operano nel campo della salute mentale, del lavoro e della scuola consente pertanto di osservare come le pratiche analizzate nel paragrafo precedente, assumano una forma coerente di significato con cui il gruppo interpreta la struttura istituzionale in cui è immerso e attraverso la quale non solo incidere nella produzione ed erogazione dei servizi, ma anche nella trasformazione della realtà sociale e dei significati che la società attribuisce agli oggetti politici affrontati in ogni campo istituzionale.
Un primo aspetto che emerge dalla lettura trasversale dei casi riguarda il concetto di contaminazione e ibridazione con cui i gruppi mobilitano risorse, strategie e saperi. Nell’ambito della salute mentale le pratiche assumono la forma culturale di una comunità dialogica in cui l’incontro tra sapere esperto e sapere esperienziale ridefinisce i rapporti di subalternità tra paziente e istituzione. La commistione tra le due matrici si inserisce nel solco della tradizione basagliana in cui l’apertura dei manicomi al territorio rompe le catene discorsive dell’istituzione totale accogliendo la voce dei pazienti nella produzione del sapere. Il “Club SPDC No Restraint”, a cui aderiscono tanto i professionisti della salute mentale quanto familiari e cittadini interessati, si pone l’obiettivo di superare il ricorso alla contenzione meccanica e farmacologica nelle pratiche terapeutiche dei pazienti all’interno dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura del Servizio Sanitario Nazionale, adottando pratiche terapeutiche orientate alla recovery, cioè al recupero di una maggiore qualità della vita attraverso interventi non coercitivi in cui la salute mentale dei pazienti non viene relegata a semplice fatto bio-chimico da risolvere con il ricorso all’uso dei farmaci, ma viene affrontata ad ampio spettro nella sua dimensione socio-relazionale dove risiedono risorse da attivare. In particolare, l’SPDC di Trento coinvolge l’utenza nelle pratiche di servizio prevedendo la figura dell’ESP (esperto in supporto tra pari), crea momenti di condivisione assembleari tra il personale infermieristico e sanitario, e prevede modelli di co-gestione condivisa e relazionale degli interventi nei confronti dei pazienti, come gli interventi I.R.O.N (Interventi Relazionali prolungati ad Orientamento No Restraint), con cui il composito team, attraverso la relazione sociale e la fiducia che questa genera, interviene abbracciando la multidimensionalità del bisogno espresso e, quindi, abbassando il livello di conflitto. Queste modalità di de-verticalizzazione del servizio generano un terreno di incontro e di abbassamento dei livelli più conflittuali tra il personale medico e la persona che deve essere assistita riducendone la distanza e favorendo il processo di cura, che si affianca agli interventi evidence based dell’approccio farmacologico. Il tempo dedicato dal personale all’incontro con la soggettività del paziente, azione non assoggettabile ad una logica di causa-effetto e di valutazione sperimentale nel contenimento dei sintomi, diventa “tempo di cura, fare cose insieme al paziente significa stare con lui e instaurare un legame terapeutico” (Maurizio Davì, Club SPDC No Restraint di Trento). Tuttavia, come sottolinea Claudio Agostini, Direttore U.O Psichiatria distretto Nord, la riduzione dei Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) che il reparto registra “non è dovuta a chissà quale mia spettacolare prodigiosa capacità, ma a una tenace volontà di spogliare la definizione di disagio dalle attribuzioni psichiatriche che portano con sé un disvalore molto importante”. Il Direttore sottolinea come è l’abbandono delle categorie definitorie della realtà e del disagio vissuto dalla persona a favorire il riconoscimento del bisogno di aiuto e supporto da parte del paziente. La spoliazione psichiatrica della salute mentale sfida, di conseguenza, i presupposti epistemologici della disciplina stessa, interpellando i processi che intercorrono tra il sapere incardinato nel campo psichiatrico e il potere che esercita (Foucault, 2013). L’orizzontalità delle relazioni, infatti, oltre a svolgere una funzione terapeutica, genera spazi di produzione collettiva di conoscenza, in cui possono emergere fratture, dissonanze, conflitti o visioni alternative tra chi riceve il servizio e chi lo implementa, svolgendo così anche una funzione politica. La de-istituzionalizzazione del sapere produce trasformazione sociale nel momento in cui questa comporta forme di riconoscimento “a un mondo di vissuto e malessere che altrimenti verrebbe ignorato dalle istituzioni”, come nota Davide Salvarani, di Arca, che si occupa di disagio psicologico giovanile con forme di supporto tra pari.
L’associazione “Sentire le voci”, organizzazione che sostiene persone con allucinazioni uditive, esprime chiaramente l’orientamento che segna una cesura tra intervento terapeutico riabilitativo e controllo sociale, tra paradigma della custodia e della cura: “noi siamo dei professionisti sanitari, non siamo le forze dell’ordine […]. Si tratta di mettersi nella forma mentale che non sei padrone della scienza […] riconoscere che le persone sono artefici del loro percorso di salute e quindi vale la pena ogni tanto mettere da parte le nostre rigidità scientifiche, i nostri manualetti o perlomeno confrontarli con i manualetti dell’esperienza di vita degli altri […]” (Raffaele Galluccio, Sentire le voci).
Considerare il “manualetto dell’esperienza di vita degli altri”, significa porsi in una dinamica di riconoscimento di esperienze marginalizzate di cittadinanza ed è ciò che caratterizza anche la cultura dei gruppi oggetto di questo studio nel campo del lavoro, la cui matrice comune si fonda sul riconoscimento della dignità professionale in opposizione ai processi di precarizzazione, privatizzazione e deregolamentazione del mercato del lavoro e dei settori economici. In particolare, i lavoratori della cultura, a partire dalla propria esperienza materiale di produttori di cultura, portano al centro del discorso e della loro rivendicazione l’idea e la necessità di un sistema culturale nazionale pubblico in quanto “i beni culturali sono dei servizi essenziali” (Rosanna Carrieri, Mi riconosci?). I gruppi studiati, che riuniscono i lavoratori in campo artistico-culturale, diventano degli spazi di coesione e di contrasto alla frammentazione e all’indebolimento dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. In questi gruppi è proprio questo a svolgere la funzione di bonding interno attraverso la costruzione di valori condivisi e pratiche di riconoscimento anche di tipo informale che non riducono l’appartenenza ad un mero tesseramento, ma saldano l’intreccio tra dimensione culturale e dimensione politica del lavoro. Il portato soggettivo dell’esperienza di vita di chi partecipa viene esteso e sviluppato dentro un quadro di significato politico-teorico più ampio, ad esempio, allargando lo sguardo a tutti i lavoratori della filiera culturale a prescindere dalle professionalità come nel caso di “Mi riconosci?”, oppure approfondendo i meccanismi specifici settoriali come nel caso di Acta che ha creato dei gruppi interni di lavoro (Tramiti e Redacta). Ciò che emerge come elemento trasversale, tuttavia, è la rilevanza attribuita alle relazioni sociali come pratica politica intorno alla quale costruire una cultura del lavoro condivisa. Il riconoscimento di una condizione comune attraverso “rapporti diretti di fiducia in cui ci si guarda in faccia” (Mattia Cavani, Redacta) diventano strumenti operativi a sostegno della contrattazione collettiva di lavoratori precari, spesso isolati gli uni dagli altri in forza di inquadramenti contrattuali come la partita IVA o le collaborazioni professionali. La creazione di spazi simbolici che alimentano relazioni intersoggettive in campi di lavoro segnati dalla frammentazione della parte lavoratrice ha dei riflessi anche sul piano del benessere individuale in cui si ridefiniscono le condizioni simboliche dell’agire lavorativo. Lo stile associativo informale, come “andare a parlare con quattro amici al bar e non in un ufficio polveroso” (Sofia Scartezzini, Redacta) riduce le distanze tra partecipante e gruppo e le asimmetrie tra associato e istituzione, creando l’innesco per cui la partecipazione possa strutturarsi nel tempo, diventando assidua e costante.
Le identità collettive che i gruppi cercano di ricostruire fanno leva sul valore culturale e collettivo del lavoro che si offre, come racconta esplicitamente Dario Buccino, compositore, artista di strada e Vicepresidente dell’organizzazione ASM: “Credo moltissimo nell’arte di strada, anche proprio come strumento di crescita personale e come strumento di condivisione culturale con la città perché, indipendentemente da ciò che fai, anche se canti una cosiddetta canzonetta in realtà sei talmente nudo di fronte al pubblico che hai la sensazione di una comunione, questa comunione io trovo che sia socialmente preziosissima, soprattutto in un momento come quello attuale in cui la cultura e la società dello spettacolo sono talmente pervasive, ormai siamo abituati a vivere in una specie di social network a cielo aperto e, quindi, penso che la condivisione sia il mattone principale di qualunque costruzione politica sana”. L’intervistato descrive un’attività di lavoro svolta come pratica artistica che cerca di sottrarsi a una logica di consumo della merce-cultura e che trova il suo valore nella costruzione di relazioni, legami sociali e senso di comunità, sottolineando pertanto il potere trasformativo del lavoro artistico-culturale.
La capacità generativa di apertura e condivisione che caratterizzano i gruppi legati al mondo del lavoro qualificano anche le esperienze che riguardano il mondo della scuola, in ottica integrativa dell’istituzione educativa pubblica. Progetti educativi, laboratori, eventi, corsi di formazione, doposcuola e altre attività inclusive sono interventi che producono beni relazionali (Donati, Solci, 2011) in cui è il territorio e il tessuto sociale che lo anima a prendersi cura della comunità che lo abita. Le pratiche educative relazionali introdotte da MdS sono inquadrate in una critica ai limiti dell’offerta pubblica, che Cesare Moreno, riconduce alle modalità standardizzate poco sensibili alla valorizzazione delle unicità delle caratteristiche degli studenti e degli alunni e a un sistema di reclutamento degli insegnanti incentrato su quello che definisce un “egualitarismo burocratico di origine politico-sindacale”, che non tiene conto degli aspetti soggettivi del lavoro di insegnamento attraverso metodologie, sensibilità e pratiche d’aula personalizzate a seconda delle esigenze degli studenti. L’autonomia dell’Associazione nel reclutare gli insegnanti, selezionando quindi profili confacenti alle istanze e alle problematiche di un “quartiere difficile” (ibidem), rappresenta un tassello delle opportunità educative territoriali che si integrano con l’istruzione scolastica pubblica, quasi come un fattore abilitante per la funzione pubblica delle scuole: “Siamo un’associazione di professionisti che progettano e sperimentano azioni educative in modo tale che le scuole siano messe in grado di assolvere alla loro funzione nei confronti delle nuove generazioni” (Cesare Moreno, MdS).
È interessante notare come un’organizzazione del Terzo settore possa rafforzare il carattere inclusivo di un’istituzione pubblica, in questo caso quella scolastica, intervenendo su ciò che l’istituzione esclude, sui bisogni a cui non trova risposta o sui processi di marginalizzazione che essa stessa produce. In definitiva, la comunità educante risiede nell’idea di un’educazione condivisa basata sui valori della corresponsabilità e della prossimità in cui le organizzazioni della società civile funzionano da cerniera tra i bisogni di chi vive il territorio e le istituzioni arricchendone l’offerta, dando vita a processi di apprendimento come esperienza collettiva di partecipazione alla vita pubblica, come emerge dal caso de La Ricostituente che mette al centro la partecipazione giovanile attraverso l’esperienza diretta da parte dei ragazzi e delle ragazze del processo costituente, sviluppando le capacità riflessive e creative nell’immaginazione di un futuro da costruire collettivamente: “I costituenti hanno immaginato un mondo che non c’era e poi hanno scritto un sistema di regole che avvicinava il mondo che loro desideravano. Ai ragazzi proponiamo di seguire la stessa strada: immaginare sui temi che li interessano un mondo che non c’è […] quindi, individuare diversi scenari sui cambiamenti futuri e poi scrivere collettivamente un articolo della Costituzione che avvicina un mondo da loro ritenuto preferibile” (Francesca Paini, La Ricostituente).
Il valore dell’aggregazione insito nei processi democratici, come dispositivo di trasformazione sociale, è quanto caratterizza l’esperienza di “Un mondo nel Cuore”. Lo spirito di fondo del gruppo che ha portato a fondare “qualcosa di cui non si era mai sentito parlare” nel quartiere, come dice Danilo Proietti, risiede nel desiderio di emancipare l’immaginario comune legato al quartiere costruito intorno ad un’idea di intolleranza e degrado attraverso pratiche di attivismo dal basso “nell’ultimo quartiere di Roma” (ibidem). I legami inclusivi generati tra gli abitanti e tra il quartiere marginalizzato e deprivato di servizi e la città rompono l’isolamento territoriale in cui versa Corcolle, ridefinendo e ampliando i confini della spazialità del territorio da “quartiere” a “mondo”.
4. Forme e significati delle azioni collettive
Una volta definite le pratiche e individuate le culture di gruppo, in questo paragrafo si metteranno in luce le azioni collettive che le organizzazioni portano avanti. L’azione collettiva come concetto euristico delle scienze sociali individua quelle attività più o meno conflittuali orientate alla produzione di beni pubblici e alla redistribuzione delle risorse (Olson, 2013), in cui è centrale l’osservazione del rapporto tra l’agire delle formazioni sociali, dove l’individuo cede parte della propria autonomia, e le forme del potere (Moini, 2013). Nell’azione collettiva si definiscono le identità collettive del gruppo attraverso il processo relazionale con cui gli attori conferiscono significato all’azione, individuano i mezzi e gli strumenti con cui agire e interagiscono con il campo di riferimento (Melucci, 2013). Le realtà associative studiate, attive dentro un sistema di rete territorializzata dei servizi e di produzione di politiche pubbliche, esito del processo storico di sussidiarietà verticale e orizzontale, mettono in campo azioni collettive all’interno di sistemi locali di governance dove le relazioni tra attore pubblico, privato e società civile prendono forma in reti territoriali.
Nell’ambito dei servizi di salute mentale, l’azione è rivolta alla costruzione di un sistema integrato dei servizi che chiama in causa i servizi socio-sanitari di competenza territoriale, i reparti ospedalieri, l’utenza e le famiglie: “Il No Restraint non è una cultura del reparto, è una cultura del servizio, lì capisci che le risorse di conseguenza si devono integrare” (Maurizio Davì, responsabile per le professioni sanitarie del Club SPDC No Restraint dell’Ospedale Santa Chiara di Trento). La presa in carico coordinata e collettiva da parte degli enti preposti richiede spazi di coordinamento tra diverse figure professionali e istituzioni dove il concetto di cura diventa un bene collettivo co-prodotto dalle forze in campo. L’azione collettiva dell’SPDC di Trento, dunque, prevede, da un lato, il coinvolgimento dell’utenza nella programmazione ed erogazione dei servizi, dall’altro, sembra orientarsi verso una forma rinnovata di governance che superi la logica dell’esternalizzazione tramite bando o delle partnership, strumenti tradizionali della sussidiarietà orizzontale che appaltano funzioni pubbliche, per dirigersi, al contrario, verso una partecipazione che abbia come oggetto la definizione stessa del servizio pubblico e delle sue forme di regolazione, come racconta Wilma Di Napoli, dirigente medico dell’unità psichiatria di Trento, nei rapporti con il Comune rispetto ai quali sottolinea come si passi da un’interlocuzione relativa alla gestione dei casi ad una finalizzata all’ideazione condivisa del servizio: “Adesso è come se volessimo co-progettare, almeno iniziare a ragionare”. L’attenzione è rivolta, dunque, alla dimensione sostanziale della partecipazione anche nei confronti dell’attivazione e del coinvolgimento dell’utenza, con l’obiettivo di superare l’atteggiamento “passivo” e “paternalista” di prassi che relegano le pratiche relazionali ad una sorta di intrattenimento sociale del paziente: “[…] - ci siamo trovati in gruppi in cui gli utenti e i familiari ce ne dicevano anche di cotte e di crude, volendo davvero comunicare in questa dialettica [...] penso che abbiamo scelto di scendere dal piedistallo dell’autoritarismo, l’autorevolezza invece ce l’abbiamo perché se in questa dialettica sentono comunque che il tecnico è una persona affidabile, che ha una competenza che però non pretende di sapere tutto e di avere il diritto di vita e di morte sulla persona” (Wilma Di Napoli).
Il “Club SPDC No Restraint” ha la forza di mettere in discussione il sapere bio-medico degli stessi partecipanti al gruppo, anche aprendo il campo della salute mentale ad una molteplicità di figure in un’ottica di compenetrazione sistemica tra l’associazione e il servizio, attraverso le pratiche di lavoro attuate dai professionisti presenti nel reparto: “Le associazioni premono affinché l’istituzione pubblica cambi, perché in realtà democraticamente l’istituzione pubblica è del popolo, però poi diventa di pochi […] è un indicatore di qualità il fatto che dentro l’istituzione lavorino professionisti assunti che portano un contributo attraverso il volontariato, l’associazionismo, l’esperienza degli ESP […] l’associazionismo e le persone che gravitano intorno alla psichiatria sono fondamentali per evitare di tornare all’istituzione totale (Francesca Sozzi, psichiatra, Dirigente medico)”.
Allo stesso tempo si ravvede la necessità di incidere sul discorso pubblico intorno alla salute mentale come processo di trasformazione della cultura collettiva nella sua valenza politica: “Per me è fondamentale che ci sia un movimento di professionisti, ma non solo, che appoggia una scelta di questo tipo perché ha una valenza anche politica, una presa di posizione rispetto a ciò che a nostro parere è legittimo (e non) fare […]” (Claudio Agostini, Direttore U.O Psichiatria Distretto Nord).
Lavorare sulla dimensione relazionale della cura è un’attività onerosa che richiede ingenti risorse all’interno delle pratiche e dei tempi di lavoro del personale medico-infermieristico, e che si scontra contestualmente con uno strutturale definanziamento dei servizi di salute mentale, facendo emergere la complessità del rapporto tra condizioni di lavoro e qualità del servizio: “[...] non puoi fare le nozze con i fichi secchi. Se mi chiedi di fare un lavoro di qualità, richiede relazione, capacità comunicativa anche tempo e personale per farlo. Se in un reparto ho tre persone, come faccio a gestirlo in modalità no restraint? [...] siamo così convinti che sia meglio, magari un ricovero in contenzione? Dura 10 giorni in più. Se andiamo a valutare bene i costi cos’è che è più efficace? [...] forse qui abbiamo ancora passione, in altre realtà siamo talmente stanchi e deprivati […] a volte mi raccontano colleghi che sono da soli, un professionista per un CSM che serve un territorio di 300 mila persone, posso capire che qui ci si senta in una specie di bunker e non a lavorare” (Wilma Di Napoli).
La questione del finanziamento è un aspetto che mobilita anche il settore della scuola dove emerge il rapporto ambiguo tra capacità finanziaria e impegno politico. Nel caso de La Ricostituente, infatti, Francesca Paini mette a tema come le difficoltà nel reperimento dei fondi necessari tra organizzazioni del Terzo settore possa essere dovuta ad una logica di interesse rispetto agli sbocchi reputazionali che il finanziamento di un progetto comporta per l’organizzazione, piuttosto che alla validità e alla rilevanza del progetto stesso: “Ogni anno ripartiamo da zero per trovare i fondi necessari a organizzare il festival con i giovani […]. Se parliamo di sostegno politico, sin dal principio ci siamo rivolti ai big player del Terzo settore per ricevere il loro appoggio […] nessuno ci ha detto di no [...]. Nel 2024, giunti alla quinta edizione del festival nazionale stiamo però ancora lavorando affinché i soci promotori, senza intestarsi il festival, lo sostengano in modo importante, anche economicamente, mettendoci una quota anche minima, ma per usarlo veramente sul piano culturale. Il festival è di chi decide che gli obiettivi de La Ricostituente diventino anche i propri [...]. Questa iniziativa è nata ai bordi del Terzo settore, non è nata esattamente da loro, non è un progetto che nessuno si poteva intestare […]” (Francesca Paini, La Ricostituente).
I rapporti di rete, quindi, sono complessi e si articolano lungo una rinegoziazione nel corso del tempo in cui ad essere implicata è anche la posta in gioco del riconoscimento, non solo dei progetti e del ruolo che svolgono i gruppi nei diversi contesti istituzionali, ma anche rispetto all’identità professionale, come evidenziato da Federico Zaccaria, coordinatore di MdS, che svolge questo incarico di responsabilità in tre scuole della zona orientale di Napoli: “In questa scuola quando entro, vengo riconosciuto come Federico, coordinatore dei MdS, chiunque sa che se vuole sono a disposizione, mi sento integrato nell’Istituto, con il corpo docenti, siamo diventati un punto di riferimento per diverse richieste e proviamo ad accoglierle in prima persona o ad indirizzarle al meglio agli altri enti del territorio” (Federico Zaccaria, MdS).
I rapporti dell’organizzazione con gli istituti scolastici non sono sempre agili. MdS opera complessivamente in 20 scuole a Napoli dove non è infrequente che l’Associazione venga percepita come estranea alla vita quotidiana degli istituti da parte dei dirigenti scolastici e del corpo docente attribuendogli l’etichetta, nonché il compito, del gruppo di educatori che si fa carico dei “ragazzi difficili”. MdS agisce proprio su questa polarizzazione tra un’educazione per i ragazzi che risiedono con agio nelle maglie dell’offerta pubblica e chi necessita, all’opposto, di sostegno e supporto ulteriore e personalizzato rispetto ai propri bisogni di apprendimento e formazione specifici, in un contesto caratterizzato da fragilità sociale e povertà educativa; un’azione che si caratterizza come un processo politico di democratizzazione della società attraverso l’accesso alle risorse educative.
Il settore del lavoro sembra caratterizzato da azioni collettive in aperto contrasto con le forme tradizionali di collettivizzazione degli interessi dei lavoratori nei corpi intermedi. I tre gruppi studiati mettono in campo un’azione collettiva finalizzata ad una maggiore regolazione del settore artistico-culturale, facendo leva su forme di mobilitazione diverse, ma che mirano ad introdurre una dimensione di responsabilità condivisa da parte dei lavoratori autonomi in un mercato altamente frammentato e competitivo. Un primo elemento che emerge è la rilevanza delle forme di auto-organizzazione che porta a processi associativi nati “dal basso”, ritenuti fondamentali dai lavoratori stessi, come sottolinea Silvia Gola, membro di Redacta, con una domanda retorica: “Chi se non noi può trattare il contenuto sindacale del nostro lavoro?”.
La sfiducia quasi cronica nei confronti degli spazi di rappresentanza sindacali è un tratto particolarmente osservabile nel caso di Acta e nei suoi sotto-gruppi, come afferma Giada Riva, membro del Consiglio direttivo di Acta e co-fondatrice di Tramiti, che si pone in aperta critica dei sindacati organizzati intorno al concetto di lavoro subordinato e incapaci di cogliere le istanze del lavoro autonomo tipico delle trasformazioni del lavoro contemporaneo post-fordista: “I sindacati tradizionali mi spaventano un po’, mi sembra di interfacciarmi con persone che non sono dentro al mio lavoro”.
L’associazione Mi riconosci?, invece, nata da un movimento di piazza per la valorizzazione e il riconoscimento delle professioni dei beni culturali all’interno dell’ampia stagione della cosiddetta “Riforma Madia”, agisce come vettore di moltiplicazione delle istanze sindacali dando loro voce e diffusione e indirizzando i lavoratori che si rivolgono al gruppo considerandolo un vero e proprio sindacato. L’associazionismo in questo caso sembra colmare le istanze di rappresentanza sindacale ad una generazione di lavoratori esclusa dalle istanze collettive sui luoghi del lavoro.
Attraverso la socializzazione delle esperienze di precarietà chi partecipa ad Acta condivide informazioni sulle proprie condizioni e sui compensi percepiti facendoli diventare patrimonio collettivo, attraverso la costruzione di strumenti che favoriscono una contrattazione più equa, come il “Redalgoritmo”, che regolano anche il comportamento dei singoli lavoratori al momento dell’ingaggio per una prestazione lavorativa. Questa sorta di mutualismo informativo prova a saldare i rapporti tra i lavoratori creando alleanze: “Si tratta di costruire una rete di fiducia, non solo di informazioni, per cui se io rifiuto un lavoro, lo rifiuti anche tu” (Mattia Cavani, Redacta).
L’azione collettiva dei gruppi che operano nel settore del lavoro si muove sul crinale tra una richiesta di riconoscimento pubblico, tramite processi di regolamentazione settoriale, e allo stesso tempo una rivendicazione della propria autonomia e specificità, in cui l’associazionismo sembra funzionare come mezzo di mediazione tra queste due polarità. Nel caso dei freelance, infatti, il nodo centrale sono le tutele e l’ampliamento dei diritti della forza lavoro precaria e non l’autonomia del lavoro in sé. Così come, per gli artisti dell’associazione ASM nella marginalità dell’arte di strada, nel suo carattere popolare, si riconosce un principio di libertà a cui l’arte non deve rinunciare “l’artista di strada è un marginale che non vuole essere emarginato” (Dario Buccino, ASM).
La conoscenza delle dinamiche specifiche settoriali è ciò che caratterizza anche l’associazione ASM, formalizzata durante il processo di interlocuzione che un gruppo di artisti di strada aveva iniziato con il Comune di Milano, per la stesura di un regolamento per le esibizioni artistiche in città: “La nostra consulenza è stata fondamentale perché un assessore di qualunque tipo è difficile che abbia esperienza di arte di strada. Un assessore alla cultura, anche quello più legato al mondo dello spettacolo e dell’arte può non saper nulla di arte di strada perché è un fenomeno che o lo fai o non lo capisci, non lo vedi in televisione, lo vedi sul marciapiede” (Dario Buccino, ASM). Il sapere esperto dei lavoratori si configura, di conseguenza, come una risorsa politica per mediare con l’istituzione. L’apparente paradosso di una richiesta di maggiori limitazioni nelle performance, come gli orari di esibizione, i tipi di impianto e un sistema di rotazione all’interno di tutto lo spazio urbano sono istanze formulate dagli stessi artisti, in assenza delle quali si verificherebbero comportamenti opportunistici e antidemocratici nella dinamica competitiva dell’esibizione in strada.
5. Osservazioni conclusive
La ricerca ha messo in luce come gli ETS, sebbene siano oggetto di pressione isomorfica e sistemica delle logiche burocratiche e di mercato, possano continuare ad agire con una carica trasformativa verso l’esistente. L’analisi delle dinamiche interne dei soggetti associativi consente di portare allo scoperto pratiche, culture e azioni multiformi, che nascono da tensioni e mediazioni con gli altri attori presenti nelle tre arene istituzionali considerate in questo studio. Le pratiche associative, che si concretizzano in progetti, attività e rituali d’interazione mettono al centro la dimensione relazionale come sfera dove il gruppo dà senso al proprio agire e dove si persegue il bene comune o l’interesse generale.
Dai casi esaminati si evince che l’interazione sociale costituisce uno spazio di esercizio democratico in cui il gruppo diventa mezzo di trasposizione dal personale al politico. Infatti, le interazioni orizzontali (quotidiane) tra i partecipanti funzionano da infrastruttura relazionale attraverso la quale innescare un processo di cambiamento a partire dal riconoscimento reciproco tra gli attivisti: il dialogo tra sapere esperienziale e sapere tecnico, reso possibile nel settore della salute mentale da modalità di azione e coordinamento tra professionisti e utenza stessa nella presa in carico dei bisogni complessi dei pazienti, che si realizza attraverso la strutturazione di veri e propri protocolli di intervento come I.R.O.N. nel caso dell’SPDC di Trento, in cui il bisogno non viene ridotto ad un intervento medico-farmacologico, ma affrontato anche nella sfera socio-relazionale e della qualità della vita dei pazienti; il solidarismo pragmatico che si instaura tra i freelance precari del settore della cultura, di cui è emblematica l’implementazione di una App (“Redalgoritmo”) open source con cui i lavoratori autonomi dell’editoria possono calcolare compensi equi in negoziazioni contrattuali che li vedono alquanto penalizzati; gli originali percorsi educativi attivati dai gruppi che collaborano con le scuole, come i laboratori realizzati dai MdS per ridurre il numero di early leavers nelle periferie di Napoli, o il controfestival itinerante organizzato da La Ricostituente per dare voce ai 17-19enni in un paese che solo di rado favorisce il protagonismo delle nuove generazioni. Risulta piuttosto evidente che i legami associativi non sono solo forme estemporanee di comunanza e socialità, ma che (a certe condizioni) possano rappresentare anche piattaforme di azione che generano risultati tangibili nei campi dove operano i gruppi coinvolti in questo studio. Sembra, dunque, che la prospettiva sociologica adottata in questo articolo consenta di intravedere dei processi di ripoliticizzazione discorsiva e sociale (Hay, 2007) degli ETS, in cui gli “oggetti socio-politici” sono reimmessi in un campo pubblico di dibattito, dialettica e conflitto. Sono le pratiche associative il terreno più propizio dove si coltivano i progetti di cambiamento sociale.
Il potere trasformativo, di conseguenza, non si configura come uno spostamento esteso del baricentro dei luoghi del potere decisionale, ma piuttosto come small wins, piccole conquiste (Termeer, Dewulf, 2019; Weick, 1984) che localmente, quotidianamente e dal basso trasformano nel corso del tempo politiche e istituzioni, in maniera incrementale piuttosto che radicale. La collettivizzazione delle istanze è, quindi, un processo che avviene a livello di gruppo, dimensione in cui prendono forma processi di coordinamento di azioni in continuo divenire tipiche della teorizzazione dell’azione civica (Lichterman, Eliasoph, 2014) e in costante ridefinizione perché frutto di relazioni fra associati. La pianificazione di obiettivi di cambiamento e delle conseguenti azioni, dunque, diventa uno spazio poroso e permeabile in cui si riversa la dimensione relazionale, quindi, mutevole e flessibile, del gruppo. La sfida consiste nella capacità dei soggetti associativi di sopravvivere nel tempo, riuscendo a stare in un campo generativo-relazionale non pienamente controllabile e definibile da poteri esterni. La necessità organizzativa di mantenere vivo il gruppo nel tempo è un’esigenza che determina la capacità trasformativa dello stesso, in quanto lo spazio aperto, dialogico e relazionale innesca una trasformazione che nasce dall’interdipendenza tra istanze individuali e collettive delle persone che partecipano e prendono parte ad iniziative condivise (Højgaard, Egholm, 2025). In ultima analisi, l’innovazione innescata da trasformazioni circoscritte, che tuttavia mantengono alto il portato politico, richiede forme di alleanze e di coordinamento tra i diversi stakeholder attivi nelle comunità locali, in modo da far entrare le istanze promosse dagli ETS nelle modalità strutturate di governo delle istituzioni. Un aspetto quest’ultimo che non si è potuto indagare nel presente lavoro, ma che apre ulteriori prospettive di ricerca.
DOI 10.7425/IS.2025.04.04
Bibliografia
Bourdieu, P. (1994). Raisons pratiques: sur la théorie de l’action. Paris, Seuil; tr. it. (2009). Ragioni pratiche, Bologna, Il Mulino.
Busso, S. (2018). Away from Politics? Trajectories of Italian Third Sector after the 2008 Crisis. Social Sciences, (7)228, 1-20.
Busso, S. (2020). Terzo settore e politica. Appunti per una mappa dei temi e degli approcci. Polis, XXXIV, 2, 393-408.
Caltabiano, C., Vitale, C. & Zucca, G. (2024) (a cura di). La prospettiva civica. L’Italia vista da chi si mette insieme per cambiarla. Milano, Fondazione Giacomo Feltrinelli.
Caltabiano, C. (2024). Attivisti tra i banchi. Esperienze associative nella scuola. In Caltabiano, C., Vitale, T. & Zucca, G., (a cura di), La prospettiva civica. L’Italia vista da chi si mette insieme per cambiarla. Milano, Fondazione Giacomo Feltrinelli, 239-268.
Citroni, S. (2022). L’associarsi quotidiano. Terzo settore in cambiamento e società civile. Milano, Meltemi Editore.
Collins, R. (1992). Teorie sociologiche. Bologna, Il Mulino (ed. or. 1988).
Corchia, L. (2011). The Contradictions of Volunteer Work. A Factor of Fragmented Social Cohesion? The Case of VOs in Tuscany. In Salvini, A. & Andersen, A. J. W. (2011) (eds). Interactions, Health and Community. Pisa, PLUS, 241-254.
Doise, W. (1980). Levels of Explanation. European Journal of Social Psychology, vol. 10, 213-231.
Donati, P. & Solci, R. (2011). I beni relazionali. Che cosa sono e quali effetti producono. Torino, Bollati Boringhieri.
Eliasoph, N. (2009). Top-down Civic Projects are not Grassroots Associations: How the Differences Matter in Everyday Life. Voluntas, (3)20, 291-308.
Ficcadenti, C. (2024). Associarsi per (auto)organizzare il lavoro culturale. In Caltabiano, C., Vitale, T. & Zucca, G., (a cura di), La prospettiva civica. L’Italia vista da chi si mette insieme per cambiarla. Milano, Fondazione Giacomo Feltrinelli, 269-290.
Fine, G. A. (2012). Tiny Publics: A Theory of Group Action and Culture. New York, Russell Sage Foundation.
Fine, G. A. (2014). The Hinge: Civil Society, Group Culture, and the Interaction Order. Social Psychology Quarterly, 77(1), 5-26.
Florida, R. (2003). The Rise of the Creative Class: And How It’s Transforming Work, Leisure, Community, and Everyday Life, New York, Basic Books.
Florida, R. (2017). The New Urban Crisis: How our Cities are Increasing Inequality, Deepening Segregation, and Failing the Middle Class and What we Can Do about it. New York, Basic Books.
Foucault, M. (2013). L’archeologia del sapere. Milano, BUR Rizzoli (prima ed. 1969).
Gandini, A. (2019). L’economia della reputazione. Il lavoro della conoscenza nella società digitale. Milano, Ledizioni.
Goffman, E. (1998). L'ordine dell’interazione. Roma, Armando Editore.
Hay, C. (2007). Why we Hate Politics. Cambridge, Polity Press.
Højgaard, C. D. & Egholm, L. (2025). Fluid Forms of Organizing Volunteering: Producing Civic Action through Organizational Maintenance. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 54(1), 80-103.
Lichterman, P.& Eliasoph, N. (2014). Civic Action. American Journal of Sociology, 120(3), 798-863.
Melucci, A. (2013). The Process of Collective Identity. In Johnston H. (ed.). Social Movements and Culture. London, Routledge, 41-63.
Merton, R.K. & Rossi, A.S. (1950). Contribution to the Theory of Reference Group Behavior. In Merton, R.K. & Lazarsfeld, P.F. Continuities in Social Research. Glencoe, Free Press, 40-105.
Moini, G. (2013). Interpretare l’azione pubblica. Teoria, metodi e strumenti. Roma, Carocci.
Olson, M. (2013). La logica dell’azione collettiva. I beni pubblici e la teoria dei gruppi, Milano, Ledizioni (prima ed. 1971).
Papakostas, A. (2011). The Rationalization of Civil Society. Current Sociology, 59(1), 5-23.
Powell, W. W. & DiMaggio, P J. (1991) (a cura di). The New Institutionalism in Organizational Analysis. Chicago, University of Chicago Press.
Reggiardo, A. (2022). L’ibridazione del Terzo settore. Note di lettura sul dibattito. Autonomie Locali e Servizi Sociali, 2, 383-404.
Reich, R. B (1991). The Work of Nations. Preparing Ourselves for 21st Century Capitalism. New York, Vintage Books.
Roy, M. J. R., Eikenberry, A. M. & Teasdale, S. (2022). The Marketization of the Third Sector? Trends, Impacts and Implications. In Donnelly-Cox, G., Meyer, M. & Wijkström, F. Research Handbook in Nonprofit Governance. Chentelham, Edward Elgar Publishing, 371-390.
Salmieri, L. (2018). Deindustrializzazione, hinterland portuale ed entroterra: il caso di Napoli Est. In Canepari, E., Marin, B. & Salmieri, L. (a cura di), Gli entroterra delle città di mare. Les arrière-pays des villes de mer. Torino, Harmattan, 141-57.
Sclavi, M. (2003). Arte di ascoltare e mondi possibili. Come si esce dalle cornici di cui siamo parte. Milano, Mondadori.
Sherif, M. et al. (1961). Intergroup Conflict and Cooperation: The Robbers Cave Experiment. University of Oklahoma, Book Exchange.
Simmel, G. (2018). Sociologia. Milano, Meltemi Editore (ed. originale 1908).
Termeer, C. J. & Dewulf, A. (2019). A Small Wins Framework to Overcome the Evaluation Paradox of Governing Wicked Problems. Policy and Society, 38(2), 298-314.
Vitale, T. (2024). La prospettiva civica: riconoscimento, comunanza e demercificazione nella reinvenzione del locale. In Caltabiano, C., Vitale, T. & Zucca, G., (a cura di), La prospettiva civica. L’Italia vista da chi si mette insieme per cambiarla. Milano, Fondazione Giacomo Feltrinelli, 291-302.
Wahlström, M. & Peterson, A. (2006). Between the State and the Market. Expanding the Concept of “Political Opportunity Structure”. Acta Sociologica, 49(4), 363-377.
Weick, K. E. (1984). Small Wins: Redefining the Scale of Social Problems. American Psychologist, 39(1), 40.
Wenger, E. (2006). Comunità di pratica. Apprendimento, significato e identità. Milano, Raffaello Cortina Editore.
Whyte, W.F. (1943). Street Corner Society: The Social Structure of an Italian Slum. Chicago, University of Chicago Press.
Zucca, G. (2024). Sussurri e grida: associazionismo e salute mentale. In Caltabiano, C., Vitale, T. & Zucca, G., (a cura di), La prospettiva civica. L’Italia vista da chi si mette insieme per cambiarla. Milano, Fondazione Giacomo Feltrinelli, 209-238.
[1] Nel triennio 2022-2024 si sono iscritti al RUNTS, Registro unico previsto dal dlgs 117/2017 circa 39 mila nuovi ETS, sia enti costituitisi prima dell’istituzione di questo archivio, ma che operavano nel “sommerso”, sia soggetti nati nel lasso di tempo considerato (dati estratti da https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it). Ciò vuol dire che la società civile si rinnova costantemente (al ritmo di circa 800/1000 ETS neoiscritti al RUNTS al mese), facendo entrare nella sfera pubblica nuove esperienze associative, filantropiche o di imprenditorialità sociale. Tale vitalità sembra quasi controintuitiva rispetto alle previsioni che hanno accompagnato l’attuazione della nuova normativa, secondo cui un peso eccessivo degli adempimenti burocratici avrebbe disincentivato la creazione (o l’emersione) di nuovi ETS.
[2] Per una disamina sulle teorie sociologiche macro, micro e meso resta imprescindibile il contributo di Collins (1992).
[3] Una versione completa degli studi di caso è apparsa in tre saggi distinti (Caltabiano, 2024; Ficcadenti, 2024; Zucca, 2024) pubblicati all’interno del Decimo Rapporto sull’Associazionismo Sociale (Caltabiano, Vitale, Zucca, 2024). Gli autori dell’articolo desiderano ringraziare Gianfranco Zucca per aver generosamente messo a disposizione le interviste condotte nello studio dei casi sulle associazioni che operano nel campo della salute mentale.
[4] Ossia ambiti dove i sistemi istituzionali (simbolici e concreti) creano norme e prescrizioni che disciplinano (almeno in parte) il comportamento individuale e di gruppo. Gli attori collettivi coinvolti nella ricerca si prefiggono di modificare tale ordine precostituito, riuscendo solo parzialmente a dare seguito ai loro intenti.
[5] Per Bourdieu, un campo è costituito dalle relazioni fra le posizioni occupate dagli attori individuali e collettivi, pubblici e privati (anche soggetti non lucrativi), che interagiscono in un determinato spazio sociale (Bourdieu, 1994).
[6] Sulla condizione ambivalente (precarietà e creatività) vissuta dai lavoratori autonomi della conoscenza, si veda il contributo di Alessandro Gandini (2019).
[7] Anche Florida sembra essersi reso conto del rovesciamento di prospettiva vissuto dalla “classe creativa” in un saggio più recente sulla povertà, in forte crescita nelle metropoli americane (Florida, 2017).
[8] Considerando le attività svolte esclusivamente nel Centro Polifunzionale, nel 2023 sono stati coinvolti 175 minori fra gli otto e i diciotto anni in attività educative di vario genere, mentre solo a Ponticelli i MdS sono presenti in tre istituti scolastici.
[9] Tra i fondatori dell’Associazione insieme a Mario Rossi Doria.
[10] La cooperatrice comasca ha frequentato un master sugli strumenti di previsione sociale all’Università di Trento, acquisendo familiarità con le tecniche sviluppate dalla psicologia delle decisioni, l’analisi dei trend statistici e il risk management.
[11] I laboratori vengono moderati da un educatore de la Ricostituente, affiancato dall’insegnante del liceo/istituto tecnico superiore coinvolto nel progetto, o dai formatori/educatori che lavorano nelle comunità terapeutiche e di accoglienza.
[12] Il festival si è tenuto a Cartosio nel 2020, a Morbegno (SO) nel 2021, nel 2022 di nuovo a Cartosio, a Parma nel 2023, a Milano nel 2024. L’edizione del 2025 è programmata il 31 maggio-1^ giugno 2025 a Rubiera (RE).
[13] Alle famiglie meno abbienti non vengono richiesti tali contributi economici.