Lezioni sull'amministrazione condivisa
Davide Palazzo
La recensione del volume curato da Emiliano Frediani, riprodotta per gentile concessione di Labsus. Si tratta di un volume che raccoglie l'opera di Berrettini, Foglia, Frediani, Galli, Gallo, Giglioni, Pellizzari, Pizzanelli, Profeta, Tubertini in cui si fa il punto sul tema, tra fondamenti normativi e questioni poste dalla diffusione delle prassi applicative.
Si riproduce di seguito per gentile concessione di Labsus, la recensione del volume "Lezioni sull’amministrazione condivisa" curato da Emiliano Frediani ed edito da Giappichelli.
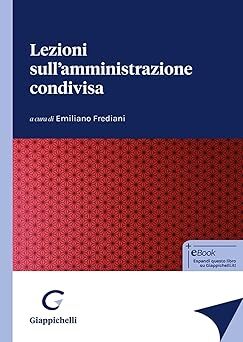 Il volume “Lezioni sull’amministrazione condivisa”, a cura di Emiliano Frediani, docente di Diritto amministrativo presso l’Università di Pisa, offre una ricca analisi dei profili teorici e delle applicazioni pratiche di un nuovo modello di amministrazione, fondato sulla cittadinanza attiva, che negli ultimi ha trovato crescente riconoscimento nel diritto positivo, nella giurisprudenza e nella prassi.
Il volume “Lezioni sull’amministrazione condivisa”, a cura di Emiliano Frediani, docente di Diritto amministrativo presso l’Università di Pisa, offre una ricca analisi dei profili teorici e delle applicazioni pratiche di un nuovo modello di amministrazione, fondato sulla cittadinanza attiva, che negli ultimi ha trovato crescente riconoscimento nel diritto positivo, nella giurisprudenza e nella prassi.
Il volume si apre con una prefazione del curatore, che inquadra precisamente il tema dell’amministrazione condivisa, come modello non solo giuridico, ma culturale, che richiede sia un “nuovo cittadino”, secondo la nota intuizione di Feliciano Benvenuti, sia una nuova amministrazione, aperta e dialogica.
La definizione delle caratteristiche di tale modello è oggetto del contributo di Fabio Giglioni, che prende le mosse dal carattere “flessibile” della Costituzione, e particolarmente dell’art. 97 Cost., nel consentire diversi modelli organizzativi dei poteri pubblici, anche ignoti nel momento in cui la nostra Carta fu approvata. In questo quadro, l’amministrazione condivisa si caratterizza per “la valorizzazione del contributo che i cittadini possono dare per soddisfare gli interessi generali”, trovando fondamento nei principi di solidarietà (art. 2 Cost.) e sussidiarietà (art. 118 Cost.) e rispettando altresì il principio di imparzialità.
Essa non trova esplicazione solamente nella disciplina del Terzo settore e dei rapporti di collaborazione tra gli enti che fanno parte e i poteri pubblici, bensì in ogni schema organizzativo di tipo non sinallagmatico e fondato sulla libera e solidale iniziativa dei privati diretta all’interesse generale. Si analizzano, a titolo esemplificativo, i “patti di collaborazione”, nelle varie forme in cui essi si esprimono nella prassi e nella legislazione speciale.
Il capitolo redatto da Claudia Tubertini evidenzia come tali esperienze, nel contesto locale, diano origine a un tipo di “città collaborativa (…) che eleva la collaborazione tra cittadini ed amministrazione a metodo normale per la cura degli interessi generali della città”. Si sottolinea così il carattere innovativo, ma altresì “ordinario” dell’amministrazione condivisa, come modello che si affianca, in posizione paritaria, a quelli “tradizionali” dell’amministrazione autoritaria, di prestazione o consensuale.
L’amministrazione condivisa trova supporto anche nel diritto dell’Unione europea, alla luce di una sua lettura attenta e aggiornata. In proposito, il contributo di Silvia Pellizzari ha il notevole merito di mettere in discussione la vulgata che concepisce il diritto europeo come orientato esclusivamente alla tutela del mercato, della concorrenza e delle libertà economiche. Mediante un’approfondita analisi della disciplina dei contratti pubblici, degli aiuti di Stato e dei fondi e finanziamenti dell’Unione europea, si evidenziano i significativi spazi che il diritto UE concede alla promozione dell’economia sociale e del Terzo settore e delle forme di partenariato con gli enti pubblici.
Amministrazione condivisa e Terzo settore: co-progettazione e co-programmazione
La co-progettazione e la co-programmazione, regolate a livello statale nell’art. 55 del Codice del Terzo settore (d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117), costituiscono due istituti centrali nel modello di amministrazione condivisa. Il loro difficile inquadramento nel contesto delle relazioni tra Stato, mercato ed enti non-profit ha dato luogo a un ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinale.
Con riferimento alla co-progettazione, il capitolo redatto da Emiliano Frediani ha il merito di collegare le peculiarità di tale istituto al profilo soggettivo degli enti del Terzo settore. L’autore evidenzia come tale profilo non si esaurisca in un elemento “negativo”, cioè nell’assenza dello scopo lucrativo, dovendosi invece apprezzare, in positivo, il possesso di una speciale professionalità, “socialmente acquisita”, che discende dal contatto tra il Terzo settore e il tessuto sociale. Da tale vicinitas deriva una expertise che rende l’apporto progettuale del Terzo settore non comparabile rispetto a quello che potrebbe fornire un operatore economico con scopo di lucro. Tale prospettiva ha trovato accoglimento nella sentenza n. 131/2020 della Corte costituzionale, che ha qualificato gli enti del Terzo settore come “rappresentativi della ‘società solidale’”.
A tale profilo soggettivo corrisponde il “coinvolgimento attivo” del Terzo settore nell’ambito della co-progettazione, che supera ampiamente lo schema della partecipazione “difensiva” o antagonista, per assumere piuttosto carattere informativo e collaborativo. In quest’ottica, il rapporto non ha natura sinallagmatica, differenziandosi dalle forme di partenariato regolate nel Codice dei contratti pubblici (d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36). Riscontro di tale impostazione si rinviene nella legislazione regionale, attentamente analizzata dall’autore.
La co-programmazione è oggetto del contributo di Alessandro Berrettini, il quale inquadra l’istituto nel contesto più ampio della disciplina e della dottrina sugli atti programmatici e sugli atti amministrativi generali. Si evidenzia, in particolare, il ruolo del Terzo settore come termine di collegamento tra la realtà socio-economica e la pubblica amministrazione. Mediante la co-programmazione si riduce l’asimmetria informativa e si realizza una forma di “democrazia partecipativa”, di volta in volta adattata dalle leggi regionali e dalle singole amministrazioni alla realtà sociale e territoriale di riferimento.
Il contributo di Luciano Gallo ha il pregio di ricostruire gli elementi fondanti e le basi normative della co-amministrazione, evidenziando le differenze con le logiche tradizionali di affidamento in regime concorrenziale. L’amministrazione condivisa può trovare una prima espressione negli atti generali delle amministrazioni, che possono da una parte approvare atti regolamentari specifici sul tema, dall’altra esplicitare l’orientamento alla co-amministrazione nei propri atti strategici come il DUP per i comuni nonché gli atti programmatori relativi a specifiche discipline. In tale ottica, l’autore colloca e commenta gli specifici strumenti di amministrazione condivisa, sottolineando il ruolo della valutazione di impatto sociale degli interventi realizzati e gli strumenti finanziari che possono sostenerla.
Nuove forme e applicazioni dell’amministrazione condivisa
Gli ulteriori capitoli del volume si soffermano su alcune importanti applicazioni “settoriali” dell’amministrazione condivisa, che si fanno spazio negli ultimi anni in coincidenza con l’emergere di nuovi bisogni sociali e sensibilità civiche.
Le comunità energetiche rinnovabili, analizzate da Giovanna Pizzanelli, costituiscono un ambito in cui il cittadino assume le vesti del “consumatore attivo nella produzione e nel consumo di energia (prosumer)”, orientando la propria azione ai principi della tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile. Similmente, la tutela ambientale costituisce l’obiettivo primario dei c.d. contratti di fiume e dei più recenti accordi di foresta, su cui si sofferma Giulio Profeta, evidenziando le difficoltà di inquadramento.
Le intersezioni tra diversi settori normativi sono al centro dei contributi offerti da Stefano Foglia e da Luca Galli.
Il primo analizza le forme di amministrazione condivisa nel contesto della valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso. Qui la commistione tra diversi interessi (interesse generale, interesse liturgico culturale e interesse religioso culturale) dà luogo a peculiari forme di partenariato il cui elemento in comune si rinviene nel principio di collaborazione, che travalica il limite della confessionalità.
Luca Galli si sofferma sulla complessa interazione tra pubblico e privato nell’ambito della gestione del fenomeno migratorio, relativamente al quale il coinvolgimento del settore privato-sociale costituisce opzione preferibile in quanto di per sé fattore d’integrazione. Particolare rilievo assume, in questo contesto, l’istituto della private sponsorship che coinvolge gli enti privati senza scopo di lucro oltre la sfera della prestazione dei servizi per giungere fino all’esercizio della funzione pubblica di gestione dei confini. Un esempio, dunque, di condivisione della funzione amministrativa in senso stretto, rispetto alla quale tuttavia emergono criticità per il rischio di violazione dei principi generali dell’azione amministrativa (imparzialità, trasparenza, obbligo di motivazione, ecc.).
Conclusioni
Dal volume in questione emerge un quadro in chiaroscuro dell’amministrazione condivisa. Da un lato, il fondamento costituzionale ed eurounitario del nuovo modello è indiscusso, alla luce di una lettura attenta dei principi e dei valori che contrassegnano l’ordinamento multilivello. Dall’altro, non può non evidenziarsi il carattere variegato e frammentato delle modalità di implementazione di tale modello, con particolare riferimento ai settori in cui può trovare attuazione, ai soggetti che possono (o devono) essere coinvolti e alle forme procedimentali tramite cui la collaborazione può realizzarsi.
Un certo grado di indeterminatezza normativa può trovare ragione nell’esigenza di adattamento dell’amministrazione condivisa a diversi contesti economici, sociali e culturali; in forza, cioè, di una esigenza di differenziazione insita nel principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.). Cionondimeno, rimane l’esigenza ineludibile che il nuovo modello di amministrazione, ancorché solidamente radicato nei principi di solidarietà e sussidiarietà, rispetti parimenti i confini fissati dai principi costituzionali dell’azione amministrativa, tra cui i principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, la cui osservanza può essere messa a rischio dal carattere eccessivamente “improvvisato” o informale delle forme di coinvolgimento del settore privato-sociale, nelle sue diverse manifestazioni.


