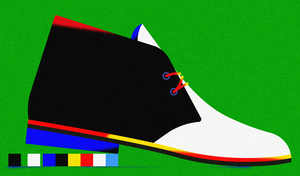
Numero 3 / 2025
La valutazione di impatto sociale come scelta culturale e strategica
Massimo Ronchini
Abstract
A partire da un’analisi critica della letteratura, il presente contributo esplora la Valutazione di Impatto Sociale (VIS) come leva strategica per il governo e l’orientamento delle organizzazioni non profit e imprese sociali. Nella prima parte, si evidenzia il ruolo della VIS nel sostenere l’azione trasformativa delle organizzazioni, mettendone in luce la natura riflessiva, la capacità di integrazione nei processi decisionali e la sua rilevanza sistemica per realtà il cui agire è guidato dalla generazione di impatto. In questa prospettiva, la VIS non viene concepita come funzione accessoria alla gestione, ma rappresenta una componente culturale che sottende i dispositivi attraverso cui si articolano le traiettorie di azione e sviluppo. Nella seconda parte, l’articolo approfondisce tre tensioni concettuali che condizionano l’effettiva integrazione della VIS nei dispositivi manageriali. Infine, le conclusioni propongono due traiettorie di sviluppo: una, rivolta alla ricerca, per il perfezionamento di modelli teorici e strumenti operativi; l’altra, rivolta alle organizzazioni, per favorire l’uso critico delle evidenze valutative e la diffusione di una cultura orientata all’apprendimento strategico.
Keywords: valutazione di impatto sociale, misurazione di impatto sociale, SIA, strategia, apprendimento, pianificazione strategica, controllo strategico, management.
Introduzione
Questo articolo propone una rassegna sulla Valutazione di Impatto Sociale (d’ora in avanti VIS) in una prospettiva strategica, esplorandone il ruolo non solo come strumento di misurazione e rendicontazione, ma anche come leva per il management e il controllo strategico delle organizzazioni. Negli ultimi decenni, la VIS ha acquisito una crescente importanza sia nel settore pubblico, sia in quello privato, riflettendo l'attenzione sempre maggiore verso le sfide sociali e ambientali che le organizzazioni e le politiche pubbliche sono chiamate ad affrontare. In particolare, le organizzazioni non profit e le imprese sociali, ovvero quelle che combinano una missione sociale con approcci di mercato per affrontare problemi sociali globali (Rawhouser et al., 2019), necessitano di strumenti adeguati a valutare e gestire gli impatti sociali che mirano a generare sui territori (Arvidson et al., 2014; Mair et al., 2006; Nicholls et al., 2015). La VIS, inoltre, viene adottata a diversi livelli istituzionali, trovando applicazione tanto nel settore pubblico (Agarchand et al., 2017; Antonie, 2012) quanto in quello privato (Grange et al., 2023; Hoos, 2022; Nguyen et al., 2015), fino alle più recenti esperienze di co-progettazione tra Enti Pubblici ed Enti del Terzo Settore (Tomasin, 2024).
Con questo contributo si intende offrire una lettura più articolata dei processi di VIS, evidenziandone il potenziale strategico e interrogandosi sulla sua integrazione nelle pratiche e nel governo delle organizzazioni. La sezione successiva, dedicata al perimetro di riflessione, offre una riconsiderazione critica del concetto di impatto sociale, delle tensioni tra misurazione e valutazione, e delle implicazioni che ne derivano per le pratiche organizzative. Seguirà un inquadramento dello stato dell’arte e delle domande di ricerca, quindi la presentazione della metodologia adottata. Nelle sezioni centrali dell’articolo, i risultati verranno articolati lungo due linee argomentative principali: la prima volta a definire il dominio strategico della VIS, la seconda a esplorare tre tensioni concettuali che ne attraversano la pratica e il significato. Le conclusioni offriranno infine una sintesi delle implicazioni teoriche e operative emerse, delineando possibili traiettorie di ricerca e sviluppo.
Il perimetro di riflessione e le domande di ricerca
Nella sua accezione più generale, la VIS afferisce ai processi attraverso cui si valutano e si gestiscono gli effetti sociali derivanti da interventi pianificati, includendo sia le conseguenze attese sia quelle non previste, che possono essere sia positive sia negative (Becker, 2001; Esteves et al., 2012; Vanclay, 2003). Tra gli elementi qualificanti si rintracciano la possibilità di rendere esplicita la missione e la proposta di valore sociale dell’organizzazione (Giovando et al., 2021) e di promuovere il coinvolgimento delle comunità di riferimento sia nell'identificazione dei propri bisogni (Esteves et al., 2012), sia nella definizione di un obiettivo di sviluppo condiviso (Mahmoudi et al., 2013). Le fasi di implementazione comprendono la tracciatura e l’analisi delle attività svolte, dei risultati conseguiti e degli effetti generati nelle comunità di riferimento (Guter-Sandu, 2023; Rawhouser et al., 2019), offrendo al contempo un supporto analitico ai processi decisionali (Esteves et al., 2009; Rowan, 2017; Santos et al., 2021).
Sebbene la formulazione sopra esposta implichi una definizione implicita di “impatto” come “effetto” di un intervento, la letteratura mostra come tale concetto sia in realtà oggetto di letture plurime e talvolta divergenti, alcune ad esempio focalizzate sui cambiamenti di lungo periodo (Nuchian et al., 2024), altre riferite a livello sistemico di trasformazione (De Benedictis et al., 2023). Tuttavia, con il passare del tempo, si è affermata una riduzione concettuale del significato di impatto che, come osserva Stame (2020), ha condotto a concepire la VIS come una tecnica focalizzata sull’attribuzione causale netta dei cambiamenti osservati alle azioni organizzative, riducendo la complessità del fenomeno valutativo a una questione esclusivamente metodologica. Ne deriva una contrapposizione fra due piani – quello valutativo, che implica l’attribuzione di senso, la riflessione strategica e il coinvolgimento degli attori, e quello misurativo, incentrato sulla raccolta di dati standardizzati e loro analisi – la quale produce implicazioni rilevanti tanto sul piano operativo quanto su quello strategico, poiché tende a orientare la VIS verso una funzione strumentale e conformativa, anziché trasformativa.
In questo scenario, è fondamentale chiarire che la misurazione rappresenta una componente necessaria ma non sufficiente della valutazione: ogni processo valutativo implica misurazione, ma non ogni attività di misurazione costituisce, di per sé, una valutazione. In altri termini, la raccolta e l’analisi dei dati forniscono elementi informativi, ma è l’impianto valutativo a doverne orientare il significato sin dalle fasi iniziali, guidando l’interpretazione verso letture strategiche e decisioni consapevoli. Ne consegue che la VIS può configurarsi non solo come un mero strumento tecnico, bensì come una leva per abilitare, costruire e gestire l'impatto sociale, sino ad accompagnare la definizione delle catene – o ecologie, come si dirà più avanti – del valore delle organizzazioni (Alinaghian et al., 2021; Hulgård et al., 2013; OECD Global Action, 2021). In questa funzione, la VIS favorisce non solo la progettazione di strategie coerenti con la missione sociale dell’organizzazione (Becker, 2001), ma anche una più efficace identificazione e lettura degli impatti generati, consentendo risposte adattive ai cambiamenti di contesto e l’attivazione di processi di apprendimento organizzativo (Esteves et al., 2012).
Le rassegne della letteratura attualmente disponibili si concentrano soprattutto sui modelli e sulle metodologie utilizzate per misurare l’impatto (Alomoto et al., 2022; Feor et al., 2023; Kah et al., 2020), altre si concentrano sul modello SROI (Corvo et al., 2022). Resta tuttavia marginale l’attenzione rivolta al ruolo strategico della VIS nei processi di gestione e controllo, in particolare rispetto alla sua effettiva integrazione nella cultura manageriale e nell’orientamento delle scelte organizzative – ambito che il presente articolo si propone di approfondire, articolando la rassegna attorno a tre domande centrali:
- In che modo – e per quali finalità – la VIS può essere integrata nella cultura organizzativa per orientare la gestione delle attività e la pianificazione strategica?
- Quali sono le principali difficoltà o criticità che ne ostacolano l’implementazione come strumento di governo organizzativo?
- Quali prospettive di approfondimento si aprono per la ricerca futura sulla VIS in una chiave gestionale e strategica?
Metodologia di ricerca
L’approccio adottato per questo contributo è quello della revisione sistematica (Grant et al., 2009), utile a sintetizzare in modo strutturato e riproducibile gli studi esistenti su un determinato tema (Snyder, 2019). L’obiettivo è identificare e organizzare le principali evidenze rilevanti rispetto alle domande di ricerca, garantendo rigore nei processi di selezione e analisi. Il protocollo PRISMA 2020 (Page et al., 2021) ha fornito le linee guida per condurre una revisione trasparente e accurata, mentre le raccomandazioni SWiM (Campbell et al., 2020) sono state utilizzate per la sintesi qualitativa, in linea con le peculiarità della letteratura sul management (Tranfield et al., 2003).
La ricerca bibliografica si è svolta sui database Scopus e Web of Science, impiegando combinazioni di parole chiave riconducibili alla valutazione dell’impatto sociale (es. Social Impact Assessment, Social Impact Measurement, ecc.) e alla dimensione gestionale e strategica (es. Management, Strategic Planning, Strategic Control, ecc.). Il focus è stato limitato ai contributi che trattano la VIS come strumento a supporto della gestione e della pianificazione strategica nelle organizzazioni non profit e nelle imprese sociali, escludendo i lavori focalizzati esclusivamente sul tema rendicontazione, le revisioni precedenti e gli articoli non pertinenti rispetto al quadro di ricerca. Il processo di selezione ha previsto una prima analisi indipendente di abstract e introduzioni, seguita dalla lettura integrale degli articoli selezionati. Accanto alla letteratura accademica, è stata inclusa anche una selezione mirata di fonti grigie – in particolare report istituzionali (es. OECD–European Union, programma LEED) – rilevanti per comprendere l’applicazione della VIS nei contesti di policy. Il corpus finale comprende 93 articoli scientifici peer-reviewed e 5 documenti di letteratura grigia, per un totale di 98 fonti. Tutto il materiale è stato sottoposto a un’analisi qualitativa orientata a costruire una sintesi interpretativa delle principali traiettorie teoriche e applicative che collocano la VIS all’interno dei processi di management strategico.
Risultati
L’analisi descrittiva dei 98 contributi selezionati ha evidenziato una distribuzione eterogenea su 70 riviste scientifiche, confermando il crescente interesse per la VIS in molteplici ambiti disciplinari. I contributi si concentrano principalmente su riviste di management e contabilità (ad esempio Journal of Management, Management Accounting Research), di imprenditorialità sociale e Terzo Settore (Journal of Social Entrepreneurship, Nonprofit Management & Leadership), nonché su riviste orientate alla sostenibilità e alla responsabilità sociale (Business Strategy and the Environment, Journal of Business Ethics). Una parte della letteratura è inoltre pubblicata in riviste tematiche settoriali, come quelle dedicate al turismo sostenibile.
Dal punto di vista della concentrazione editoriale, circa il 20% degli articoli è stato pubblicato in sei riviste, con una particolare incidenza del Journal of Cleaner Production, noto per l’attenzione ai temi dello sviluppo sostenibile e dell’impatto ambientale. Questo dato riflette il legame storico tra VIS e valutazione di impatto ambientale (Arce-Gomez et al., 2015; Burdge, 2003b; Esteves et al., 2012), soprattutto nei contesti in cui l’analisi dell’impatto sociale si è sviluppata come complemento ai processi di autorizzazione ambientale.
Sul piano geografico, la letteratura si concentra prevalentemente su studi condotti in Australia, Italia e Stati Uniti, seguiti da Regno Unito, Paesi Bassi, Cina, Francia, Canada, Sudafrica e Spagna. Questa distribuzione riflette l’emergere della VIS nei paesi che hanno promosso riforme significative in materia di Terzo Settore e valutazione dell’impatto, come nel caso italiano e australiano. In particolare, l’Italia si configura come un contesto normativamente avanzato per la promozione della VIS, grazie al quadro delineato dal Codice del Terzo Settore (2017) e ai successivi decreti attuativi – in particolare le Linee guida ministeriali per la redazione del bilancio sociale (2019a) e quelle per la realizzazione dei sistemi di valutazione dell’impatto sociale (2019b) – che introducono obblighi e indirizzi operativi volti a incentivare l’integrazione della valutazione degli effetti nelle pratiche di rendicontazione e gestione delle organizzazioni, alimentando al contempo sia l’interesse delle realtà del Terzo Settore verso strumenti valutativi, sia una vivace produzione scientifica e applicata sul tema (si veda, al riguardo, il numero monografico della rivista Impresa Sociale, 2020, n. 4). Anche il caso australiano risulta particolarmente significativo: qui la VIS si è sviluppata inizialmente in ambito ambientale e successivamente è stata integrata nei processi di valutazione dei grandi progetti industriali e infrastrutturali. L’adozione della VIS come parte dei quadri normativi di autorizzazione e monitoraggio degli impatti sociali ha favorito una letteratura attenta agli aspetti procedurali, ai modelli partecipativi e ai meccanismi di accountability nelle relazioni tra enti pubblici, comunità locali e settore privato (Esteves et al., 2012; Kabir, 2021). Inoltre, l’analisi temporale evidenzia una significativa accelerazione dell’interesse scientifico negli ultimi dieci anni: tra il 2014 e il 2024, il numero di pubblicazioni è più che raddoppiato rispetto ai trent’anni precedenti (1984–2013).
Infine, l’analisi qualitativa dei contributi ha permesso di individuare due principali livelli analitici ricorrenti nella letteratura, spesso presenti in modo intrecciato all’interno degli stessi studi. Il primo riguarda la VIS come ambito funzionale a supporto della gestione, della pianificazione e dell’apprendimento organizzativo. In questi contributi, la valutazione viene potenzialmente interpretata come parte integrante dei processi decisionali, contribuendo a strutturare modalità di intervento più sensibili al contesto e adattabili nel tempo. Il secondo livello mette in luce un insieme di dimensioni di tensione che attraversano l’implementazione della VIS nei contesti organizzativi, e che riguardano aspetti concettuali, metodologici e operativi. Tra questi, le criticità che emergono più frequentemente sono riconducibili alla distinzione tra output e outcome, alla natura lineare o non lineare dei processi di generazione dell’impatto, e ai diversi livelli di coinvolgimento degli stakeholder nei processi di valutazione. Tali elementi sono spesso indicati come fattori che ne influenzano la legittimità, l’efficacia e l’integrazione all’interno delle pratiche di governo organizzativo. Questi due livelli delineano il quadro delle principali evidenze emerse e forniscono la base per le riflessioni interpretative che saranno approfondite nelle successive sezioni.
Discussione
Come anticipato, i risultati della revisione restituiscono un panorama articolato e in continua evoluzione, strutturato attorno a due livelli analitici tra loro complementari. Da un lato, emerge un dominio funzionale, in cui la VIS si configura come una risorsa da integrare progressivamente nei processi di gestione, pianificazione e apprendimento organizzativo. Dall’altro, si delineano alcune tensioni concettuali e operative – output vs. outcome, causalità lineare vs. non lineare, basso vs. alto grado di coinvolgimento degli stakeholder – che attraversano le pratiche valutative, influenzandone la capacità di orientare strategicamente l’azione organizzativa. La sezione che segue approfondisce entrambi questi livelli.
Il dominio strategico della VIS tra motivazioni, prospettive e culture organizzative
Il primo livello di analisi riguarda il dominio strategico-funzionale della VIS, nell’ambito del quale emergono dalla letteratura due principali logiche di implementazione, assunte qui come punto di partenza dell’argomentazione.
Da un lato, la VIS viene adottata in risposta alle crescenti pressioni di accountability esercitate da una pluralità di stakeholder (van Rijn et al., 2021), tra cui comunità locali (Miller et al., 2007), donatori (Polonsky et al., 2016) e finanziatori istituzionali (Gazzola et al., 2021; Muñoz et al., 2020). In tale contesto, le pratiche valutative si configurano spesso come dispositivi relazionali, entro cui si intrecciano aspettative differenziate: da un lato, ad esempio, gli enti finanziatori – in particolare le fondazioni di erogazione – richiedono evidenze sull’efficacia dei progetti sostenuti, sia per fini conoscitivi interni sia per legittimare le proprie scelte allocative; dall’altro, le organizzazioni beneficiarie riconoscono la necessità di rendicontare in modo strutturato gli effetti generati attraverso l’utilizzo delle risorse ricevute, anche al fine di consolidare relazioni fiduciarie e accedere a nuove opportunità di sostegno (Ricciuti et al., 2018). In molti casi, tuttavia, come osservato in diverse fonti (OECD, 2021; Stame, 2020), la crescente istituzionalizzazione della valutazione tende a tradursi in sistemi standardizzati di indicatori e cruscotti predefiniti, spesso imposti dai finanziatori secondo logiche uniformi e indipendenti dalle specificità dei territori, delle comunità e degli interventi. Gli approcci di questo tipo, prevalentemente prescrittivi, tendono talvolta a collocarsi entro una logica di “measure to prove” (Kato, 2021; Lall, 2017; van Rijn et al., 2021), in cui la valutazione è finalizzata principalmente alla dimostrazione dell’efficacia di specifici interventi progettuali su un target definito di persone beneficiare (Grieco, 2018).
D’altro canto, alcuni studi evidenziano che le relazioni tra ente finanziatore ed ente finanziato, quando sono fondate su fiducia e riconoscimento reciproco, possono orientare la VIS verso una connotazione meno prescrittiva. In questi casi – come rilevato nello studio condotto da Nguyen et al. (2015) – il processo valutativo si emancipa dalla mera logica di controllo esterno, configurandosi piuttosto come una leva per coltivare relazioni collaborative. Tali dinamiche, una volta consolidate, possono creare le condizioni per un confronto aperto su criticità e apprendimenti, superando le rigidità tipiche dei modelli impositivi. In questo senso, la VIS riesce ad agire come dispositivo abilitante, poiché da un lato favorisce l’emersione di pratiche riflessive orientate al miglioramento dei progetti, e dall’altro contribuisce alla costruzione di capacità organizzative (Denny-Smith et al., 2020; Gallou et al., 2019).
Tali considerazioni si collegano a quella che in letteratura viene generalmente definita come logica del “measure to improve” (Gallou et al., 2019; Lall, 2017; van Rijn et al., 2021), dove si riconosce il processo valutativo come elemento utile alla pianificazione strategica (Depedri, 2020; Kubickova, 2021; Moura et al., 2022; van Rijn et al., 2021) e all’apprendimento organizzativo (Denny-Smith et al., 2020; Gallou et al., 2019; Gibbon et al., 2011; Muñoz et al., 2020), e dove si assegna alla misurazione un valore principalmente generativo, ossia capace di restituire significato alle attività progettuali e di orientare le decisioni verso gli obiettivi strategici (Barinaga, 2023; Behn, 2003; Maas, 2009; Moura et al., 2022).
Queste due logiche, pur nella loro diffusione in letteratura, non dovrebbero però essere intese come dicotomiche, né in termini normativi né funzionali. Al contrario, esse possono coesistere e intrecciarsi nei processi progettuali, a condizione che siano ricondotte a un impianto valutativo consapevole. In altri termini, la logica del “measure to prove” – riconducibile alla dimensione misurativa nei rapporti tra enti finanziatori ed enti finanziati – può risultare strategicamente utile quando orientata a far emergere non soltanto ciò che ha funzionato sul piano progettuale, ma anche il perché ha funzionato e, soprattutto, ciò che non ha generato i risultati attesi, evitando inoltre la produzione e la diffusione di narrazioni univoche e auto-referenziali. In questa prospettiva, il “provare” non si limita a dimostrare l’efficacia di quanto realizzato, ma si apre anche al “dimostrare” ciò che si è compreso lungo il percorso di valutazione.
In questa direzione, un ruolo potenzialmente abilitante può essere svolto dai procedimenti di co-programmazione e co-progettazione, sia quando formalmente disciplinati dall’art.55 Codice del Terzo Settore (2017), sia quando organizzati in modo strutturato al di fuori della cornice normativa, come pratiche collaborative che possono essere attivate, ad esempio, tra enti finanziatori, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del Terzo Settore. In entrambi i casi, tali approcci potrebbero incentivare una definizione condivisa degli obiettivi e delle modalità di intervento, offrendo le condizioni per una valutazione integrata in senso strategico sin dalle fasi iniziali delle relazioni inter-organizzative. Sulla scorta delle riflessioni proposte da Tomasin (2024), si può ritenere che, quando la valutazione viene introdotta sin dall’avvio di questi percorsi, essa assuma una funzione generativa e trasformativa, poiché condivisa tra le parti come strumento di lettura del contesto, di costruzione ex ante delle ipotesi sottostanti alla generazione del valore sociale e di negoziazione delle metriche. In questo quadro, la VIS non si limita a rispondere a obblighi esterni, ma può contribuire alla strutturazione di visioni strategiche comuni, superando le rigidità dei modelli standardizzati e favorendo la contestualizzazione delle misure rispetto ai territori, alle comunità e alle finalità specifiche dell’intervento. Sebbene le pratiche osservate registrino ancora una diffusione disomogenea e talvolta solo formale, le esperienze di co-progettazione possono in questo senso rappresentare un laboratorio utile per comprendere come la dimensione valutativa possa essere radicata nell’intenzionalità e non solo nella tecnica, riconfigurando la misurazione come esito e non come presupposto del processo valutativo. Le riflessioni fin qui sviluppate possono almeno parzialmente sovrapporsi alle evidenze sperimentali proposte da Cecchini Manara et al. (2025), aprendo ulteriori scenari di analisi sul ruolo che le configurazioni relazionali tra finanziatore e organizzazione finanziata assumono nell’orientare la natura e le finalità del processo valutativo. Lo studio in questione, che simula diverse modalità di interazione tra le parti nell’ambito della finanza a impatto, mostra, tra le altre cose, come l’introduzione di metriche ancorate al raggiungimento di soglie minime di qualità possa indurre l’ente finanziato a limitarsi all’adempimento richiesto, sacrificando in parte la qualità complessiva dei servizi erogati. In questo quadro, appare dunque rilevante interrogarsi su come relazioni cooperative, fondate sulla fiducia e sul confronto dialogico continuativo, possano contribuire a ridurre le asimmetrie informative tra gli attori coinvolti e a contenere tali rischi distorsivi, favorendo un riposizionamento del piano valutativo verso una maggiore coerenza con il significato trasformativo degli interventi finanziati.
La distinzione più rilevante, quindi, non è tra provare o migliorare, ma tra pratiche valutative ancorate a una funzione tecnica e misurativa, e processi valutativi che nascono da una riflessione strategica sul senso e sugli scopi della misurazione, muovendo dai processi di generazione dell’impatto per arrivare a quelli di misurazione – e non viceversa (De Benedictis et al., 2023). In linea con questa impostazione, quando la VIS oltrepassa il perimetro del singolo intervento progettuale e viene assunta come componente strutturale delle organizzazioni, essa assume per le imprese sociali e le organizzazioni non profit un ruolo cruciale, in quanto consente di monitorare e migliorare il grado di raggiungimento degli obiettivi istituzionali, in coerenza con la loro missione e con una visione sistemica dell’impatto capace di integrarsi nelle dimensioni economiche, sociali e ambientali dello sviluppo organizzativo (Battilana et al., 2014; Burdge, 2003a; Molecke et al., 2017; Nguyen et al., 2015). Solo allora, tale funzione si traduce anche in un supporto integrato al processo decisionale, alimentando la disponibilità di informazioni utili alla valutazione critica dell’efficacia complessiva dell’agire organizzativo (Jäger et al., 2013).
A partire da queste ultime considerazioni, l’integrazione della VIS nei processi organizzativi può maturare fino a configurarsi come un vero e proprio approccio strutturato alla gestione dell’impatto (Gentile, 2002; Hehenberger et al., 2023; Krlev et al., 2023; OECD et al., 2024). L’impact management, pur essendo inizialmente riconducibile alla logica del “measure to improve”, non rappresenta soltanto un’evoluzione tecnica della funzione valutativa, ma si configura come una prospettiva gestionale che acquista pieno significato solo quando è profondamente radicata nella cultura organizzativa (Hehenberger et al., 2020, 2023; OECD et al., 2024). Tale radicamento si esprime nell’adozione di sistemi, identità, comportamenti e pratiche che riflettono una dimensione culturale orientata all’apprendimento dalle evidenze raccolte, alla rilettura critica delle strategie e al coinvolgimento consapevole degli stakeholder nei processi valutativi (De Benedictis et al., 2023; OECD et al., 2024). Lungi dal costituire un esito residuale, la VIS interpretata attraverso la lente dell’impact management diviene quinti parte integrante della capacità dell’organizzazione di governare in modo consapevole il proprio sviluppo.
La seguente tabella delinea una mappa dei principali ambiti gestionali che possono essere valorizzati attraverso l’adozione della VIS come processo valutativo ispirato all’impact management. Tali ambiti sono ricondotti al meta-dominio del controllo strategico (Bagnoli, 2009; David, 2011; Gatti et al., 2021; Papulova et al., 2016), inteso non come funzione settoriale, ma come cornice trasversale che integra pianificazione, processo decisionale, apprendimento e gestione delle relazioni. In questa cornice, la VIS si configura come leva trasformativa, capace di rafforzare coerenza strategica e capacità di gestione delle organizzazioni.
|
Meta-dominio |
Ambito gestionale |
Funzioni attivabili attraverso la VIS in un approccio valutativo orientato all’impact management |
|
Controllo strategico |
Pianificazione strategica e orientamento al contesto |
Supporto nella definizione di obiettivi strategici e allineati alla missione |
|
Orientamento alla progettazione adattiva a partire dal contesto |
||
|
Traduzione della missione in una narrazione del cambiamento che si vuole contribuire a generare |
||
|
Apprendimento organizzativo e miglioramento continuo |
Sostegno all’apprendimento organizzativo attraverso l’analisi e le evidenze dei cambiamenti sociali |
|
|
Facilitazione di cambiamenti strutturali orientati all’efficacia e all’efficienza |
||
|
Stimolo alla diffusione di una cultura valutativa interna e trasversale (capacity building) |
||
|
Processo decisionale |
Rafforzamento del processo decisionale basato su evidenze e senso |
|
|
Stakeholder engagement e governance |
Coinvolgimento degli stakeholder nella generazione e lettura dei cambiamenti sociali |
|
|
Generazione di visioni strategiche condivise in contesti collaborativi (es. co-progettazione) |
In conclusione, il potenziale strategico della VIS non risiede tanto nella contrapposizione tra le logiche del “provare” e del “migliorare”, quanto nella capacità delle organizzazioni di ricondurre i processi valutativi a una riflessione consapevole sul senso, sugli scopi e sulle condizioni del proprio agire. È proprio questa riflessività, se coltivata come pratica culturale e intenzionale – come nei più maturi approcci di impact management – a rafforzare la capacità di controllo strategico delle organizzazioni e a sostenere processi decisionali orientati all’apprendimento, tanto nella dimensione gestionale interna quanto in quella relazionale e collaborativa.
Dimensioni critiche e tensioni interpretative
Il secondo livello di analisi riguarda l’esplorazione di alcune tensioni concettuali e operative che attraversano l’adozione della VIS nei contesti organizzativi. Queste tensioni non devono essere intese come polarità inconciliabili, bensì come assi interpretativi utili a cogliere la complessità e la natura dinamica dei processi valutativi. In particolare, verranno approfonditi tre snodi critici ricorrenti nella letteratura e nella prassi: la distinzione tra output e outcome, la contrapposizione tra modelli di causalità lineare e non lineare, e le implicazioni connesse a un basso o alto grado di coinvolgimento degli stakeholder. L’analisi di queste dimensioni consente di far emergere alcune ambivalenze strutturali che caratterizzano la pratica valutativa e, al tempo stesso, di offrire alle organizzazioni – singolarmente o in forma collaborativa – strumenti interpretativi per orientare in modo più consapevole le proprie scelte gestionali e valutative.
Il passaggio critico dalla performance al cambiamento
Numerosi approcci alla VIS si sviluppano a partire dal modello della impact value chain (Dufour, 2019), che descrive il processo di generazione del valore sociale come una sequenza logica articolata in cinque passaggi: input, attività, output, outcome e impatto (Rosenzweig, 2004). Tale catena intende rappresentare il legame tra ciò che un’organizzazione mette in campo e i cambiamenti che, attraverso le proprie attività, è orientata a generare: gli output corrispondono ai prodotti o risultati immediati delle azioni intraprese; gli outcome riflettono i cambiamenti nelle condizioni di vita delle persone e delle comunità coinvolte. Infine, l’impatto, seguendo le più ricorrenti letture già richiamate in precedenza, si riferisce generalmente all’insieme dei cambiamenti attribuibili all’intervento, al netto di quanto sarebbe comunque accaduto in assenza dello stesso (Dufour, 2019; Grieco, 2018). In questa sequenza, mentre gli output risultano in larga parte sotto il controllo diretto dell’organizzazione e possono essere più facilmente misurati, gli outcome e, ancor più, l’impatto si rivelano concettualmente e metodologicamente più complessi da isolare e quantificare, poiché dipendono da una pluralità di fattori esterni e da dinamiche relazionali non sempre governabili (Molecke et al., 2017).
Nel quadro appena delineato, la distinzione tra output e outcome – e, in prospettiva, anche impatto – riveste un significato strategico rilevante per le organizzazioni non profit e le imprese sociali, in quanto direttamente connessa alla natura della missione istituzionale perseguita a livello organizzativo. Per chiarire il punto, si può ricorrere a un’analogia: se nelle imprese for profit gli output – intesi come beni prodotti o servizi erogati – possono essere considerati elementi sufficienti per valutare il raggiungimento degli obiettivi, nel caso di organizzazioni costituite con finalità di utilità sociale ciò che dovrebbe assumere centralità è il cambiamento che si contribuisce a generare nel contesto territoriale di riferimento, e non soltanto la quantità di attività svolte o di servizi offerti. Il passaggio concettuale dagli output agli outcome non rappresenta, dunque, soltanto un’evoluzione metodologica, ma costituisce una condizione necessaria per garantire coerenza tra obiettivi organizzativi, sistemi valutativi e controllo strategico. Spostare l’attenzione da ciò che si realizza a ciò che cambia – o può ragionevolmente cambiare – nelle condizioni di vita delle persone e delle organizzazioni coinvolte, fino a incidere sui contesti in cui si opera, significa andare oltre le logiche di mera rendicontazione fondate su quadri di compliance e su indicatori di efficienza, per adottare pratiche valutative capaci di collegare le azioni svolte agli obiettivi strategici, in coerenza con la missione istituzionale.
Un caso emblematico in tal senso è quello documentato da Dufour (2019) riguardante una WISE (Work Integration Social Enterprises) francese, la quale ha progressivamente abbandonato un impianto valutativo centrato sugli output – peraltro richiesto dai propri stakeholder pubblici – per introdurre indicatori focalizzati su cambiamenti nei comportamenti e nelle competenze dei destinatari. Questo passaggio non ha eliminato la dimensione del monitoraggio, ma l’ha integrata con una prospettiva valutativa più ampia, volta a comprendere il contributo effettivo dell’organizzazione al cambiamento sociale. Ne emerge così la distinzione concettuale tra monitoraggio o rendicontazione delle attività e valutazione dei cambiamenti.
Tuttavia, alcuni contributi emersi nell’ambito della letteratura analizzata e nei casi studio ricompresi nel processo di revisione, evidenziano come la differenza tra output e outcome continua a generare ambiguità nella prassi. In diversi casi, le organizzazioni descrivono i cambiamenti attraverso indicatori riconducibili agli output, come il numero di beneficiari o di ore di formazione erogate (Grieco, 2018; Polonsky et al., 2016; Sanfeliu et al., 2013), trascurando la complessità multidimensionale degli outcome, che può includere, ad esempio, miglioramenti nella salute mentale e fisica, nelle competenze, nella coesione sociale o nella resilienza comunitaria (Antadze et al., 2012; Burkett et al., 2017; Denny-Smith et al., 2020; Hebb et al., 2017; Hervieux et al., 2019). A complicare ulteriormente il quadro, alcune pratiche di rendicontazione hanno adottato espressioni come social outputs per descrivere i risultati ottenuti, contribuendo però ad accrescere la confusione concettuale: secondo le definizioni comunemente accettate, se si intende valutare l’impatto sociale, è necessario almeno fare almeno riferimento a social outcomes; al contrario, parlare di social outputs richiama più propriamente le logiche del monitoraggio classico e non quelle proprie della valutazione di impatto (Antadze et al., 2012).
In sintesi, la confusione concettuale tra output e outcome rischia di compromettere la capacità delle organizzazioni di leggere e interpretare i cambiamenti generati nei territori, alimentando distorsioni nei sistemi di controllo e valutazione che, quando orientati esclusivamente alla misurazione degli output o all’impiego di indicatori di performance produttiva, tendono a riprodurre logiche proprie del settore for profit, trascurando gli obiettivi trasformativi dell’azione organizzativa e risultando, di conseguenza, incompleti rispetto agli scopi istituzionali perseguiti. Per evitare tale rischio, è essenziale che le organizzazioni riflettano sin dalla fase di progettazione dei sistemi di gestione su ciò che realmente aspirano a trasformare nei contesti di riferimento, così da costruire dispositivi valutativi coerenti con la propria identità e missione.
Causalità e linearità nei processi di generazione dell’impatto
Per affrontare criticamente la seconda tensione che attraversa il processo di VIS, è necessario anzitutto chiarire il significato e le implicazioni concettuali di due nozioni spesso utilizzate in modo intercambiabile, ma sostanzialmente distinte: causalità e linearità. La prima concerne la relazione di causa-effetto tra fenomeni, ovvero il tentativo di riconoscere perché un determinato cambiamento avviene; la seconda descrive invece la forma assunta da tale relazione, ossia se il cambiamento avviene secondo una sequenza ordinata e prevedibile. In altri termini, mentre la causalità rappresenta un fondamento logico-epistemologico – stabilire che cosa causa che cosa – la linearità costituisce una specifica ipotesi sul modo in cui tale relazione si sviluppa.
Tuttavia, tanto la nozione di causalità quanto quella di linearità sono concetti il cui significato assume diverse accezioni in base ai contesti teorici e alle tradizioni epistemologiche di riferimento. Sul versante della causalità, si è nel tempo affermata l’esigenza di adottare un approccio pluralista, anche in ragione della sua natura polisemica, capace di accogliere diversi modelli interpretativi – dal paradigma regolarista a quello determinista, dalle letture probabilistiche alle impostazioni controfattuali, fino alle prospettive interventiste, processuali e realiste (Laudisa, 2012). Ciascuno di essi propone un diverso modo di intendere che cosa significhi causare un cambiamento e si fonda su specifici assunti epistemologici che sarebbe opportuno rendere espliciti anche nel dibattito valutativo, poiché condizionano i nostri giudizi sull’impostazione del processo di valutazione, sulle modalità di analisi e sull’interpretazione dei cambiamenti osservati. Al contempo, la scelta dell’approccio valutativo – e, in particolare, della funzione che si vuole attribuire alla valutazione nel contesto specifico – orienta la selezione degli strumenti e dei modelli più adatti a sostenerla e a garantirne la coerenza. Da questa prospettiva, il rigore controfattuale – sostenuto, ad esempio, da Barbetta (2020) – andrebbe inteso, a parere di chi scrive, non come prescrizione univoca su come condurre una valutazione, ma come opzione misurativa da adottare in modo consapevole solo qualora risulti coerente con il piano valutativo ed epistemologico di riferimento, ovvero con gli obiettivi conoscitivi e le condizioni specifiche in cui la valutazione si colloca. Anche la linearità, come la causalità, può assumere significati differenti – riferendosi, ad esempio, a sequenze temporali, effetti additivi, proporzionalità dirette o isolabilità delle variabili – ma in tutte le sue declinazioni implica comunque l’assunzione di un nesso prevedibile e ordinato tra le variabili, una presunzione che verrà messa in discussione nei contesti sociali analizzati.
Pur riconoscendo la complessità teorica di questi concetti, le organizzazioni non profit e le imprese sociali non possono, a parere di chi scrive, sottrarsi a un confronto critico sui propri processi di generazione e valutazione del valore sociale, orientandosi istituzionalmente verso finalità di cambiamento. Nel quadro del presente contributo, che si interroga sul ruolo della VIS come leva per il controllo strategico, questa esigenza si fa ancora più stringente: rinunciare a tale riflessione equivarrebbe, in ultima analisi, a rinunciare alla propria vocazione trasformativa, organizzando l’azione in assenza di direzionalità o, peggio, piegando la missione a logiche puramente efficientistiche, più prossime alla razionalità strumentale dell’impresa for profit che alla propria identità costitutiva. In questo senso, il parallelismo con la distinzione tra output e outcome già discussa risulta evidente, poiché rinunciare a interrogarsi sui meccanismi causali significa rimanere ancorati alla logica degli output, limitando la possibilità di orientare l’azione in modo strategico verso i propri obiettivi di cambiamento e trasformazione.
In questo quadro, una delle rappresentazioni più adottate per descrivere i processi di generazione dell’impatto è la Theory of Change (ToC), da cui deriva la struttura sequenziale della catena del valore presentata nella sezione precedente. Assumendo spesso una configurazione lineare – in cui i cambiamenti attesi sono concepiti come risultato diretto delle azioni realizzate – la ToC solleva, tuttavia, interrogativi sulla sua capacità di rappresentare adeguatamente la complessità dei contesti sociali. In un contributo di Ebrahim et al. (2010), successivamente ripreso anche da altri autori, viene proposta una distinzione tra una Theory of Change “focused”, fondata su nessi causali chiari e ordinati, e una “complex”, in cui le relazioni tra azioni e cambiamenti risultano meno intellegibili, poiché dipendono da molteplici fattori interagenti. La riflessione su come approfondire la comprensione dei meccanismi complessi e non sempre lineari di generazione dell’impatto rimane, in questo senso, una questione aperta.
Alcuni contributi emersi dalla letteratura analizzata e dai casi studio inclusi nel processo di revisione convergono nel mettere in discussione l’assunzione di linearità. Lowe et al. (2017) , in particolare, osservano come in contesti complessi come quelli sociali — caratterizzati da sistemi interdipendenti e da fattori non sempre visibili o controllabili — la pretesa di spiegare i cambiamenti attraverso modelli lineari conduca a rappresentazioni distorte e a dati potenzialmente fuorvianti. In modo analogo, Antadze e Westley (2012) segnalano l’inadeguatezza degli strumenti valutativi convenzionali, fondati su logiche lineari e positiviste, nel restituire la natura trasformativa e spesso imprevedibile dei processi di innovazione sociale. Molecke e Pinkse (2017), infine, evidenziano come l’incertezza che caratterizza le relazioni causali nei contesti di intervento renda problematico l’impiego di metodologie standardizzate, riscontrando che molte organizzazioni tendono ad adottare pratiche di “bricolage” valutativo, ovvero configurazioni adattive che combinano strumenti, dati e criteri eterogenei, con l’obiettivo di costruire rappresentazioni plausibili e contestualizzate del cambiamento generato.
Alla luce di quanto finora discusso – e in particolare della necessità di superare rappresentazioni lineari e unidirezionali dei processi di generazione dell’impatto, in favore di modelli più aderenti alla natura complessa, dinamica e relazionale dei contesti sociali – potrebbe altresì risultare più opportuno sostituire la metafora, pur ampiamente diffusa, delle catene del valore con una visione maggiormente sistemica e interdipendente. In questa direzione, il concetto di ecologia dell’impatto, mutuato dalle scienze biologiche, si presta a rappresentare in modo più coerente e adeguato quell’insieme di relazioni adattive, retroazioni e co-evoluzioni che caratterizzano i processi di cambiamento attivati dalle organizzazioni nei propri territori di riferimento.
Dal coinvolgimento alla co-costruzione ecosistemica per una riflessione sul ruolo degli stakeholder
La terza tensione emersa dall’analisi della letteratura non si presenta come una contrapposizione tra posizioni divergenti, quanto piuttosto come l’esigenza di approfondire criticamente un tema trasversalmente riconosciuto, ossia il grado di coinvolgimento degli stakeholder nei processi di VIS. Sebbene si riscontri un’ampia convergenza sull’importanza della partecipazione degli attori territoriali lungo l’intero processo valutativo (Erdiaw-Kwasie et al., 2017; Gazzola et al., 2021; Plaisance, 2023; Tišma et al., 2022), due prospettive si rilevano particolarmente significative nel contesto di questo contributo.
La prima valorizza il coinvolgimento degli stakeholder come leva per validare la rilevanza e la materialità degli outcome considerati (Antadze et al., 2012; Gibbon et al., 2011; Ricciuti et al., 2019; Santos et al., 2021). In particolare, Costa e Pesci (2016) propongono un approccio ispirato alla multiple-constituency theory, evidenziando come la misurazione dell’impatto sociale debba essere co-costruita attraverso il dialogo con i portatori di interesse, i quali esprimono bisogni informativi differenziati e situati, superando così approcci unilaterali e autoreferenziali.
La seconda prospettiva propone invece un’evoluzione concettuale dell’impatto, orientandolo verso una lettura ecosistemica. Hervieux et al. (2019), in particolare, invitano a concepire l’impatto sociale come esito di processi sistemici emergenti dalle interazioni tra attori sociali operanti all’interno di arene partecipate. In tale visione, il coinvolgimento degli stakeholder non rappresenta soltanto una scelta metodologica auspicabile, ma costituisce una componente strutturale della valutazione, poiché è attraverso le relazioni e le dinamiche partecipative che l’impatto prende forma e diviene osservabile. Tale visione appare connessa in modo coerente con quanto discusso nella precedente sezione, dove si è proposto di superare la rappresentazione lineare della generazione dell’impatto in favore di una logica sistemica ed ecologica. Se l’impatto non si configura come effetto diretto e deterministico delle attività svolte, ma come risultato emergente di relazioni adattive, allora è proprio nel coinvolgimento attivo degli stakeholder e nella comprensione della qualità delle interazioni che può risiedere la chiave interpretativa dei cambiamenti generati.
Volgendo infine lo sguardo alla relazione tra enti finanziatori ed enti finanziati, le riflessioni sin qui elaborate consentono di delineare ulteriori prospettive di sviluppo. In una logica trasformativa, tale relazione potrebbe auspicabilmente evolvere verso forme più collaborative, fondate sul coinvolgimento attivo degli stakeholder territoriali nella co-costruzione di processi valutativi. Ciò implicherebbe il superamento di approcci centrati sulla rendicontazione di metriche predefinite unilateralmente, a favore di pratiche valutative capaci di accompagnare sia la definizione che l’evoluzione dell’azione collettiva. Una tale funzione si concretizza, ad esempio, attraverso l’implementazione congiunta di percorsi continuativi di lettura del contesto territoriale e la negoziazione progressiva di framework valutativi affinché questi mantengano nel tempo coerenza e adeguatezza rispetto ai bisogni, alle specificità e alle aspirazioni delle comunità coinvolte. Tali pratiche, già richiamate nella riflessione sul ruolo strategico della VIS, risultano inoltre cruciali per rafforzarne la dimensione dialogica e co-interpretativa, laddove l’impatto emerga come costruzione relazionale, e non come semplice effetto programmato. Per rendere effettiva questa transizione verso forme valutative co-costruite, risulta tuttavia essenziale promuovere percorsi di capacity building condivisi, volti a rafforzare le competenze delle organizzazioni coinvolte. Tali capacità rappresentano condizioni abilitanti per l’emergere di una cultura della valutazione realmente partecipata dagli stakeholder di riferimento e capace di configurarsi come leva di apprendimento e riorientamento dell’agire collettivo, piuttosto che ridursi a mero strumento di controllo finalizzato alla sola gestione delle risorse.
Conclusioni
Il percorso fin qui tracciato ha inteso esplorare, in primo luogo, le possibili condizioni di integrazione strategica della VIS all’interno delle organizzazioni, mettendone in luce la natura riflessiva, trasformativa e istituzionalmente situata. Piuttosto che configurarsi come un mero esercizio tecnico, la VIS appare sempre più come una pratica che intreccia dimensioni valutative, processi di apprendimento e strumenti di orientamento strategico, contribuendo alla definizione e al governo delle scelte che plasmano la direzione complessiva dell’azione organizzativa. Tale intreccio, come si è cercato di mettere in luce nel corso dell’analisi, riveste un significato particolarmente rilevante per le imprese sociali e gli enti del Terzo Settore, la cui stessa genesi istituzionale è orientata al perseguimento di obiettivi di impatto, entro un assetto in cui la sostenibilità economica si configura come strumento e l’impatto come riferimento guida dell’agire organizzativo. Per queste realtà, infatti – a differenza delle imprese for profit, che pongono tradizionalmente il profitto come fine e non come mezzo – non è sufficiente adottare strumenti di controllo strategico ancorati esclusivamente a logiche di efficienza operativa o produttiva. È piuttosto necessario dotarsi di dispositivi e processi – come quelli connessi alla VIS – capaci di orientare in modo sistematico l’analisi e la comprensione dei cambiamenti generati, o che si vorrebbero generare, nei contesti di riferimento. Perché tale potenziale possa effettivamente dispiegarsi, tuttavia, è necessario che la VIS non sia più concepita come pratica occasionale o funzione collaterale, ma venga assunta come dimensione culturale dell’organizzazione, spostandosi dall’applicazione su singoli progetti verso un orizzonte che la integri stabilmente nel sistema di linguaggi, significati e visioni condivise all’interno delle organizzazioni, sino a configurarsi come un modo di pensare naturalmente strategico, in linea con quanto discusso nei paradigmi più evoluti dell’impact management.
Abbracciando tale prospettiva, il contributo ha quindi individuato e approfondito tre tensioni concettuali che attraversano in profondità i dibattiti teorici e le pratiche organizzative, configurandosi come snodi critici attorno ai quali si gioca la possibilità di un uso più consapevole, strategico e trasformativo della VIS. Da un lato, è emersa la necessità di un chiaro impegno da parte delle organizzazioni nel transitare da una logica di rendicontazione centrata sulle realizzazioni a una logica orientata ai cambiamenti e alle trasformazioni sociali che si mira a realizzare sul territorio. Dall’altro, sono state evidenziate le sfide connesse al superamento di approcci sequenziali o meccanicistici, in favore di paradigmi capaci di accogliere la complessità, la non linearità e la dimensione relazionale dei processi di cambiamento. Infine, è stato sottolineato come il grado di coinvolgimento degli stakeholder nei processi valutativi non rappresenti un elemento residuale, ma un indicatore sostanziale della capacità dell’organizzazione di costruire senso condiviso, legittimità e apprendimento diffuso attorno agli esiti della propria azione.
Pur nella consapevolezza delle difficoltà che l’esplorazione di tali nodi concettuali inevitabilmente comporta – in particolare rispetto alla questione della causalità e della non linearità nei processi di cambiamento che si vorrebbero generare ed osservare – rinunciare ad affrontarle significherebbe depotenziare l’intero impianto del controllo strategico, privandolo di una componente essenziale per la comprensione e il governo dell’agire trasformativo di queste organizzazioni. Le tensioni evidenziate non costituiscono dunque ostacoli da eludere, ma dimensioni strutturali con cui è necessario misurarsi, proprio in virtù della natura e degli obiettivi delle imprese sociali e degli enti del Terzo Settore, e in reazione a una lettura riduzionista dell’impatto come mero “effetto” da attribuire a un intervento. In questa direzione, si aprono almeno due traiettorie di riflessione. La prima riguarda il contributo che la ricerca futura è chiamata a offrire, affinando modelli teorici e strumenti operativi in grado di tradurre – senza semplificazioni riduttive – la complessità in pratiche valutative efficaci e pertinenti, capaci di coniugare rigore metodologico e sostenibilità organizzativa, con l’obiettivo di accrescere il valore d’uso delle evidenze prodotte. La seconda chiama in causa le capacità organizzative necessarie a valorizzare evidenze anche non perfettamente formalizzate, ovvero la necessità di sviluppare competenze critiche e riflessive per interpretare i dati in chiave strategica, integrandoli nei processi decisionali in modo consapevole e contestualizzato.
Riconoscimenti
Ente finanziatore: progetto finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU – Piano Nazionale Resistenza e Resilienza (PNRR) - Missione 4, Componente 2, Investimento 3.3 – D.R. 607/2023 del 14/06/2023 UNIVPM. Award Number: 39-033-01-DOT1301919-9355. Decreto 117/2023 Ministero dell’Università e della Ricerca. CUP I32B23001240007. Titolo progetto: "Ecosistemi di innovazione: il social impact assessment come strumento di reporting e di apprendimento organizzativo per la pianificazione strategica”.
Bibliografia
Agarchand, N., & Laishram, B. (2017). Sustainable infrastructure development challenges through PPP procurement process: Indian perspective. International Journal of Managing Projects in Business, 10(3), 642–662. doi: 10.1108/IJMPB-10-2016-0078
Alinaghian, L., & Razmdoost, K. (2021). How do social enterprises manage business relationships? A review of the literature and directions for future research. Journal of Business Research, 136, 488–498. doi: 10.1016/j.jbusres.2021.08.003
Alomoto, W., Niñerola, A., & Pié, L. (2022). Social Impact Assessment: A Systematic Review of Literature. Social Indicators Research, 161(1), 225–250. doi: 10.1007/s11205-021-02809-1
Antadze, N., & Westley, F. R. (2012). Impact Metrics for Social Innovation: Barriers or Bridges to Radical Change? Journal of Social Entrepreneurship, 3(2), 133–150. doi: 10.1080/19420676.2012.726005
Antonie, R. (2012). Introducing a model for social impact assessment of public administration reform in Romania. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 36E, 5–12. Retrieved from www.iaia.org
Arce-Gomez, A., Donovan, J. D., & Bedggood, R. E. (2015). Social impact assessments: Developing a consolidated conceptual framework. In Environmental Impact Assessment Review (Vol. 50, pp. 85–94). Elsevier Inc. doi: 10.1016/j.eiar.2014.08.006
Arvidson, M., & Lyon, F. (2014). Social Impact Measurement and Non-profit Organisations: Compliance, Resistance, and Promotion. Voluntas, 25(4), 869–886. doi: 10.1007/s11266-013-9373-6
Bagnoli, L. (2009). Performance measuring in social enterprises. 2nd EMES International Conference on Social Enterprise.
Barbetta, G. P. (2020). Sono utili gli interventi sociali? Impresa Sociale, 4, 21–26.
Barinaga, E. (2023). From Evaluation to Valorising: Three Moments in the Making of Social Impact Value. Journal of Social Entrepreneurship. doi: 10.1080/19420676.2023.2262158
Battilana, J., & Lee, M. (2014). Advancing research on hybrid organizing–Insights from the study of social enterprises. Academy of Management Annals, 8(1), 397–441.
Becker, H. A. (2001). Social impact assessment. European Journal of Operational Research, 128, 311–321. Retrieved from www.elsevier.com/locate/dsw
Behn, R. D. (2003). Why Measure Performance? Different Purposes Require Different Measures. In Public Administration Review (Vol. 63, Issue 5, pp. 586–606). Blackwell Publishing Ltd. doi: 10.1111/1540-6210.00322
Burdge, R. J. (2003a). Benefiting from the practice of social impact assessment. Impact Assessment and Project Appraisal, 21(3), 225–229. doi: 10.3152/147154603781766284
Burdge, R. J. (2003b). The practice of social impact assessment background. Impact Assessment and Project Appraisal, 21(2), 84–88. doi: 10.3152/147154603781766356
Burkett, I., & Mcneill, J. (2017). Measuring the Impact of Social Procurement: A New Approach.
Campbell, M., McKenzie, J. E., Sowden, A., Katikireddi, S. V., Brennan, S. E., Ellis, S., Hartmann-Boyce, J., Ryan, R., Shepperd, S., Thomas, J., Welch, V., & Thomson, H. (2020). Synthesis without meta-analysis (SWiM) in systematic reviews: Reporting guideline. The BMJ, 368. doi: 10.1136/bmj.l6890
Cecchini Manara, V., Sacconi, L., & Faillo, M. (2025). Il finanziamento dell’impresa sociale. Un’analisi sperimentale sui limiti della finanza d’impatto. Impresa Sociale, 1, 64–71. doi: 10.7425/IS.2025.01.08
Corvo, L., Pastore, L., Mastrodascio, M., & Cepiku, D. (2022). The social return on investment model: a systematic literature review. In Meditari Accountancy Research (Vol. 30, Issue 7, pp. 49–86). Emerald Group Holdings Ltd. doi: 10.1108/MEDAR-05-2021-1307
Costa, E., & Pesci, C. (2016). Social impact measurement: why do stakeholders matter? Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 7(1), 99–124. doi: 10.1108/SAMPJ-12-2014-0092
David, F. R. (2011). Strategic management concepts and cases. Prentice hall.
De Benedictis, L., Miccolis, S., Venturi, P., & Zamagni, S. (2023). La prospettiva civile dell’impatto sociale.
Denny-Smith, G., Williams, M., & Loosemore, M. (2020). Assessing the impact of social procurement policies for Indigenous people. Construction Management and Economics, 1139–1157. doi: 10.1080/01446193.2020.1795217
Depedri, S. (2020). La valutazione dell’impatto sociale. Farla divenire uno strumento utile. Impresa Sociale, 4, 12–20. doi: 10.7425/IS.2020.04.03
Dufour, B. (2019). Social impact measurement: What can impact investment practices and the policy evaluation paradigm learn from each other? Research in International Business and Finance, 47, 18–30. doi: 10.1016/j.ribaf.2018.02.003
Ebrahim, A., Rangan, V. K., & Ebrahim, R. (2010). The Limits of Nonprofit Impact: A Contingency Framework for Measuring Social Performance (Working Paper No. 10-099).
Erdiaw-Kwasie, M. O., Alam, K., & Kabir, E. (2017). Modelling Corporate Stakeholder Orientation: Does the Relationship Between Stakeholder Background Characteristics and Corporate Social Performance Matter? Business Strategy and the Environment, 26(4), 465–479. doi: 10.1002/bse.1930
Esteves, A. M., Franks, D., & Vanclay, F. (2012). Social impact assessment: The state of the art. Impact Assessment and Project Appraisal, 30(1), 34–42. doi: 10.1080/14615517.2012.660356
Esteves, A. M., & Vanclay, F. (2009). Social Development Needs Analysis as a tool for SIA to guide corporate-community investment: Applications in the minerals industry. Environmental Impact Assessment Review, 29(2), 137–145. doi: 10.1016/j.eiar.2008.08.004
Feor, L., Clarke, A., & Dougherty, I. (2023). Social Impact Measurement: A Systematic Literature Review and Future Research Directions. World, 4(4), 816–837. doi: 10.3390/world4040051
Gallou, E., & Fouseki, K. (2019). Applying social impact assessment (SIA) principles in assessing contribution of cultural heritage to social sustainability in rural landscapes. Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, 9(3), 352–375. doi: 10.1108/JCHMSD-05-2018-0037
Gatti, M., & Chiucchi, M. S. (2021). Controllo di gestione. Strutture, processi, misurazioni. G. Giappichelli Editore.
Gazzola, P., Amelio, S., Papagiannis, F., & Michaelides, Z. (2021). Sustainability reporting practices and their social impact to NGO funding in Italy. Critical Perspectives on Accounting, 79. doi: 10.1016/j.cpa.2019.04.006
Gentile, M. C. (2002). Social impact management and social enterprise: Two sides of the same coin or a totally different currency? [The Aspen Institute - Business and Society Program]. Retrieved from www.CasePlace.org
Gibbon, J., & Dey, C. (2011). Developments in social impact measurement in the third sector: Scaling up or dumbing down? Social and Environmental Accountability Journal, 31(1), 63–72. doi: 10.1080/0969160X.2011.556399
Giovando, G., Mangialardo, A., Sorano, E., & Sardi, A. (2021). Impact assessment in not-for-profit organizations: The case of a foundation for the development of the territory. Sustainability (Switzerland), 13(17). doi: 10.3390/su13179755
Grange, A. Le, & Maas, G. (2023). Social Enterprises Impact Assessment: Exploring Alternative Measuring Frameworks. Event Management, 27(8), 1199–1217. doi: 10.3727/152599523X16830662072053
Grant, M. J., & Booth, A. (2009). A typology of reviews: An analysis of 14 review types and associated methodologies. Health Information and Libraries Journal, 26(2), 91–108. doi: 10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x
Grieco, C. (2018). What do social entrepreneurs need to walk their talk? Understanding the attitude–behavior gap in social impact assessment practice. Nonprofit Management and Leadership, 29(1), 105–122. doi: 10.1002/nml.21310
Guter-Sandu, A. (2023). Accounting infrastructures and the negotiation of social and economic returns under financialization: The case of impact investing. Competition and Change, 27(1), 205–223. doi: 10.1177/10245294221085636
Hebb, T., & Hachigian, H. (2017). Social value procurement and evaluation - A Global Review and Assessment of Social Value Procurement.
Hehenberger, L., & Buckland, L. (2023). How impact measurement fosters the social economy: From measurement of impact to learning and management for impact. In Social Economy Science: Transforming the Economy and Making Society More Resilient (pp. 138–166). Oxford University Press. doi: 10.1093/oso/9780192868343.003.0007
Hehenberger, L., Buckland, L., & Gold, D. (2020). From Measurement of Impact to Learning for Impact: European Charitable Foundations’ Learning Journeys. Retrieved from www.vansterandlei.com
Hervieux, C., & Voltan, A. (2019). Toward a systems approach to social impact assessment. Social Enterprise Journal, 15(2), 264–286. doi: 10.1108/SEJ-09-2018-0060
Hoos, F. (2022). Showing off or showing impact? The joint signalling effect of reputation and accountability on social entrepreneurs’ crowdfunding success. Management Accounting Research, 54. doi: 10.1016/j.mar.2021.100778
Hulgård, L., & Ferreira, S. (2013). Social innovation and public policy. In The International Handbook on Social Innovation: Collective Action, Social Learning and Transdisciplinary Research. Edward Elgar Publishing.
Jäger, U. P., & Rothe, M. D. (2013). Multidimensional Assessment of Poverty Alleviation in a Developing Country: A Case Study on Economic Interventions. In Nonprofit Management and Leadership (Vol. 23, Issue 4, pp. 511–528). doi: 10.1002/nml.21077
Kabir, Z. (2021). The Role of Social Impact Assessment (SIA) in the Development of a Mine Closure Plan in Regional Australia. Journal of Environmental Assessment Policy and Management, 23(3–4). doi: 10.1142/S1464333222500156
Kah, S., & Akenroye, T. (2020). Evaluation of social impact measurement tools and techniques: a systematic review of the literature. In Social Enterprise Journal (Vol. 16, Issue 4, pp. 381–402). Emerald Group Holdings Ltd. doi: 10.1108/SEJ-05-2020-0027
Kato, S. (2021). Social performance measurement adoption in nascent social enterprises: Refining the institutional model. Journal of Business Venturing Insights, 15. doi: 10.1016/j.jbvi.2021.e00244
Krlev, G., Wruk, D., Pasi, G., & Bernhard, M. (2023). Social Economy Science. Transforming the Economy and Making Society More Resilient (Oxford University Press, Ed.).
Kubickova, K. (2021). Drivers of Strategic Approach to Philanthropy in the Czech Republic. Central European Management Journal, 29(3), 86–113. doi: 10.7206/cemj.2658-0845.55
Lall, S. (2017). Measuring to Improve Versus Measuring to Prove: Understanding the Adoption of Social Performance Measurement Practices in Nascent Social Enterprises. Voluntas, 28(6), 2633–2657. doi: 10.1007/s11266-017-9898-1
Laudisa, F. (2012). Causalità. APhEx - Giornale Italiano Di Filosofia Analitica.
Lowe, T., & Wilson, R. (2017). Playing the Game of Outcomes-based Performance Management. Is Gamesmanship Inevitable? Evidence from Theory and Practice. Social Policy and Administration, 51(7), 981–1001. doi: 10.1111/spol.12205
Maas, K. (2009). Corporate Social Performance From Output Measurement to Impact Measurement. Retrieved from www.b-en-t.nl
Mahmoudi, H., Renn, O., Vanclay, F., Hoffmann, V., & Karami, E. (2013). A framework for combining social impact assessment and risk assessment. Environmental Impact Assessment Review, 43, 1–8. doi: 10.1016/j.eiar.2013.05.003
Mair, J., & Martí, I. (2006). Social entrepreneurship research: A source of explanation, prediction, and delight. Journal of World Business, 41(1), 36–44. doi: 10.1016/j.jwb.2005.09.002
Miller, E., Buys, L., & Summerville, J. A. (2007). Quantifying the Social Dimension of Triple Bottom Line: Development of a Framework and Indicators to Assess the Social Impact of Organisations. International Journal of Governance & Business Ethics, 3. Retrieved from http://eprints.qut.edu.au
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. (2019a). Decreto Ministeriale 4 luglio 2019 – Linee guida bilancio sociale ETS.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. (2019b). Decreto Ministeriale 23 luglio 2019 – Linee guida valutazione impatto sociale ETS.
Molecke, G., & Pinkse, J. (2017). Accountability for social impact: A bricolage perspective on impact measurement in social enterprises. Journal of Business Venturing, 32(5), 550–568. doi: 10.1016/j.jbusvent.2017.05.003
Moura, L. F., Lima, E. P., Deschamps, F., Van Aken, E., da Costa, S. E. G., Duarte, R., & Kluska, R. A. (2022). What Role Do Design Factors Play in Applying Performance Measurement Systems in Nonprofit Organizations? Administrative Sciences, 12(2). doi: 10.3390/admsci12020043
Muñoz, P., & Gamble, E. N. (2020). Impact measurement in an emerging social sector: four novel approaches. Academy of Management Discoveries.
Nguyen, L., Szkudlarek, B., & Seymour, R. G. (2015). Social impact measurement in social enterprises: An interdependence perspective. Canadian Journal of Administrative Sciences, 32(4), 224–237. doi: 10.1002/cjas.1359
Nicholls, A., Nicholls, J., & Paton, R. (2015). Measuring social impact. In Social Finance (pp. 253–281). Oxford University Press Oxford.
Nuchian, N., Biju, A. V. N., & Reddy, K. (2024). An investigation on social impact performance assessment of the social enterprises: Identification of an ideal social entrepreneurship model. Business Strategy and Development, 7(1). doi: 10.1002/bsd2.305
OECD. (2021). Private Philanthropy for Development – Second Edition: Data for Action. OECD. doi: 10.1787/cdf37f1e-en
OECD, & European Union. (2024). Local Economic and Employment Development (LEED) Measure, Manage and Maximise Your Impact. A Guide for the social economy.
OECD Global Action. (2021). Social Impact measurement for the Social and Solidarity Economy. Retrieved from www.oecd.org.
Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., … Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. Systematic Reviews, 10(1). doi: 10.1186/s13643-021-01626-4
Papulova, Z., & Gazova, A. (2016). Role of Strategic Analysis in Strategic Decision-Making. Procedia Economics and Finance, 39, 571–579. doi: 10.1016/s2212-5671(16)30301-x
Plaisance, G. (2023). Evaluation in nonprofit organizations: A defense of perception as a managerial and scientific tool. Journal of Philanthropy and Marketing, 28(4). doi: 10.1002/nvsm.1807
Polonsky, M. J., Landreth Grau, S., & McDonald, S. (2016). Perspectives on social impact measurement and non-profit organisations. Marketing Intelligence and Planning, 34(1), 80–98. doi: 10.1108/MIP-11-2014-0221
Rawhouser, H., Cummings, M., & Newbert, S. L. (2019). Social Impact Measurement: Current Approaches and Future Directions for Social Entrepreneurship Research. Entrepreneurship: Theory and Practice, 43(1), 82–115. doi: 10.1177/1042258717727718
Repubblica Italiana. (2017). Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 – Codice del Terzo Settore.
Ricciuti, E., & Bufali, M. V. (2019). The health and social impact of Blood Donors Associations: A Social Return on Investment (SROI) analysis. Evaluation and Program Planning, 73, 204–213. doi: 10.1016/j.evalprogplan.2019.01.003
Ricciuti, E., & Calò, F. (2018). Are foundations assessing their impact? Concepts, methods and barriers to social impact assessment in Italian foundations. International Review on Public and Nonprofit Marketing, 15(4), 553–574. doi: 10.1007/s12208-018-0213-7
Rosenzweig, W. (2004). Double Bottom Line Project Report: Assessing Social Impact In Double Bottom Line Ventures. Retrieved from https://escholarship.org/uc/item/80n4f1mf
Rowan, M. (2017). Aligning resettlement planning and livelihood restoration with social impact assessment: a practitioner perspective. Impact Assessment and Project Appraisal, 35(1), 81–93. doi: 10.1080/14615517.2016.1271541
Sanfeliu, B. C., Cervelló Royo, R., & Moya Clemente, I. (2013). Measuring performance of social and non-profit Microfinance Institutions (MFIs): An application of multicriterion methodology. Mathematical and Computer Modelling, 57(7–8), 1671–1678. doi: 10.1016/j.mcm.2011.11.010
Santos, J., Dias, Á., Costa, R. L. Da, Santos, R., & Pereira, L. (2021). Benefits realisation management: social impact analysis. International Journal of Learning and Change, 1(1), 1. doi: 10.1504/ijlc.2021.10039673
Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 104, 333–339. doi: 10.1016/j.jbusres.2019.07.039
Stame, N. (2020). Valutazione d’impatto sociale. Committenti, Enti di Terzo Settore e valutatori. Impresa Sociale, 4, 53–59. doi: 10.7425/IS.2020.04.09
Tišma, S., Uzelac, A., Jelinčić, D. A., Franić, S., & Mileusnić Škrtić, M. (2022). Overview of Social Assessment Methods for the Economic Analysis of Cultural Heritage Investments. Journal of Risk and Financial Management, 15(8). doi: 10.3390/jrfm15080327
Tomasin, P. (2024). La valutazione d’impatto sociale nella co-progettazione. Impresa Sociale, 4, 93–100. doi: 10.7425/IS.2024.03.10
Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a Methodology for Developing Evidence-Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review. British Journal of Management, 14(3), 207–222. doi: 10.1111/1467-8551.00375
Valutare la valutazione. Opinioni a confronto. (2020). Impresa Sociale, 4, 1–104.
van Rijn, M., Raab, J., Roosma, F., & Achterberg, P. (2021). To Prove and Improve: An Empirical Study on Why Social Entrepreneurs Measure Their Social Impact. Journal of Social Entrepreneurship, 15(2), 494–516. doi: 10.1080/19420676.2021.1975797
Vanclay, F. (2003). International principles for social impact assessment. Impact Assessment and Project Appraisal, 21(1), 5–12. doi: 10.3152/147154603781766491


