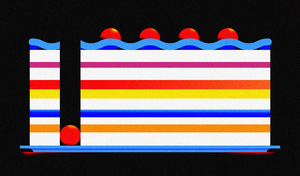
Numero 3 / 2025
Le imprese sociali, le politiche, gli strumenti
Redazione
Il numero 3/2025 di Impresa Sociale si sviluppa su tre differenti sezioni: le imprese sociali, le politiche, gli strumenti.
La prima sezione offre alcune riflessioni sull’impresa sociale, in particolare analizzando, seppure in modo parziale e non sistematico, alcune sfide di cambiamento.
Il punto di partenza è rappresentato dal contributo di Campedelli che evidenzia la necessità di comprendere le molteplici transizioni - digitale, ambientale, politica, economica, demografica, sanitaria e del welfare - che stiamo attraversando, le discontinuità che esse comportano per tracciare degli scenari possibili e definire in modo consapevole strategie di sviluppo per le imprese sociali; in sostanza, si tratta di pensare all’evoluzione delle imprese sociali nei prossimi anni a partire dall’analisi del diverso contesto in cui saranno chiamate ad operare. I quattro articoli che seguono rappresentano altrettanti ambiti concreti in cui le imprese sociali stanno esplorando queste frontiere di cambiamento.
Il primo, a firma di Semeraro e Croce, sviluppa il tema del cambio di prospettiva introdotto dal d.lgs. 62/2024 che riforma in modo radicale l’approccio verso le persone con disabilità, prevedendo il diritto per ciascuno alla definizione di un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato. Questo richiede un significativo cambio di mentalità e di organizzazione delle imprese sociali, chiamate a passare dall'erogazione di prestazioni definite alla co-costruzione di interventi flessibili e su misura per ogni persona. L’articolo individua e analizza specifiche aree tematiche in cui il nuovo approccio comporta la necessità di ripensare aspetti economici e organizzativi delle imprese sociali, così da individuare strade adeguate e giocare un ruolo trasformativo, anziché rincorrere con fatica il cambiamento.
Nel secondo articolo Busacca, Buzzao, Lovato e Tubaro espongono gli esiti di una ricerca empirica realizzata in Veneto, relativa all’atteggiamento delle imprese sociali di fronte alle tecnologie. Gli autori si chiedono quali siano i fattori - aspettative di risultato, sforzo per l'introduzione, influenze sociali e altre condizioni – che ostacolano o favoriscono l’intenzione d’uso da parte degli ETS di nuove tecnologie, soffermandosi, in questa fase, in particolare sull’utilizzo dell'intelligenza artificiale e delle piattaforme di crowdfunding.
Dal Veneto alla Sicilia, Saladino propone gli esiti di una ricerca empirica che riguarda un altro ambito in cui le imprese sociali possono giocare un esito trasformativo, quello del rilancio delle aree interne. La ricerca infatti riguarda le cooperative di comunità siciliane e come esse, combinando impresa e partecipazione, contribuiscono alla rigenerazione socioeconomica dei territori e si interroga sulle politiche di sostegno e le strategie collaborative che possono consolidare e diffondere queste esperienze.
Ha una base empirica anche l’ultimo articolo di questa sezione, proposto da Andorlini e Bongiovanni. Si tratta della sintesi del lavoro svolto dall’Osservatorio sulla prossimità realizzato nell’ambito della Biennale della Prossimità, che giunge ora alla VI edizione. A partire da sedici studi di caso, sono ricostruiti gli aspetti trasversali che accomunano le pratiche di prossimità, dai modelli organizzativi alla valutazione di impatto, alle competenze, fino alle indicazioni per ETS e pubbliche amministrazioni per costruire un ecosistema di prossimità.
La seconda sezione della rivista riguarda le politiche e il modo in cui esse si intrecciano con i percorsi delle imprese sociali.
Il tema è aperto dalla riflessione di Fazzi, Datres e Scardella, e costituisce una riflessione a partire da un’esperienza di coprogrammazione sulla domiciliarità che gli autori hanno guidato a Trento. Emerge come il solo confronto tra operatori pubblici e di Terzo settore rischia di non superare la dipendenza da percorso e quindi la tendenza a ripetere l’assetto dei servizi già noto e sperimentato; al contrario, l'ascolto dei beneficiari e delle loro famiglie apre invece alla possibilità di concepire interventi innovativi.
Segue il contributo di Santuari, che prende a pretesto una sentenza del TAR Sicilia per ripercorrere le norme del Codice dei Contratti pubblici che riconoscono le specificità delle cooperative sociali e dei settori, welfare e l'inserimento lavorativo, dove esse operano. Ne emerge un quadro che evidenzia, pur tra alcune timidezze normative, il riconoscimento della funzione sociale delle cooperative sociali.
L’ultimo articolo della sezione è di Bernardoni e Ferrucci che fanno il punto sulle politiche che il nostro paese ha adottato per favorire l’occupazione dei lavoratori svantaggiati passando in rassegna le norme sul collocamento obbligatorio, la legislazione sulle cooperative sociali, il collocamento mirato, l’art. 14 della cosiddetta "Legge Biagi" e quindi la relazione tra imprese for profit e cooperative sociali e infine i contratti riservati, con un approfondimento sulla recente legislazione umbra in materia.
La terza sezione è relativa agli strumenti che accompagnano le imprese sociali e le politiche.
Nel primo articolo Sedehi e Moretto elaborano una proposta, oggetto di sperimentazioni concrete da parte degli autori nella loro attività di supporto a imprese sociali, per sviluppare il Business Model Canvas combinando i quadri classici di questo modello con gli obiettivi di sostenibilità e considerando l'impresa in logica sistemica all'interno di una rete di stakeholder. Si tratta di una revisione del BMI che pare coerente con la fase di transizione che stiamo percorrendo.
Ronchini, a partire da una review delle pubblicazioni scientifiche, riflette sulla Valutazione di Impatto Sociale. Senza nascondere le tensioni concettuali che attraversano questo tema, più volte sviluppate nelle pagine di Impresa Sociale, l’autore evidenzia come la VIS vada considerata come leva strategica per sostenere l'azione trasformativa delle imprese sociali, chiamate a sviluppare un uso critico delle evidenze valutative e a fare propria una cultura orientata all’apprendimento.
Dopo queste tre sezioni, il numero è chiuso da un contributo di Scalvini – con un breve intervento anche di Musella – in cui si ripercorre il percorso di IRIS Network, per molti anni editore di questa rivista e tra i protagonisti negli ultimi due decenni della riflessione che ha portato al progressivo riconoscimento dell’impresa sociale nel nostro paese. Oggi IRIS termina la sua attività, ma quanto esso ha portato avanti – e in primo luogo Impresa Sociale – rimane come patrimonio capace di svilupparsi e accompagnare, come si è cercato di fare in questo numero, i processi trasformativi in cui le imprese sociali sono immerse.


