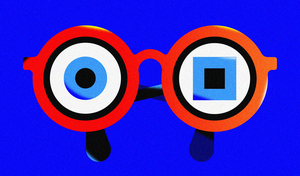
Numero 3 / 2025
Dare voce ai bisogni: l’esperienza della co-programmazione sulla domiciliarità in provincia di Trento
Luca Fazzi, Sara Datres, Francesca Scardella
Introduzione
Da diversi anni ha preso forma l’idea che le politiche del welfare locale debbano essere co- progettate e co-costruite da pubblico e terzo settore. Dopo essere stata inaugurata con la legge 285/97 (Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza) e con la 328/00 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), l’idea della coprogettazione dei programmi del welfare locale sembrava essere finita in sordina. Con l’approvazione del Codice del terzo settore nel 2017 invece si è aperta una nuova stagione partecipativa che trova la sua compiuta espressione nell’art. 55 che introduce gli istituti della co-programmazione e della co-progettazione (De Ambrogio e Marocchi, 2023; Borzaga et al. 2023). I due dispositivi - uno orientato alla definizione di obiettivi e priorità e l’altro alla concreta progettazione operativa degli interventi - si fondano sul principio della collaborazione tra pubblico e terzo settore nei diversi passaggi di attuazione dei procedimenti (Frediani, 2021).
Mentre per quanto riguarda il terzo settore l’obiettivo del coinvolgimento da parte della nuova normativa è esplicito, al riguardo del ruolo dei cittadini, degli utenti e delle famiglie, la discussione è caratterizzata da più elevati livelli di ambiguità. Ciò che viene dato per acquisito, soprattutto nella giurisprudenza successiva al 2017 (si pensi alla sentenza 131/2020 della Corte costituzionale che riconosce la legittimità del sistema collaborativo come alternativa ordinaria agli appalti), è che il terzo settore sia di per sé un insieme di enti vicini ai bisogni e capaci di intercettare e leggere il territorio con le sue connotazioni sociali e culturali. Partendo da questo principio a cascare i processi di costruzione delle politiche e degli interventi sono istituiti attraverso procedure che non prendono in considerazione l’attivazione e il coinvolgimento dei cittadini assumendo che gli enti di terzo settore in quanto tali incorporino già le loro preferenze e bisogni.
Il coinvolgimento di cittadini, utenti e famigliari rappresenta una sfida molto importante per la costruzione di nuove risposte del welfare locale, ma risulta di non facile attuazione per una serie di motivi correlati, richiamando la complessità dell'applicazione dei processi di innovazione, dal punto di vista amministrativo, giuridico e di contenuto, che derivano da un quadro di riferimento di non facile lettura e attuazione, condizionato anche dalle prassi in uso e alla resistenza al cambiamento.
Il dibattito sulla partecipazione di cittadini e utenti negli ultimi due decenni ha mostrato come la voce e il vissuto di cittadini e utenti non è un optional per il rinnovamento delle politiche del welfare locale, ma rappresenta un antidoto molto importante alla path dependance e alla tendenza a mantenere il focus sull’offerta dei servizi esistente che soprattutto nei momenti di scarsità di risorse diventa una strategia per garantire la sopravvivenza degli enti erogatori dei servizi (Neshkova e Guo, 2012). I cittadini e gli utenti non sono mere appendici del sistema dei servizi. Essi sono al contrario detentori di conoscenze e portatori di esperienze vitali per garantire che i servizi diventino obsoleti e inefficienti di fronte al cambiamento (Nicholas e Tua, 2017; Kurki et al. 2024). Inoltre, il coinvolgimento dei cittadini e degli utenti è considerato da molti essere un fondamento della base democratica delle politiche pubbliche (Brandsen et al. 2018). Le nuove evidenze teoriche ed empiriche sulla partecipazione indicano inoltre come non sia necessario per favorire il coinvolgimento di cittadini e utenti la mobilitazione di risorse economiche e organizzative straordinarie e si possa lavorare efficacemente anche con investimenti molto modesti e sostenibili.
Il presente articolo si propone di descrivere e analizzare l’applicazione degli strumenti dell’art. 55 in una prospettiva di coinvolgimento dei cittadini e degli utenti nell’ambito delle politiche per la domiciliarità in provincia di Trento.
Collaborazione e partecipazione
La stagione della collaborazione sancita con l’approvazione del Codice del terzo settore ha superato la fase della sperimentazione e l’uso in particolare della co-progettazione è ormai ampiamente diffuso, soprattutto nelle regioni del nord e centro Italia (Boschetti et al. 2024). La letteratura empirica, nonostante siano trascorsi quasi otto anni dal via libera alla riforma, è tuttavia ancora abbastanza limitata e al suo interno si possono riconoscere due principali filoni: quello consulenziale prodotto da professionisti impegnati in attività sul campo focalizzato soprattutto sulla descrizione di best practices (Stanghellini e colleghi, 2025) e quello più scientifico che mira a abbracciare una più ampia gamma di esperienze e ad analizzare i processi in chiave critico interpretativa (Borzaga e colleghi, 2024; Guarna e Maino, 2024). Il secondo filone di ricerca parte dall’assunto che è rischioso maturare un atteggiamento poco critico e poco attento alle dinamiche che caratterizzano sul piano di realtà i rapporti tra pubblico e terzo settore e mette in luce oltre ai possibili vantaggi anche una serie di tensioni che accompagnano l’introduzione dei nuovi strumenti amministrativi. Tali elementi di fatica o criticità sono collegabili principalmente alla cosiddetta dipendenza dal percorso, ovvero alla difficoltà di sganciare le nuove procedure dagli obiettivi e dalle logiche consolidate di affidamento dei servizi in cui prevalgono come elementi centrali la pressione sui costi, gli approcci selettivi e difensivi e il controllo burocratico delle procedure (Fazzi, 2023). Un aspetto particolarmente delicato dell’applicazione dell’art 55 concerne la presunta maggiore capacità degli strumenti collaborativi di valorizzare la vicinanza ai bisogni e la capacità di lettura delle problematiche sociali da parte degli enti di terzo settore. Come ribadito dalla sentenza 131/2020 della Corte costituzionale il terzo settore è meritevole di un trattamento che giustifica l’esenzione dal regime competitivo di affidamento dei servizi in forza, tra il resto, della più efficace capacità di lettura dei bisogni e dei risparmi ad essi associati in termini di aumento dell’efficacia degli interventi. Perché gli enti di terzo settore dovrebbero essere in grado di comprendere i bisogni in modo migliore rispetto ad altri soggetti è un interrogativo a cui gli studi faticano a offrire una risposta. Nella letteratura classica sul terzo settore risalente agli anni ‘80 e ai primi ’90, l’elemento peculiare di queste organizzazioni è fatto risalire alle motivazioni allo start-up che si basano sulla volontà di dare risposta a bisogni da parte di gruppi di persone direttamente interessate a specifiche problematiche sociali (Fiorentini, 1996). Anche in Italia, tutta la cosiddetta stagione pionieristica dell’impresa sociale ovvero la fase di trasformazione dalle esperienze di volontariato in forme organizzative più strutturate e professionali di produzione di servizi è stata spesso caratterizzata da una stretta alleanza da gruppi di famigliari e utenti con volontari e lavoratori retribuiti soprattutto nell’ambito della disabilità e della psichiatria (Borzaga e Santuari, 2001). A seguito dei processi di integrazione nelle politiche pubbliche, un numero crescente di enti, organizzati prevalentemente in forma di cooperative sociali, ha acquisito tuttavia nel tempo una configurazione più produttiva e occupazionale orientata alla gestione dei servizi e meno a intercettare e leggere l’evoluzione dei bisogni (Donati e Colozzi, 2004). In particolare, soprattutto nell’ultimo decennio, molte cooperative sociali hanno spesso interiorizzato la convinzione di essere fornitori di servizi a una committenza definita per via amministrativa dagli enti pubblici. La tendenza a pensarsi come fornitori, da un lato risponde al bisogno di sicurezza e legittimazione di enti che per esistere hanno necessità di stabilizzare le fonti di finanziamento; dall’altro, si configura come l’esito di dinamiche più articolate che uniscono una specializzazione nella produzione di servizi a basso valore aggiunto poco funzionali a sostenere investimenti, compagini sociali non di rado mono-professionali e tecnostrutture povere con difficoltà a orientare uno sviluppo più autonomo dalla domanda pubblica. Un risultato comune di questi processi è la perdita di focus sull’evoluzione dei bisogni e in seconda istanza il depauperamento della capacità di svolgere una funzione di sentinelle sociali sul territorio e promotori di innovazione.
Trasportata sul piano dell’applicazione degli strumenti collaborativi previsti dall’art. 55 impegnati nella produzione di servizi, la configurazione assunta nel tempo da parte di enti di terzo settore a vocazione produttiva come effetto delle dinamiche politiche e regolative emergenti rischia di produrre tre effetti:
- il primo è la tendenza alla conservazione dell’esistente. Essendo enti specializzati in gestione dei servizi e non di analisi dei bisogni, il campo entro cui si muovono e ragionano molti enti è quello di ciò che si conosce e ciò che rappresenta un problema per il modo con cui si sanno fare le cose. Nelle procedure collaborative, di conseguenza, le proposte avanzate riguardano spesso prevalentemente miglioramenti incrementali dell’offerta consolidata con la preoccupazione di garantire la continuità dei servizi o del posizionamento degli enti sul territorio con l’ente pubblico che mantiene fermamente una posizione dominante nel decidere priorità e oggetti delle procedure collaborative (Borzaga et al. 2024).
- il secondo effetto del mancato coinvolgimento dei cittadini e degli utenti è il rischio di consolidare una distorsione percettiva che porta il terzo settore a vedere gli strumenti collaborativi non come un mezzo per innovare l’architettura dell’offerta, ma come modalità per preservarla, riducendo lo stress delle gare e il pericolo di perdere la gestione dei servizi e delle posizioni consolidate.
- il terzo effetto è infine la perdita dell’opportunità di rimettere al centro della riflessione sulla progettazione degli interventi i bisogni, e non le definizioni amministrative degli stessi, che alimentano prestazioni specialistiche spesso frammentate e disorganiche che non consentono di strutturare percorsi di supporto ai percorsi di vita delle persone.
In un quadro in cui l’applicazione dell’art 55 appare ancora in mezzo al guado e in cui rischia di prevalere conseguentemente una concettualizzazione dei nuovi strumenti in chiave di procedure codificate (Polizzi, 2023), queste considerazioni evidenziano l’importanza di interrogarsi di queste dinamiche e cercare di capire come è possibile in base ai dispositivi proposti recuperare e rilanciare un modello di progettazione dei servizi e degli interventi sociali capace di intercettare e interagire con le esigenze e i bisogni reali dei cittadini.
Come recuperare un focus sui bisogni? L’esperienza della co-programmazione per gli interventi a favore della domiciliarità in Provincia di Trento
L’esperienza della co-programmazione sulla domiciliarità della provincia autonoma di Trento rappresenta un caso indicativo dei rischi di tralasciare il ruolo di cittadini e utenti dalla progettazione degli interventi e delle potenzialità che tale coinvolgimento comporta per rilanciare sia le politiche sociali locali che il ruolo di pubblico e terzo settore. La provincia di Trento è un territorio autonomo caratterizzato da un’alta spesa sociale e da una rete di servizi consolidata nel tempo. Il livello di organizzazione ed erogazione dei servizi è quello delle cosiddette Comunità di Valle che assommano 16 bacini socio geografici omogenei e formano il livello istituzionale intermedio fra i comuni e la provincia autonoma. Nel campo delle politiche sociali, alla provincia competono le linee di programmazione, mentre i singoli territori hanno autonomia di organizzazione e implementazione delle strategie generali.
Il ruolo del terzo settore e in particolare della cooperazione sociale nell’erogazione dei servizi è storicamente molto forte. La Federazione della cooperazione trentina conta oltre centomila soci ed è un soggetto politico capace di condizionare in modo consistente le decisioni politiche provinciali. Il Trentino non a caso è stata una delle prime aree territoriali a riconoscere gli aumenti del nuovo contratto nazionale dei lavoratori della cooperazione sociale. Il nuovo contratto, che ha avuto decorrenza dal 1° settembre 2024, prevede per la parte economica a partire dal gennaio 2025 un aumento dell’indennità integrativa provinciale del 33% e ad oggi è uno dei più favorevole dell’intero territorio nazionale.
Il processo è stato avviato per istanze ampie legate alla necessità di migliorare il servizio di assistenza domiciliare nel suo complesso al fine di renderlo più congruente ai bisogni. Al riguardo erano state individuate quattro aree di criticità: il costo del servizio, il modello di servizio con l'elevata segmentazione, la difficoltà di reperimento del personale e la limitata offerta rispetto alla domanda potenziale.
Fin da subito la discussione sui servizi domiciliari aveva intersecato il crescente dibattito sull’invecchiamento della popolazione e l’incremento di richieste di servizi avviato al tavolo della programmazione sociale provinciale. In quella sede l’indicazione politica condivisa dai partecipanti istituzionali del comitato compreso i rappresentanti del terzo settore era stata quella di ampliare il tavolo sui servizi domiciliari e fare confluire la tematica in un più ampio processo di co-programmazione riguardante la domiciliarità in senso esteso del termine.
La progettazione del processo inizialmente era stata impostata, oltre che sull’analisi della documentazione statistica e dei report dei servizi sociali e sanitari provinciali, sul classico modello dei tavoli di lavoro a cui invitare responsabili di servizi pubblici ed enti di terzo settore. Il cambio di oggetto di lavoro dai “servizi di assistenza domiciliare” alla “domiciliarità” in senso ampio ha portato però fin da subito a interrogarsi su quali fossero i soggetti meglio titolati a parlare di un tema dai confini più incerti e permeabili rispetto a quello più definito dei servizi accreditati e formalizzati. In questa prospettiva, si è deciso di procedere con un metodo misto, inserendo nelle più classiche attività dei tavoli con i rappresentanti di pubblico e terzo settore anche un filone di raccolta informazioni e indicazioni relative ai bisogni basata sul coinvolgimento diretto di anziani e famigliari/caregivers. È stato costruito un campione qualitativo di profili di anziani in condizioni assistenziali e di famigliari caregivers le cui caratteristiche sono riportate nella tab. 1. I profili sono stati identificati attraverso il metodo del campionamento di esperti in collaborazione con i funzionari e i responsabili dei servizi territoriali in modo da coprire le situazioni più diffuse del fenomeno. Il campione individuato per via qualitativa non aveva valore statisticamente rappresentativo, ma si proponeva di focalizzare l’attenzione su situazioni idealtipiche per favorire una successiva discussione dei risultati basata su conoscenze dei cosiddetti “esperti per esperienza”.
Tab. 1 Il campione
|
Anziani |
Famigliari/caregivers |
|
Con diagnosi precoce di Alzheimer che vive da solo |
Coniuge di un anziano inserito privatamente in struttura |
|
Non autosufficiente con copertura medio-alta di servizi a domicilio (cinque o più giorni a settimana) |
Coniuge di un anziano inserito in convenzione in struttura |
|
Non autosufficiente con copertura bassa di servizi a domicilio |
Coniuge di un anziano con Alzheimer, non seguito da servizi in zona di periferia/città |
|
Parzialmente non autosufficiente, convivente con persona anziana con problemi di parziale/grave non autosufficienza |
Figlia single lavoratrice di un anziano a carico con figli minori |
|
In lista di attesa per entrare in struttura residenziale con un punteggio medio basso |
Figlia non lavoratrice con nucleo con anziano a carico e figli piccoli |
|
Parzialmente autosufficiente che vive in cohousing |
Figlio di persona anziana residente in zona isolata, non in carico a servizi |
|
Parzialmente non autosufficiente solo abitante in aree periferiche poco coperte da servizi |
Coniuge senza reti sociali solo con anziano a carico |
|
Parzialmente autosufficiente con disabile a carico |
Figlio lavoratore single con genitore anziano che vive da solo |
|
Parzialmente non autosufficiente che vive in nucleo abitativo con moglie figlia coniuge e nipote |
Figlio solo con due genitori a carico, con declino parallelo, zona montana |
|
Malato di Parkinson senza parenti con assistente famigliare |
Coniuge di anziano con SAD e assistente familiare privato |
|
Anziano non autoctono parzialmente non autosufficiente trasferito da pochi anni in periferia |
Familiare di anziano con SAD e Centro Diurno |
Una volta definiti i profili di interesse, sono stati individuati i soggetti da intervistare e sono state raccolte le storie del percorso di perdita di autosufficienza e di assistenza, focalizzando l’interesse sugli elementi del vissuto che permettevano di riflettere sul tema domiciliarità. La raccolta delle storie è durata un mese e mezzo sono state realizzate 22 interviste della durata variabile tra una e tre ore e i materiali sono stati elaborati attraverso l’analisi tematica utilizzando il programma ATLAS-T. L’intero processo di co-programmazione comprensivo di sette incontri del tavolo di lavoro è durato da febbraio a giugno 2025.
I principali risultati dell’analisi
Le storie degli anziani e dei loro famigliari e caregivers mettono in luce una realtà molto più articolata e complessa rispetto a quella deducibile dai resoconti amministrativi e procedurali dei servizi di assistenza domiciliare.
La domiciliarità come luogo e come spazio
Innanzitutto, attraverso il coinvolgimento di anziani e famigliari il domicilio riacquisisce una centralità analitica che la centratura dell’attenzione sulle prestazioni di assistenza domiciliare rischia di lasciare completamente in sottofondo. Il domicilio può essere inteso in termini sia di luogo che di spazio. Lo spazio è una dimensione non vitale, privata o impoverita di relazioni umane e sociali che faticano a dispiegarsi o per assenza o per la fatica di prendere forma. Per spazio si intende un riferimento prevalentemente anagrafico che non è riempito di una dimensione umana e relazionale positiva. Il domicilio come luogo, al contrario, è un costrutto antropologico costituito da relazioni vitali, da riferimenti identitari e dalla storia delle persone che pur connotato dalle fatiche dell’assistenza e della malattia non decade in una condizione di stress e burn out permanente. Parlare di domicilio come luogo significa quindi fare riferimento a un ambiente in cui le persone trovano sostegno e gratificazioni e sono in grado di convivere anche con forma di malattia o non autosufficienza molto pesanti.
Le condizioni della domiciliarità
La duplicità dei significati di domiciliarità è specificata nei diversi racconti in base alle condizioni che consentono a anziani e caregivers di vedere soddisfatti i loro bisogni oppure di viverli come negati.
I bisogni di cui gli intervistati parlano sono plurali e utilizzando la piramide di Maslow (1954) possono essere distinti in: bisogni fisici, di sicurezza, affettivo relazionali, di autostima e di autorealizzazione.
I bisogni fisici – mangiare, bere, dormire, l’igiene – sono di solito riferiti agli anziani, ma dalle storie dei caregivers la prospettiva si amplia molto. Ci sono famigliari che per assistere i propri cari per lunghi periodi di tempo non dormono o sono talmente stressati da non riuscire a prendere sonno. Per quanto riguarda i bisogni di sicurezza il rimando è alle condizioni abitative e alla funzionalità degli alloggi che spesso non sono pensati per persone con gravi problemi di deambulazione e mobilità. I bisogni affettivi sono ancora più articolati. Le relazioni tra famigliari e anziani si basano spesso su rapporti filiali o coniugali che comportano un senso di obbligazione morale all’assistenza. Assistere può dare soddisfazioni e gratificazioni personali, ma anche, se mancano le condizioni, creare dissapori e tensioni interne alla rete primaria. Quando i famigliari non condividono le scelte assistenziali o di gestione della vita quotidiana possono ingenerarsi conflitti tra figli o fratelli che inaspriscono la situazione e rendono l’esperienza dell’assistenza a domicilio un fattore di forte stress personale e sociale. L’assistenza agli anziani, se è poco o insufficientemente supportata, o se i caregivers non sono preparati e capaci di gestire particolari problematiche, come potrebbero essere quelle legate alla demenza o a malattie di lunga durata, invece di supportare l’autostima e la gratificazione dell’aiutare un proprio congiunto rischia di trasformarsi in frustrazione e senso di colpa, andando a deteriorare il clima famigliare. Autostima e autorealizzazione, infine, si rilevano nelle situazioni in cui nonostante le fatiche permangono condizioni di vita e di respiro decenti. Quando c’è un sostegno parentale allargato, un buon rapporto con la comunità e una presenza efficace dei servizi le persone si sentono più sicure e la motivazione a svolgere i compiti di aiuto tende ad aumentare e rinforzarsi.
La domiciliarità, su queste basi, non è una questione che riguarda solo i servizi di assistenza agli anziani conseguenti ad una valutazione multidimensionale centrata solo sulla persona; è invece il sistema di relazioni che coinvolge l’anziano e i caregivers all’interno di una situazione domiciliare data a dovere rappresentare il fuoco dell’attenzione e dell’intervento.
La domiciliarità come continuum
Raccogliendo le storie di anziani e caregivers durante il percorso di perdita di autosufficienza quello che infine appare centrale è la dimensione dinamica del concetto di domiciliarità. La domiciliarità non è uno spazio asettico, ma un luogo di relazioni significative; questo implica che si possono avere condizioni di domiciliarità non solo nella propria abitazione. Fino a quando si può stare a casa in condizioni soddisfacenti, il domicilio è la soluzione più umana e più soddisfacente, sia per gli anziani che per i caregivers. Entrano però in campo, con l’aumento della non autosufficienza, più variabili che possono trasformare l’abitazione in una condizione disagevole o non più sostenibile. Lasciare la propria abitazione non significa tuttavia perdere un’idea di intimità e relazionalità. Alcuni anziani che hanno scelto di condividere il domicilio con altri anziani esprimono soddisfazione per la scelta effettuata soprattutto se i coinquilini sono persone conosciute del luogo o del vicinato. Allo stesso tempo soluzioni di cohousing a bassa protezione, se pensate garantendo una continuità di rapporti con la rete delle relazioni significative, possono sortire un effetto di rassicurazione per persone che stano perdendo la loro autosufficienza. Un’idea di domiciliarità come luogo si può estendere anche alle residenze per anziani lungodegenti nel momento in cui sono garantiti i legami con la storia e le relazioni con la famiglia e le reti sociali comunitarie e tali strutture non si trasformano in spazi asettici di ospedalizzazione forzata.
Dal coinvolgimento alla programmazione
Una volta terminate e elaborate le interviste, i risultati delle storie di anziani e caregivers sono stati riportati sui tavoli di lavoro con i rappresentanti del pubblico e del terzo settore, definendo un nuovo perimetro cognitivo per rappresentare e discutere dei programmi di intervento a favore della domiciliarizzazione degli anziani.
Gli esiti sono stati quelli di una riformulazione sostanziale del dibattito.
La riformulazione dell’assistenza domiciliare
In primo luogo, si è cominciato a condividere ai tavoli di lavoro l’idea che nella società contemporanea le reti primarie sono molto più fragili che in passato; quindi, se venti anni fa si poteva organizzare un’assistenza domiciliare centrata sui bisogni dei singoli individui, oggi è indispensabile valutare monitorare e aiutare anche le molte situazioni di caregivers e famiglie che rischiano di essere letteralmente schiacciate dalle incombenze dell’assistenza a domicilio. Il passaggio di prospettiva non si limita a considerare le reti primarie come più o meno funzionali all’assistenza all’anziano ma definisce esse stesse come soggetti potenzialmente vulnerabili da monitorare e sostenere. Sono da tale constatazione emerse diverse idee e linee di azione che impattano in modo diretto sull’organizzazione dei servizi e sulla necessità di riprogettare strumenti e interventi. Per esempio, il riconoscimento dei caregivers come soggetti fragili ha spinto i rappresentanti del sociale e della sanità a condividere la necessità di elaborare degli strumenti condivisi di valutazione non solo degli anziani, ma anche dei loro nuclei per costruire gli interventi di sostegno in modo integrato. Sul piano dell’organizzazione dei servizi di assistenza domiciliare il nuovo sguardo ha consentito di focalizzare alcuni problemi di gestione dei servizi secondo nuove coordinate. La fatica a reclutare assistenti domiciliari registrata dalla cooperazione sociale è imputabile a diversi fattori, tra i quali il basso salario. Un aspetto molto sottovalutato dell’insoddisfazione deli lavoratori riguarda il rapporto con i famigliari degli assistiti. Nei modelli organizzativi dominanti si rileva una forte rotazione degli operatori. Nel giro di poche settimane presso un medesimo assistito si possono presentare quattro o cinque operatori diversi. Uno degli effetti di questa organizzazione del lavoro non riguarda solo la mancata continuità assistenziale nei confronti dell’anziano, ma anche un cambio continuo di interlocutore per i suoi famigliari. Soprattutto quando le famiglie sono più fragili, preoccupate e con poche risorse, sugli operatori rischiano di essere riversate di conseguenza aspettative e tensioni che vanno nella direzione contraria a ciò che un lavoratore sociale dovrebbe ricevere come incentivo intrinseco alla motivazione lavorativa: un sentimento di fiducia, un dialogo e un riconoscimento del lavoro svolto. Inoltre, dai racconti di anziani e caregivers, appare chiaro che i soli operatori professionisti in molti casi non sono sufficienti per assicurare una assistenza dignitosa agli anziani; quando i famigliari lavorano gli anziani trascorrono ore da soli e servirebbe promuovere un servizio di monitoraggio, magari leggero, attraverso volontari per garantire la sicurezza e aumentare la protezione. Queste esemplificazioni mostrano come attraverso le storie dei caregivers e degli anziani si possono delineare piste di lavoro e coprogettazione che potrebbero forse apparire banali, ma che la specializzazione lavorativa e i modelli di gestione dei servizi dominanti tendono a sottovalutare o a non percepire come inerenti al compito.
Lo sviluppo di forme di abitare condiviso leggero
Un secondo aspetto che le interviste hanno messo in luce, soprattutto attraverso i racconti dell’evoluzione della non autosufficienza, è la possibilità di costruire soluzioni abitative leggere in condivisione come ponte tra una vita indipendente a domicilio resa difficile dal peggiorare delle condizioni fisiche psicologiche degli anziani e le soluzioni di assistenza residenziale più strutturate. Nel modello istituzionalizzato di politica dei servizi l’assistenza domiciliare è considerata l’anticamera del passaggio in struttura residenziale. Questo passaggio è reso tuttavia sempre più problematico dall’aumento di anziani non autosufficienti e dal numero limitato di posti in struttura. La soluzione dell’investimento sull’assistenza domiciliare anche politicamente diventa in questo scenario un modo per cercare di risolvere un problema strutturale che per costi di gestione delle strutture e numero di posti disponibili non è realisticamente risolvibile. L’esperienza di alcuni anziani intervistati che risiedevano nelle primissime sperimentazioni di cohousing a livello provinciale ha rilevato l’importanza dello sviluppo di nuove forme di “abitare possibile” che possono rappresentare anche soluzioni culturalmente e socialmente sostenibili per superare il radicato senso di colpa che porta molti famigliari a tenere gli anziani a domicilio fino a che arriva un punto di rottura delle condizioni di entrambi.
L’abitare in condivisione non può essere pensato tuttavia secondo gli schemi rigidi degli accreditamenti o degli appalti perché deve unire la dimensione della protezione leggera con quella della convivialità e del legame con la comunità. Di conseguenza questa nuova frontiera dei servizi si configura come un ambito privilegiato di coprogettazione che deve sviluppare soluzioni molto locali capaci di fare leva sul senso di appartenenza degli anziani e sulla conoscenza reciproca dei residenti.
L’organizzazione comunitaria delle residenze protette
L’idea di domiciliarità nei racconti degli intervistati portati ai tavoli ha sottolineato, infine, l’esigenza di pensare le strutture non come spazi chiusi, ma come luoghi che tengono vivo un rapporto con la comunità e le reti famigliari di origine dei residenti. Dalle interviste di anziani e famigliari inseriti in struttura, ciò che si desuma è l’esigenza di mantenere vivi i legami con la storia, l’identità e la comunità di origine per fare in modo che un’idea di domicilio come luogo, non più possibile nella propria abitazione, possa replicarsi in qualche forma almeno approssimata nelle nuove residenze. I rappresentanti pubblici e di terzo settore convocati ai tavoli di lavoro, partendo da questi spunti, sono stati portati a enfatizzare azioni innovative di organizzazione e progettazione del funzionamento delle strutture protette sottolineando l’esigenza di costruire ponti con la comunità per tramite dell’associazionismo locale e di ripensare la logica assistenziale in chiave di umanizzazione degli interventi e di progettazione di nuove filiere di servizi per consentire un accompagnamento più efficace e efficiente dei percorsi di invecchiamento dalla casa all’istituzione.
Queste considerazioni delineano un orizzonte di lavoro delle politiche della domiciliarità territoriali molto diverso da quello configurato inizialmente in base alle istanze delle cooperative che erogavano con crescenti fatiche l’assistenza domiciliare e degli enti pubblici responsabili dei procedimenti di affidamento dei servizi.
In primo luogo, lo spazio di riflessione e progettazione degli interventi non sono più i singoli servizi con le loro legittime esigenze, ma i mondi vitali delle persone; questo è un passaggio estremamente importante, perché la scarsa efficacia e la bassa efficienza di molti servizi è legata in questa fase storica al fatto che essi sono stati pensati rispetto a problematiche che oggi sono profondamente mutate. Venti o trenta anni fa, per esempio, gli anziani non autosufficienti erano molti meno e le loro reti primarie risultavano più ampie e solide. Quindi, un’ora di assistenza domiciliare rivolta all’anziano aveva un senso completamente differente rispetto a una situazione in cui sono sia l’anziano sia i suoi famigliari a essere sotto pressione e sono gli equilibri tra questi due soggetti a risultare precari e a rischio.
In secondo luogo, spezzare la logica del welfare orientato ai servizi per riposizionare gli stessi nei confronti dei bisogni è un’azione benefica sia per gli utenti e le loro reti che per gli erogatori che possono individuare strade per rinnovare il proprio protagonismo sociale e per gli operatori che spesso rischiano di essere ingabbiati in procedure e protocolli il cui senso non è sempre facile da trovare.
In terzo luogo, nei processi di immaginazione e costruzione degli interventi, l’introduzione dei punti di vista di chi vive di prima persona le situazioni di difficoltà permette di rappresentare le risposte in una ottica di maggiore ampiezza e integrazione. Se si ragiona su una prestazione di assistenza domiciliare o di un servizio di educativa a domicilio, implicitamente gli attori coinvolti sono quelli contemplati dai protocolli di erogazione dei servizi. Se si parte dai bisogni, al contrario, aumenta la complessità delle questioni in campo ed è più facile ragionare su interventi più ampi e coordinati. Per esempio, riconoscere le fatiche dei famigliari significa dovere ragionare sulla loro formazione, sulla necessità di fornire competenze per gestire i momenti in cui si è da soli con gli anziani, sugli interventi di monitoraggio che possono essere svolti da associazioni di volontariato o sui servizi di respiro che aprono nuove opportunità di sviluppo per il terzo settore economico e occupazionale.
Discussione e conclusioni
Le traiettorie della partecipazione delineate dall’art. 55 aprono potenzialmente a una stagione di maggiore collaborazione tra pubblico e terzo settore. Come per ogni riforma serve tempo per comprenderne gli effettivi esiti e bisogna considerare sia gli effetti diretti che quelli che si sarebbero verificati se essa non fosse mai stata attuata. Una valutazione complessiva è dunque ancora lontana da potere essere effettuata e quello che si può ragionevolmente fare è cercare di comprendere quali sono le dinamiche in atto, cosa sta funzionando e quali sono i problemi per provare a risolverli. In altre sedi sono stati discussi e affrontati altri aspetti. In questa il punto oggetto di attenzione è stato il ruolo e il coinvolgimento di cittadini, utenti e famigliari nei nuovi processi collaborativi. In base alle argomentazioni e alle esemplificazioni descritte un errore concettuale fondamentale che rischia di ritrovarsi nelle giustificazioni politiche e giuridiche all’introduzione dei nuovi dispositivi collaborativi è di attribuire alla natura intrinseca del terzo settore una maggiore capacità di essere vicini e leggere i bisogni. Il legislatore ha probabilmente voluto essere generico per supportare le sue argomentazioni a favore dell’introduzione dell’art. 55 come strumento ordinario dei rapporti tra pubblico e terzo settore non cogliendo che gli enti di terzo settore hanno natura eterogenea e le loro caratteristiche comprese quelle di sapere leggere i bisogni e di promuovere innovazione, sono dinamiche e strettamente connesse con l’evoluzione politica e sociale (Colozzi e Bassi, 2004; Fazzi, 2014). Diverse ricerche hanno evidenziato in particolare come il passaggio da terzo settore di tipo tradizionale a configurazioni più occupazionali ed economiche ha profondamente differenziato e trasformato la natura di molte organizzazioni, rinforzando non in modo esclusivo, ma sicuramente molto significativo, la componente di erogazione di servizi a scapito delle funzioni di advocacy e di cambiamento sociale (Borzaga e Fazzi, 2014). La capacità di essere vicini ai bisogni e di leggerne le dinamiche meglio di altri attori per molti enti può essere dunque ancora presente, ma non è una condizione propria alla sola natura giuridica degli enti di terzo settore e costituisce più una forzatura della realtà che la realtà stessa.
Se si analizza l’insieme dell’offerta dei servizi erogati dal terzo settore e dalla cooperazione sociale in particolare in una prospettiva storica, ciò che appare evidente è una strutturazione di uno zoccolo duro di servizi come l’assistenza domiciliare, l’educativa a domicilio o i centri diurni rivolti a target di utenza molto circoscritti che definisce il principale perimetro sia operativo, che in parte anche cognitivo, entro cui gli enti pensano e agiscono. L’innovazione, che pure ancora occasionalmente si registra, appare limitata ed è trascinata da un gruppo di organizzazioni largamente minoritario sul totale.
Questa tendenza è solo parzialmente imputabile alla crescente difficoltà economica in cui si trovano molti enti, perché in realtà anche prima del Covid quando le marginalità della vendita di servizi erano migliori, si registrava una medesima tendenza alla gestione dell’esistente piuttosto che non alla apertura di nuove aree di attività. A indebolire la capacità di lettura dei bisogni sono diversi fattori quali la diffusa specializzazione professionale verso specifiche tipologie di utenza, la carenza di tecnostrutture orientate all’innovazione e non solo alla progettazione per bandi, e una modellistica organizzativa di tipo prevalentemente funzionale organizzata per rispondere a criteri di accreditamento o tipologie di domanda standardizzate. Altrettanto chiaro è però che si è assistito nel tempo a una separazione progressiva tra attori potenzialmente legati ad un'unica finalità: gli enti impegnati nell’erogazione di servizi, da un lato, e i cittadini, gli utenti, i loro famigliari ovvero da coloro che vivono sulla loro pelle lo stato di bisogno, dall’altro, che sono diventati da partner a ricettori più passivi dei servizi.
Le principali idee esterne capaci di orientare l’offerta sono state di conseguenza sempre più spesso quelle dei finanziatori pubblici alle prese con problemi di controllo e razionalizzazione della spesa, a discapito delle voci di chi in prima persona vive una condizione di bisogno e che in passato era stato spesso anche direttamente coinvolto, e non solo interlocutore del terzo settore.
In questo quadro, l’introduzione dei dispositivi collaborativi previsti dall’art. 55 del Codice del terzo settore rischia di riprodurre in una chiave formalmente nuova, ma contenutisticamente vecchia, le stesse dinamiche e gli stessi ragionamenti che hanno caratterizzato l’ultima fase di sviluppo dei rapporti tra pubblico e enti di privato sociale quali il prevalere di atteggiamenti difensivi, il focus sull’esistente, la fatica di immaginare il nuovo con una prospettiva temporale non legata ai finanziamento estemporanei dei bandi (problema che ha assunto con il PNNR dimensioni molto preoccupanti). Quanto rischi di essere debole la capacità di lettura autonoma da parte del terzo settore dei bisogni sociali, appare evidente dall’attuale esiguo numero di proposte di coprogettazione avanzate direttamente dagli enti del privato sociale e dal permanere di una rappresentazione del nuovo istituto come forma originale di affidamento di servizi da parte pubblica e non di costrutto da ideare insieme.
In un’epoca in cui impera anche nei mercati profit l’imperativo della open innovation e dei modelli distribuiti che coinvolgono afflussi e deflussi di conoscenza gestiti in modo mirato tra i confini delle organizzazioni (Chesbrough, 2003), sono tanti i segnali che indicano come, anche nella costruzione degli interventi sociali, sia prioritaria la necessità di ricorre a idee, risorse e competenze esterne ai sistemi consolidati per generare innovazione e risposte coerenti con lo sviluppo dei bisogni. Negli ultimi anni hanno proliferato i progetti di accompagnamento finalizzati all’innovazione offerti a terzo settore e pubbliche amministrazioni da professionisti e società di consulenza spesso per rispondere a criteri di bandi decisi dall’alto. Spesso, anche in questi casi cittadini, utenti e famigliari sono rimasti fuori dai tavoli e dai gruppi di lavoro assumendo implicitamente che non dovessero essere loro gli attori protagonisti del cambiamento e altrettanto spesso questi progetti formalmente ben predisposti sono rimasti terminati i finanziamenti dei bandi lettera morta sul campo.
Come è stato mostrato attraverso la descrizione del processo di co-programmazione per gli interventi a favore della domiciliarità in provincia di Trento, restare ancorati o, peggio, strumentalizzare una immagine retorica del terzo settore come attore capace da solo di leggere i bisogni in forza del suo inserimento nelle reti delle relazioni locali può risultare deludente ai fini dell’efficacia dell’applicazione della nuova normativa. Di fronte a una società in rapidissima e radicale trasformazione non possono essere attori e modelli organizzativi fortemente strutturati e fondamentalmente pensati per un'altra epoca e per un altro contesto storico a dettare da soli il cambio di linea. Ciò che serve è anche il recupero di un rapporto vero con i cittadini, gli utenti e le famiglie, perché sono loro a essere spesso le prime sentinelle dei bisogni e la riflessione sulla domiciliarità che ha coinvolto anziani e caregivers è emblematica del cambiamento di paradigma che si può promuovere facendo dialogare i diversi attori.
Su un piano più direttamente operativo, il coinvolgimento di cittadini, utenti e famigliari nei nuovi processi partecipativi può avere molteplici declinazioni. A titolo esemplificativo, per quanto riguarda le attività di co-programmazione, si possono mettere in atto, oltre a attività di coinvolgimento diretto di cittadini, utenti e famiglie sul facsimile di quello descritte, anche misure che attivamente promuovono e incentivano la partecipazione di associazioni di utenti e famigliari piuttosto che organizzazioni di advocacy. Per quanto concerne invece la co-progettazione sarebbe molto importante introdurre tra i criteri di selezione dei proponenti indicatori relativi alla reale capacità di leggere i bisogni, richiedendo analisi che qualificano effettivamente tale caratteristica e incentivano di conseguenza a attivare percorsi di confronto con i destinatari, oppure alla presenza tra gli enti proponenti (non solo formale ma verificabile nelle interconnessioni progettuali) di associazioni di utenti, cittadini e famigliari. La partecipazione attiva di cittadini e utenti può continuare anche durante il processo di realizzazione degli interventi maturati nel corso della co-progettazione. In una esperienza pilota da poco conclusa a Torino sugli stranieri nella ASL TO4 sulla salute mentale è emerso per esempio come uno degli aspetti significativi circa l’ascolto dei beneficiari sia non solo che possano dare voce nella fase di programmazione ai bisogni, ma anche immaginare forme di governance ordinaria dei servizi (tavolo di programmazione/coordinamento permanenti). Il coinvolgimento non si limita in questa prospettiva all’ascolto, ma dall’ascolto si può prendere spunto per includere la voce dei destinatari anche nei luoghi dove di fanno politiche e strategie.
In conclusione, ciò che può rappresentare un momento di novità sostanziale nello sviluppo delle nuove forme di collaborazione previste dal Codice del terzo settore è ricordarsi che le basi della società civile non possono essere surrogate in forma di rappresentanza non realistiche e che è veramente importante oggi forse più che mai dare valori al vissuto e alla voce di chi quotidianamente sperimenta il bisogno e il rischio di esclusione sulle proprie spalle.
DOI 10.7425/IS.2025.03.07
Bibliografia
Colozzi I., Bassi A. (2004) Da terzo settore a imprese sociali, Carocci, Roma
Boschetti B., Cavallaro C., Giachi L. Proia F. (2024) L’amministrazione condivisa oltre il Codice del terzo settore, in B. Boschetti (a cura di) Per un laboratorio dell’amministrazione condivisa, Editoriale Scientifica, Napoli, pp. 17-60.
Borzaga C., Fazzi L., Rosignoli A. (2023) Guida pratica alla co-programmazione e alla co-progettazione. Strategie e strumenti per costruire agende collaborative, Erickson, Trento.
Borzaga C., Fazzi L., Rosignoli A. (2024) Co-progettare i servizi sociali: nuove traiettorie del welfare locale in Italia?, in Politiche Sociali, 1, pp. 3-24.
Borzaga, C. e Santuari, A. (2001) Italy. From traditional co-operatives to innovative social enterprises, in C. Borzaga, J. Defourny (eds.), The Emergence of Social Enterprise, Routledge, London, pp. 166-181.
Brandsen T., Steen T, Verschuere B. (2018), Co-Production and Co-Creation: Engaging Citizens in Public Services, New York, Taylor & Francis.
Chesbrough H. (2003) Open Innovation: the new imperative for creatingand profiting, from technology, Harvard Business School Press, Boston.
De Ambrogio U. Marocchi G. (2023) Co-programmare e co-progettare. Amministrazione condivisa e buone pratiche, Carocci, Roma.
Donati P. Colozzi I. (a cura di) Il terzo settore: culture e pratiche, FrancoAngeli, Milano.
Fazzi L. (2014) Imprenditori sociali innovatori, FrancoAngeli, Milano.
Fazzi L. (2023) Co-progettazione e welfare locale in Italia: innovazione o ancora un caso di dipendenza dal percorso?, in "Autonomie locali e servizi sociali" 1, pp. 119-136.
Fiorentini G. (1996) Il contributo della teoria economica processi di privatizzazione nei servizi sociali, in C. Borzaga, G, Fiorentini, A. Matacena (a cura di), Nonprofit e sistemi di welfare, Nuova Italia Scientifica, Roma., pp. 55-68.
Frediani E. (2021) La co-progettazione dei servizi sociali. Un itinerario di diritto amministrativo, Giappicheli, Torino.
Guarna A. Maino F. Co-progettazione e co-programmazione tra teoria e prassi, in F. Maino (a cura di) Agire insieme. Co-progettazione e co-programmazione per cambiare il welfare. Sesto rapporto sul secondo welfare, Milano, Percorsi di secondo welfare, 2024.
Kurki A.L., Weiste E., Toiviainen H., Käpykangas S., Ylisassi H. (2024) Co-development of client involvement in health and social care services: examining modes of interaction, in Journal of Health Organization and Management, Vol. 38, 9, pp. 19-35.
Maslow A. (1954) Motivation and Personality, New York; Harper & Row Publishers; trad. it. Motivazione e personalità, Armando, Roma, 1973
Neshkova M., Guo H. (2012) Public Participation and Organizational Performance: Evidence from State Agencies, in Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 22 (2), pp. 267–288.
Polizzi E. (2023) Una politica per l’amministrazione condivisa. Gli usi possibili degli strumenti di riforma, in Impresa Sociale, 4.
Stanghellini A., Gillini G. M., Brunod M. (2025) Co-progettazione sociale e beni comuni. Significati, pratiche e prospettive, Erickson, Trento.
Nicholas G., Tua T. (2017) Client-service engagement in social service provision as co-creation of value, in International Journal of Integrated Care, Vol. 17, 3, pp. 1-18.


