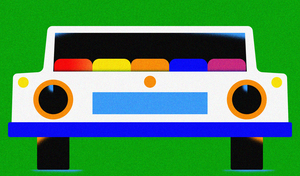
Numero 3 / 2025
L'impresa sociale in uno scenario di transizioni multiple
Massimo Campedelli
Introduzione
Da anni, con prospettive diverse e in occasione di eventi o situazioni altrettanto diversificate, il mondo della cooperazione sociale è oggetto di accese discussioni.
Come elenco, parziale, degli argomenti di ricerca scientifica e di dibattito pubblico che lo hanno riguardato, possiamo richiamare: le criticità delle condizioni di lavoro offerte e l’effettività della governance partecipativa (Fazzi 2024), l’ibridazione organizzativa (Venturi e Zandonai 2014) e l’indebolimento dei caratteri distintivi propri[1], l’instabilità nell’equilibrio tra finalità economiche e finalità sociali, la residualità nell’agenda delle politiche economiche in particolare nel PNRR (FTS e Openpolis 2025; Ascoli e Campedelli 2021; FDD e IrisNetwork 2021), il limitato se non nullo riconoscimento nei confronti dell’opinione pubblica e dei potenziali target di utenti/clienti (Ipsos 2024)[2], la vulnerabilità nei confronti delle economie criminali (Vesco e Belloni 2024) e/o l’adozione di comportamenti illegali, la debolezza nella comprensione e azione di un ruolo politico specifico (Morniroli e Scancarello 2025), ecc.
Una agenda di policies di per sé già alquanto corposa.
Alla luce delle grandi transizioni – demografica, sociale (disuguaglianze e convivenze tra diversi), democratica-politica, digitale, ambientale - che, per usare le parole di papa Bergoglio, segnano il cambio d’epoca che stiamo vivendo (Campedelli 2021), questi temi pongono la necessità di essere riconfigurati e/o rideclinati: hanno cioè bisogno di essere interrogati in profondità, ovvero di più riflessività sia da parte degli studiosi che da chi è attore protagonista della cooperazione sociale.
Scopo di questo contributo è quello di istruire un possibile perimetro di un programma di ricerca che abbia al centro l’impatto di tali transizioni sul mondo della cooperazione sociale, indicando non solo o tanto alcune soluzioni specifiche o generali (CGM 2024), quanto un metodo per affrontarle.
Pur tenendo ferma l’attenzione sulla cooperazione sociale, l’analisi toccherà campi contigui normalmente ad essa associati, quali le politiche di welfare, l’implementazione della riforma del Terzo settore, le policy relative all’economia sociale.
Al contempo, proprio per la finalità indicata, questa riflessione potrà debordare per accennare alle implicazioni relative a temi quali la governance multilivello delle politiche pubbliche (Campedelli, Carrozza e Pepino 2010), le politiche di spesa e le esigenze che gli scenari di guerra stanno imponendo (Ansalone 2025; Aresu 2025; Ican 2025; Sipri 2025), i cambiamenti in atto nel mercato del lavoro, ecc. Ovvero, a quelle problematiche che, anche nella comunità degli esperti, sembrano essere considerate secondarie (Maino e colleghi 2025).
Al fine di garantire il carattere istruttorio, a partire dal lavoro di analisi dei bilanci di Gianfranco Marocchi pubblicato in questa rivista (Marocchi 2024), insieme ad una selezione della letteratura disponibile, si utilizzeranno ulteriori fonti statistiche e documentali inerenti alle tematiche via via evidenziate.
Particolare attenzione verrà rivolta alla metodologia degli scenari (Wilkinson 1995; Delvecchio, Lega e Longo 2010) ovvero alla esplorazione del futuro imprevedibile, qui assunta come esempio di strumento pertinente a strutturare il programma di ricerca appena richiamato.
La ratio su cui si fonda è legata all’esigenza di anticipazione delle discontinuità strutturali che una serie di indicatori – anche se deboli, colti come segnali per le conseguenze rilevanti che comportano – riescono a manifestare al fine di favorire la predisposizione di alternative possibili e di modalità flessibili e adattabili utili a mettere in atto, con tempistiche appropriate, le decisioni necessarie.
Nella consapevolezza che lo sguardo su un’esperienza quasi cinquantennale come quella della cooperazione sociale (Dell’Acqua 2022), non può che essere rapportato al futuro che ci e la attende e misurato rispetto a ruoli e funzioni che essa potrà ancora svolgere in scenari diversi, forse completamente nuovi, da quelli fin qui conosciuti. Questo richiede di evitare, nei limiti del possibile sia sguardi nostalgici rivolti ad un passato idealizzato, retrotopico per dirla con l’ultimo Bauman (2020), sia le letture che nascondono o tendono a rimuovere “discontinuites and invisible continuities” (Laville 2025).
I quattro paragrafi su cui si sviluppa il presente contributo rappresentano quattro tappe di avvicinamento alla necessità di aprire, meglio, riaprire, su una prospettiva di medio lungo periodo, la discussione attorno al futuro della cooperazione sociale, a partire dal nostro Paese, ma non fermandosi ad esso.
Nel prossimo paragrafo, il secondo, viene descritta la situazione di questo articolato modello imprenditoriale argomentando l’interrogativo, a fronte delle grandi transizioni in atto, sulla sua capacità di resilienza davanti ai segnali che sempre più sembrano intaccarne i fondamentali. In quello successivo, il terzo, viene presentata, con una prima esemplificazione, la metodologia degli scenari sopra richiamata. A seguire, nel quarto e quinto, una serie di esemplificazioni di natura qualitativa relative alla transizione del welfare, a quella politica e a quella economica e alle prospettive europee in tema di economia sociale.
Oltre l’emianopsia: uno sguardo ampio?
In un contesto attraversato da molteplici transizioni – oggetto del prossimo paragrafo – in che misura la cooperazione sociale appare dotata delle caratteristiche di dinamismo, capacità di adattamento e resilienza necessarie per avventurarsi verso un futuro necessariamente diverso dall’oggi? È una domanda che richiede, appunto, di andare oltre l’emianopsia, la patologia della vista che comporta la perdita di una parte rilevante del campo visivo in uno o entrambi gli occhi.
Vi sono elementi che portano a pensare che, come in passato, la cooperazione sociale abbia caratteristiche che le consentono di confrontarsi con le sfide di un contesto in evoluzione: a partire dalle prime esperienze nate a cavallo tra militanza politica, deistituzionalizzazione, imprenditorializzazione del volontariato, riconfigurazione organizzativa di altri enti di solidarietà, esternalizzazione dei servizi pubblici e creazione di quasi-mercati del welfare, ecc. (Laville 2025), questa forma particolare di cooperativa ha via via adottato, integrandole spesso in modo assolutamente originale, molteplici logiche d’azione[3], con una notevole capacità di adattamento sia verso l’interno che verso l’ambiente di riferimento. Si potrebbe dire, un attore sociale che si è dimostrato resiliente per definizione.
Questo ha permesso di acquisire un posizionamento chiave in alcuni settori, come nei servizi di welfare territoriale (Fazzi 2022) o nell’inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio (Marocchi 2023); di reagire ad eventi critici fortemente impattanti, come nel caso del Covid (Barbetta e Aii 2021; Ascoli e Campedelli 2021) e prima alle successive crisi del 2008 e del 2011 (Borzaga e Tallarini 2021) e nonostante una sostanziale mancanza di considerazione nell’ambito delle politiche di sviluppo economico e industriale del Paese (UP Umanapersone 2023)[4], sia di crescere in termini quantitativi, sia di rappresentare un attore di cambiamento delle policy che lo riguardano direttamente (Marocchi 2020).
Da qui la domanda: a fronte delle transizioni richiamate, tale capacità di resilienza può permanere nel tempo, per quanto e con quali conseguenze?
La rielaborazione dei dati provenienti da diverse fonti statistiche (Marocchi 2024) offre sia conferme alle ipotesi di persistente resilienza, sia elementi che possono portare a dubitarne; in sintesi, afferma Marocchi “i diversi dati economici — sul fatturato, sui risultati di esercizio, sul patrimonio netto — restituiscono indicatori aggregati che documentano la tenuta del fenomeno, la sua resilienza, la sua vitalità; ma d’altra parte questi dati sono frutto delle performance di sottogruppi abbastanza limitati di cooperative sociali, assumendo invece valori trascurabili per una quota assai rilevante di cooperative sociali… Si tratta di una normale riorganizzazione interna al mondo cooperativo, che continua a crescere grazie alla capacità di alcune sue unità di ridefinirsi e competere con successo sul mercato? Si tratta al contrario di una manifestazione di fragilità della cooperazione sociale, la cui sorte appare affidata ad un numero limitato di unità in un contesto di fragilità diffusa?”
Il quadro che emerge, in sintesi, all’interno di indicatori aggregati che dimostrano una buona tenuta complessiva, fa emergere una serie di elementi – la concentrazione del fatturato su un numero limitato di unità, la caduta delle nuove costituzioni, l’invecchiamento dell’età media delle cooperative, la redditività minima – che vanno considerati con attenzione e che sono compatibili anche con letture pessimistiche del fenomeno: meno cooperative sociali, sempre più vecchie quelle solide, in crescita dimensionale ma sempre meno in grado di patrimonializzare, potenzialmente sottoposte alla crescente concorrenza di altre forme di impresa sociale e non solo, come rimarcato anche nella recente sentenza della Corte costituzionale 116/2025 (si veda per un commento Marocchi 2025).
Difficile, quindi, di primo acchito, pensare che la resilienza quale tratto genetico, possa garantire, senza rilevanti impatti, una adeguata capacità di misurarsi con le transizioni in atto. Quali sono allora, e se ci sono, i determinanti specifici relativi alle criticità segnalate?
In sintesi, rispetto al tema oggetto di questo paragrafo, possiamo affermare che la indubitabile resilienza della cooperazione sociale, la sua capacità di rilanciarsi di fronte a criticità che portano altri attori economici a soccombere, rappresenta senz’altro un capitale a disposizione; ma, d’altra parte, sarebbe semplicistico, anche a fronte dei dati economici documentati, ritenere che la cooperazione sociale sia senz’altro attrezzata a confrontarsi con successo anche con le nuove sfide che l’attendono. Al contrario, sussistono elementi di debolezza che, in assenza di azioni consapevoli, rischiano di rendere ciò problematico.
Immaginare il futuro?
Se dunque alla cooperazione sociale è oggi richiesto un passaggio non scontato di consapevolezza e lungimiranza, la successiva riflessione che è necessario sviluppare riguarda gli scenari di cambiamento che ci attendono. Ciò che condiziona l’evoluzione della cooperazione sociale, è infatti anche legato alle evoluzioni degli ambienti (sistemici) in cui essa opera.
Mantenendo fede al compito istruttorio e metodologico che ci siamo dati, insieme ad una descrizione dei capisaldi della metodologia degli scenari, si propongono alcuni schemi in bozza - da completare e validare con opportuni approfondimenti sia qualitativi che quantitativi, eventuali metanalisi nonché revisioni degli studi disponibili - sulle possibili relazioni tra le transizioni in corso, i determinanti che le guidano, i possibili impatti, e alcuni punti di snodo delle e nelle evoluzioni imprenditoriali, quali approssimazioni per affrontare le esigenze qui poste. Tali esemplificazioni non sono proposte e non vanno lette per i contenuti di merito che contengono, ma come esemplificazione delle direzioni cui la metodologia degli scenari può portare.
Prima di tutto ragioniamo su una prospettiva temporale dell’ordine dei 10-15 anni. Un tempo apparentemente lungo, soprattutto per le abitudini programmatorie oramai consolidate in molte imprese sociali. In realtà, necessario e nei fatti tutt’altro che distante rispetto alle decisioni che, comunque, ogni giorno si debbono prendere nella quotidianità di tali imprese.
Nel concreto, ragionare secondo la metodologia degli scenari comporta:
- ricostruire, tra gli attori principali e i diversi stakeholder interessati, una mappa comune delle variabili da mettere sotto osservazione;
- allinearsi sulle questioni strategiche, ovvero favorire un meeting of minds tra i diversi protagonisti che condividono l’ambiente da essi interattivamente agito;
- sistematizzare il mix di conoscenze di cui dispongono, tra fatti ed evidenze (ciò che si sa per certo), proiezioni del passato nel futuro (ciò che si presuppone di sapere), domande nei confronti delle quali più che ipotesi di risposta solide disponiamo solo di alternative diversificate (ciò che si vorrebbe sapere), definendo così uno spettro di potenziali futuri;
- individuare i punti di biforcazione del futuro, ovvero i possibili momenti di rottura e passaggio a nuove condizioni, in genere questioni scomode che si tende a rimuovere o a rinviare;
- consolidare il coinvolgimento degli stakeholder, eventualmente allargando la platea, condividendo via via una postura strategica;
Detto altrimenti, si tratta di individuare l’essenza delle questioni strategiche, delineare le coordinate sociopolitiche e le condizioni operativo-strutturali dello spazio strategico co-costruito, favorire il dialogo tra i partecipanti e alimentare e indirizzare verso finalità perseguibili il pensiero condiviso.
Gli esempi che seguono sono così strutturati:
- viene proposta una breve introduzione ad un aspetto della transizione;
- sotto, nella prima colonna, vengono identificate le caratteristiche della transizione in questione;
- nella seconda colonna si evidenziano gli impatti di tale transizione sulle cooperative sociali;
- nella terza colonna si elencano le possibili discontinuità che la transizione porta con sé con riferimento al rapporto tra cooperazione sociale e sistema socioeconomico;
- nella quarta e ultima colonna si elencano le possibili discontinuità che la transizione porta con sé con riferimento alla cooperazione sociale.
Si è consapevoli che ciascuno dei temi trattati presenta aspetti di complessità ulteriori a quelli qui richiamati e richiederebbe una disamina più ampia; ma tali schemi sono qui proposti con un mero intento esemplificativo di un percorso metodologico che la cooperazione sociale è chiamata a compiere per affrontare con consapevolezza le transizioni. Va inoltre considerato che le transizioni sono tra loro interconnesse (si pensi ad esempio alle relazioni tra transizione demografica e sanitaria) e che dunque un’analisi di scenario compiuta richiederebbe di considerare insieme una pluralità di aspetti.
|
Esempio 1 - Transizione demografica A fronte di un regime demografico che nel passato era caratterizzato da elevati tassi di natalità compensati da altrettanto elevati tassi di mortalità, la situazione attuale, dopo una prima fase di riduzione della mortalità, si caratterizza per una altrettanto forte riduzione della natalità, accompagnate da modifiche strutturali nei modelli familiari e riproduttivi. Per ora, la transizione riguarda i paesi occidentali, mentre quelli del sud del mondo mantengono alti tassi di natalità e differenziati tassi di mortalità. Il dibattito sulle migrazioni, ovviamente non determinate solo da tali asimmetrie demografiche, e sul futuro delle società occidentali trova qui uno dei fattori determinanti. La cooperazione sociale ne è coinvolta sia per quanto riguarda la composizione della sua base sociale che rispetto ai cambiamenti relativi alla domanda di servizi e prestazioni. |
|||
|
Caratteristiche |
Possibili impatti sulle c.s. |
Discontinuità ambientale/di sistema |
Discontinuità di impresa |
|
Le cooperative sociali sono nate a ridosso del baby boom postbellico, tempo in cui la cd. piramide demografica garantiva: ricambio generazionale; sostituzione del personale; welfare familistico e basato sui trasferimenti; in associazione con il boom economico, espansione della spesa sociale; maggiore incidenza delle acuzie vs cronicità. Nell’arco di 2-3 generazioni tali dinamiche si sono invertite. Oggi ci troviamo ad affrontare l’inverno demografico; le difficoltà di crescita economica; le difficoltà di reperimento del personale; il welfare che, insieme ai problemi storici del modello italiano, vive la sindrome della “coperta che si restringe”. |
Invecchiamento della popolazione lavorativa; difficoltà nel ricambio del personale; aumento dell’incidenza dei lavorotari/ trici immigrati/e; cambiamento nella concezione e nella reputazione del lavoro sociale e della rilevanza del mutualismo nella appartenenza all’impresa; modificazioni strutturali della domanda di servizi; irrigidimento della spesa pubblica per trasferimenti, in particolare pensionistici e per altre voci, come la spesa militare |
Riconfigurazione – ponderata in base all’attuale copertura, in genere limitata, e ai cambiamenti nei modelli procreativi e di cura familiari in corso – dei servizi per l’infanzia e educativi vs. aumento di quelli legati all’invecchiamento, ovvero delle disabilità congenite o acquisite, con progressiva richiesta di personalizzazione e adozione di soluzioni digitali e non istituzionalizzanti per entrambe. Riduzione base sociale vs. ampliamento incidenza dei non lavoratori/trici. |
La disponibilità di personale immigrato vs la progressiva sostituzione di mansioni anche assistenziali attraverso la digitalizzazione dei servizi. La riduzione della capacità innovativa vs. innovazione trainata da una diversa composizione-governance della base sociale. Una strategia consapevole e ponderata per il ricambio dei gruppi dirigenti vs. una dinamica autonoma e differenziata per singola impresa. La riduzione della base sociale et ampliamento lavoro dipendente vs. mutualizzazione estesa/ totale della impresa. |
|
Esempio 2 - Transizione epidemiologica e sanitaria La riduzione della mortalità si è sviluppata grazie alla 'transizione epidemiologica', quale passaggio da una situazione di prevalenza di malattie infettive a patologie croniche e degenerative, con un conseguente slittamento in avanti dell'età di morte. La transizione sanitaria, fenomeno collegato ma più ampio, è caratterizzato da tre fattori: (a) il miglioramento del tenore di vita (in particolare dell'alimentazione), conseguente allo sviluppo economico; (b) i progressi della biologia e della medicina; (c) i mutamenti culturali e di comportamento igienico-sanitari. La cooperazione sociale ne è direttamente coinvolta dal punto di vista dei determinanti sociali – o distali – della salute, ovvero rispetto al favorire ambienti, condizioni di lavoro e stili di vita sani per maestranze e utenti/clienti dei servizi e delle produzioni. Questo, soprattutto, in riferimento alla crescita delle disuguaglianze, che in primis sono proprio disuguaglianze di salute. |
|||
|
Caratteristiche |
Possibili impatti sulle c.s. |
Discontinuità ambientale/di sistema |
Discontinuità di impresa |
|
A fronte di aumento delle cronicità, insieme ad una maggiore domanda di soluzioni integrate sociosanitarie per via tecnologica, aumenteranno le vulnerabilità epidemiche (zoonosi e non solo) ma anche, per l’aumento delle disuguaglianze, le patologie delle povertà e per l’impatto delle tecnologie le patologie psicologico-psichiatriche connesse. |
Le maestranze della cooperazione sociale sono, prioritariamente, esposte ai rischi di salute relativi alle professioni e alle mansioni svolte. Possibili differenze riguardano/riguarderanno: se e come il contesto di lavoro e se e come il tenore di vita dei lavoratori/trici, eventualmente combinati, potranno migliorare o peggiorare tali rischi. Sul lato della domanda/bisogni, potrà essere necessario prevedere nuovi modelli di servizio adattabili alle emergenze e ad alto contenuto tecnologico insieme alla ridefinizione dei contenuti/ approcci relazionali mediati dalle tecnologie. |
Assunzione vs. non assunzione come temi di policy: 1) dell’epidemiologia delle maestranze e dei loro familiari; 2) della flessibilizzazione dei modelli di servizio a fronte di emergenze impreviste o non facilmente prevedibili (es. Covid 19), in combinato disposto con la digitalizzazione delle prestazioni; 3) della relazionalità in trasformazione per effetto delle tecnologie. Meta-tema, chi e come può assumere i costi/investimenti sia della analisi e definizione delle strategie che della loro attuazione? |
Investire sul personale vs. sulla digitalizzazione quale vettore della sostituzione vs. su entrambi con una riconfigurazione nuova delle relative incidenze? Nel concreto: più welfare aziendale finalizzato alla salute delle maestranze vs. più trasformazione delle funzioni non direttamente assistenziali con soluzioni digitali vs. più digitalizzazione orientata al miglioramento delle condizioni di lavoro…? |
Tabelle simili potrebbero essere redatte per diversi altri aspetti su cui sono in corso evidenti transizioni: la transizione del welfare e della spesa sociale pubblica, la transizione democratica e politica, la transizione digitale e tecnologica, la transizione ambientale, la transizione economica, ecc.
Rimandando ad altri contribuiti per una trattazione più sistematica, quello che si intende qui evidenziare è la necessità di impegnarsi – con i punti di forza e le fragilità che caratterizzano la cooperazione sociale di oggi – nel tentativo di comprendere e condividere la direzione delle molteplici transizioni che attraversano il contesto socioeconomico: un passaggio fondamentale per una cooperazione sociale che non si limiti a subire il cambiamento, ma si attrezzi per portare un proprio contenuto attivo nell’orientare i processi e, conseguentemente, diventi – magari trasformato – un attore protagonista (e non soccombente) degli scenari futuri.
Cambiamenti strutturali in corso: appunti per un approfondimento qualitativo
Come esemplificazione di tipo qualitativo, ci limitiamo a proporre alcune ulteriori considerazioni sulle potenziali implicazioni del combinato disposto tra: l’inversione logica della funzione dei sistemi di welfare (transizione del welfare); la riduzione degli spazi di autonomia del composito mondo del TS (transizione politica); la difficoltà nel costruire una piattaforma di politica economica per il mondo della cooperazione sociale (transizione economica).
4.1 L’inversione logica della funzione dei sistemi di welfare
Una disamina complessiva del welfare italiano e della sua evoluzione non è possibile in questa sede; per quello che qui interessa approfondire, basti dire che, pur nel quadro di un modello di welfare, comune ad altri paesi del sud Europa, fortemente centrato sulla famiglia e sul lavoro femminile (Ferrera 1996) e pur considerando la stratificazione di norme e di misure di fasi ed epoche diverse e taluni evidenti contraddizioni, il welfare italiano si è sviluppato, soprattutto grazie agli impulsi dei “trent’anni gloriosi” post-bellici, in coerenza con il principio inclusivo/emancipatorio/solidaristico riassunto nell’articolo 3 comma 2 della Costituzione, e con il risultato di una progressiva implementazione dei diritti sociali.
Negli ultimi anni, dopo che il binomio “crescita economica – estensione dei diritti sociali” è entrato in crisi a causa di processi sia strutturali (nella globalizzazione, la discrasia tra regimi ordinamentali delle merci e regolazione dei fenomeni migratori), sia culturali (individualismi, razzismi, ecc.) e politici (crisi delle democrazie e crescita delle varie forme di populismo), si sta imponendo una diversa narrazione in cui giorno dopo giorno emerge un potenziale/crescente rifiuto del welfare “cifra di civiltà” (Campedelli 2021) riassunto, per l’appunto nella nostra come in altre Carte dei diritti fondamentali. In altre parole, è come se il welfare diventasse ogni giorno sempre più funzionale a scopi di consenso e di controllo sociale, un welfare insomma che “mentre cura e controlla, discrimina”[5] (Campedelli, Marcello e Tarantino 2025).
Se questo processo di cambiamento della cd. “Costituzione materiale” si consolidasse, è evidente che essi impatterebbero in modo sempre più rilevante sui fondamentali e sulla quotidianità delle cooperative sociali[6]. Quando, per esempio[7], con il consenso diretto o indiretto della propria cittadinanza, la committenza pubblica modifica la regolazione nell’accesso e nella fruizione di prestazione sociali discriminando, in forma simbolica e/o materiale, i bambini e le bambine le cui famiglie non sono in grado di corrispondere la retta della mensa scolastica, esse come si devono comportare? Aprono un contenzioso, o comunque pongono una questione politica, con la quasi certezza che nella valutazione che otterranno nel successivo bando di gara le chance di vincere saranno minime? Rinunciano alla gestione del servizio, mettendo in crisi posti di lavoro? Oppure accettano e accantonano i principi di solidarietà su cui hanno costruito la propria storia, pur di garantire gli occupati?
O, addirittura, quando la committenza pubblica attribuisce direttamente il compito di riscuotere la retta del servizio alla cooperativa appaltatrice, senza che questa possieda il ruolo di autorità pubblica della PP.AA. a vario titolo condiviso con organi di pubblica sicurezza, per cui oltre alla sovrapposizione/confusione di ruoli (p.e. educativo ed esattoriale/sanzionatorio) si scaricano i rischi economici per l’eventuale mancato pagamento, le cooperative come si devono regolare?
In ogni caso, tra tutti gli ETS che hanno rapporti convenzionali con la PP.AA., per le caratteristiche proprie di un’impresa labour intensive, è evidente che la cooperativa sociale si trova maggiormente vincolata nel non poter agire soluzioni exit, pena il rischio di perdita di posti di lavoro, di capitale umano su cui si è investito, di coesione interna della compagine sociale.
Riguardo a quest’ultimo aspetto, vi è da considerare poi un ulteriore insieme di fattori relativi sia alla struttura del mercato del lavoro di cura, sia al cambio generazionale e alla cultura del lavoro di cui le nuove leve, già da qualche tempo, sono portatrici.
Il retroterra culturale originario di chi opera a vario titolo nel welfare, orientato alla militanza politica e ad istanze di cambiamento, nel corso del tempo non è scomparso[8], ma - paradossalmente, proprio grazie al ruolo acquisto dalla cooperazione sociale nella gestione dei servizi di welfare – non è infrequente che l’operatore sociale consideri la cooperativa sociale in cui opera un mero datore di lavoro, l’unico possibile – almeno sino a che non venga indetto un concorso pubblico - per svolgere una determinata attività professionale. L’istanza mutualistica che accompagnava il lavoro sociale delle origini – simboleggiata nella adesione a socio o socia - sembra notevolmente scemata (Fondo Sviluppo 2024). Al contempo sembra cambiato anche il sistema di significati che essi ed esse attribuiscono al lavoro sociale[9]. Soprattutto per le figure medio alte, come educatori/tri, assistenti sociali, infermieri, ecc. l’identità di ruolo e la qualità lavorativa (Venturi e Baldazzini 2022; Fazzi 2024) sembrano sempre più avere la priorità rispetto ad altre dimensioni del noi, condivisibili con i colleghi e le colleghe, con i fruitori e i loro caregiver, con la comunità territoriale di riferimento.
L’impatto che ha avuto l’apertura dei concorsi e delle assunzioni di infermieri e OSS nel SSN a seguito dell’epidemia da Covid-19 è emblematico: a fronte di stipendi più alti, condizioni di lavoro meno incerte, orari e ruoli certi (Bobba e Sepio 2025), molti hanno optato per tale soluzione.
Tutto questo senza poi dimenticare che l’attrattività del lavoro sociale nei confronti delle nuove generazioni, mediamente, è fortemente calata[10].
E se a questo si aggiunge, come effetto della transizione demografica caratterizzata da denatalità e invecchiamento, che le nuove coorti di riferimento si stanno progressivamente riducendo, il puzzle della trasformazione strutturale del welfare che stiamo vivendo è quantomeno delineato.
4.2 Sussidiarietà senza autonomia
La cooperazione sociale è genealogicamente, oltre che giuridicamente, una componente del Terzo settore, a cui le sentenze della Corte costituzionale[11] hanno riconosciuto l’essere espressione della autonoma iniziativa dei cittadini proiettata al perseguimento di finalità di interesse generale e attori titolati nel realizzare la sussidiarietà orizzontale, come indicato dall’art. 118, quarto comma, della Costituzione. Gli enti di Terzo settore e tra questi la cooperazione sociale sono quindi “soggetti qualificati, espressivi del pluralismo sociale orientato al perseguimento del principio di solidarietà, come libera e autonoma espressione della socialità dell’uomo; [ciò] li rende sul piano giuridico-costituzionale interlocutori privilegiati e principali di una pubblica amministrazione che intenda non essere più la solitaria espressione autoritativa del potere, ma il partner di una relazione collaborativa improntata al «coinvolgimento attivo» dei cittadini associati.” (Gori 2020, 12).
Tale rilevante riconoscimento, per la verità scaturito soprattutto in tema di attuazione degli art. 55-57 del CTS sulla co-progettazione e co-programmazione (Frediani 2021), sembra però non considerato, se non proprio contrastato, in sede legislativa dal Governo e dal Parlamento. A fronte dell’ormai completata parte fiscale della riforma del TS (Gro e Sepio 2025) non si possono non considerare i segnali emersi, non certo in modo esclusivo (Novarino 2020), nella attuale contingenza politica nazionale e locale. Ci riferiamo, per citarne alcuni:
- ai ritardi, seppur a macchia di leopardo, nei pagamenti dei crediti da parte dello Stato[12] e degli EE.LL. nei confronti degli ETS, ovviamente con maggiori ricadute problematiche in quelli labour intensive, come le cooperative sociali[13];
- al non riconoscimento delle scelte del contribuente di destinare il proprio 5 per mille agli ETS[14], con il trattenimento da parte dello Stato di 28€ milioni€ di sforamento per il 2023 e di 79 milioni € per il 2024 a seguito della introduzione del tetto a 525 milioni € nel 2022, pari ad una decurtazione di 0,7 (su 5) punti percentuali solo nell’ultimo anno;
- alle modifiche del sistema degli appalti pubblici con il D.LGS. 209 del 31.12.2024 e la decisione di lasciare invariata la revisione dei prezzi per servizi e forniture al 5%, con il riconoscimento solo dell’80% dei costi oggettivi sopraggiunti, e solo sulla cifra eccedente; norma particolarmente impattante per i servizi sociosanitari, socioeducativi e le cooperative sociali di inclusione lavorativa, ulteriore indicatore di un più generale silenzio rispetto ai livelli di remunerazione e alle condizioni di lavoro nel mondo della cooperazione sociale;
- ad una serie di provvedimenti proposti, approvati poi ritirati o successivamente modificati, con la legge di bilancio 2025[15], quali: il controllo diretto da parte del MEF sull’operatività degli ETS che ottengono finanziamenti pubblici per un importo superiore ai 100 mila €; il non rifinanziamento del fondo di contrasto alla povertà educativa “Con i bambini”, successivamente reintegrato in minima parte; l’introduzione di un tetto massimo di spesa detraibile per tutti i contribuenti con reddito compreso tra 75mila euro e 100mila euro, con la conseguente vanificazione di molti degli incentivi alla solidarietà ottenuti con la riforma del Terzo Settore; la riduzione dei crediti di imposta di cui fruiscono le fondazioni di origine bancaria per le loro attività erogative; l’eliminazione degli ETS dal regime di esclusione Iva, poi reintrodotto con la proroga di un solo anno, e ora al vaglio della discussione per l’approvazione definitiva della legge delega per la Riforma Fiscale[16];
- alle osservazioni critiche, sia di merito che di metodo, relative all’accordo interistituzionale tra l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc), il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel) firmato l’8 aprile 2025, formulate da Libera, Legambiente, Arci, CGIL, Avviso Pubblico, Legacoop e Forum del Terzo Settore; per quanto riguarda il metodo, gli organismi firmatari segnalano la marginalizzazione del TS dal processo decisionale, mentre per le questioni di merito si evidenzia una serie di confusioni definitorie e giuridiche che rischiano di “allargare l’approccio privatistico anche ai beni immobili, per i quali l’affitto oneroso e la vendita devono rimanere l’extrema ratio.” [17]
- alla contrapposizione-conflitto con quegli ETS che intervengono in campi particolarmente critici delle politiche pubbliche del Paese, quali quelle del soccorso ai profughi e della loro accoglienza; conflitto che si esprime l’allontanamento forzato dai contesti di salvataggio nel Mediterraneo, o comunque alle frontiere, a cui si aggiungono accuse di complicità nel traffico degli esseri umani, la sottoposizione a sistemi di spionaggio da parte dei servizi segreti, ecc. [18];
- all’utilizzo di eventi drammatici (il naufragio al largo di Cutro del 23 e 24 febbraio 2023; lo stupro di minorenni a Caivano scoperto nell’estate del 2023; ecc.) per ridefinire il profilo delle misure di politica sociale, dentro un quadro sempre più imperniato su risposte di cd. populismo penale (Massaro 2024); fenomeno, questo, che ha visto la modifica più complessiva di alcune policies a seguito della decretazione di urgenza adottata, le cui conseguenze hanno impattato sul sistema di protezione internazionale[19], sulla giustizia minorile[20], sulla condizione del relativo sistema penitenziario[21] e sull’aumento del potere repressivo degli apparati di controllo;
- alla tanto attesa approvazione della normativa quadro per le non autosufficienze (Legge n. 23 del 2023), modificata dalla decretazione successiva in modo contraddittorio rispetto agli indirizzi approvati[22], priva delle risorse necessarie per la sua attuazione (UPB 2024, 413 e ss.gg.), di fatto svuotata rispetto agli indirizzi che aveva stabilito[23].
Se questa sintetica e necessariamente parziale ricostruzione legittima l’affermazione da cui siamo partiti, insieme alle ricadute dirette sulla operatività delle cooperative sociali, ne conseguono due interrogativi, in parte tra loro sovrapponibili:
- si sta delineando una prassi che trasforma la sussidiarietà in subalternità funzionale alle decisioni di una politica sempre più decisionista, ovvero indisponibile a condividere, nella pluralità di ruoli, la definizione e costruzione delle scelte per la collettività?
- vi è l’obiettivo, più o meno dichiarato, di perseguire lo svuotamento di questa parte della Carta fondamentale in quanto espressione di una stagione culturale e politica, peraltro non sedimentata nella opinione pubblica, che si intende cancellare secondo un disegno egemonico di ben altra impostazione?
4.3 Alla ricerca di una politica industriale per l’impresa sociale
Il terzo tema riguarda un insieme di quesiti relativi al fatto che nel nostro Paese ci sia, con quali contenuti, all’interno di quali piattaforme politico-culturali, una politica industriale per l’impresa sociale.
Da una parte, la o le risposte rinviano alle politiche comunitarie in tema di impresa sociale e alla loro prossima ricaduta nell’ambito nazionale (vedi paragrafo successivo). Dall’altra, più o meno implicitamente, la risposta non può che essere positiva: organismi di rappresentanza, reti di varia natura, centri studi specializzati, istituzioni finanziarie, istituzioni pubbliche, ecc., sono di fatto promotrici di policy che riguardano lo sviluppo della cooperazione sociale.
Al contempo, da punti di vista differenti, il tema è a vario titolo direttamente sollevato, o quantomeno evocato, in non pochi degli interventi fino ad ora citati[24] (tra cui: Filippini 2014; Marocchi 2020; Novarino 2020; UP Umanapersone 2023; Borzaga e Salvatori 2024; Bobba e Sepio 2025; Laville 2025). Come se, sintetizzando, malgrado l’oggettiva rilevanza dell’impresa sociale, il dibattito pubblico e scientifico non riuscisse a focalizzare direttamente la questione. Ovvero, si parla di policies ma non, questa è la nostra ipotesi, di politica industriale.
Ciò avviene in un contesto in cui di una politica industriale vi sarebbe un effettivo bisogno, anche considerando che, pur a fronte di numeri di tutto rispetto, la cooperazione sociale si trova, almeno in talune aree, in una posizione di svantaggio competitivo. Ad esempio, un grande competitor delle cooperative di tipo A, nonostante il trend calante riscontrato negli ultimi anni[25], è il composito mondo delle assistenti familiari e delle colf, rappresentato da poco più di 800 mila persone con almeno un contratto registrato all’Inps e, secondo altre stime, di 6-700 mila lavoranti irregolari, per una spesa complessiva a carico delle famiglie di circa 13 miliardi €, pari ai 2/3 del fatturato complessivo delle cooperative sociali.
Rispetto a cosa significhi definire una politica industriale, riprendendo la definizione di Bianchi (2012) almeno tre ne sono i capisaldi:
- è concepita come un fattore di sviluppo economico del Paese (Borgomeo 2013 e 2022), avendo di conseguenza come interlocutrici principali le istituzioni pubbliche che ne definiscono le strategie (i ministeri economici e della funzione pubblica, il Cnel, la Conferenza delle Regioni con gli assessorati alle attività produttive, ecc.);
- è negoziata con l’insieme degli stakeholder interessati, dalle già citate istituzioni alle rappresentanze sindacali e alle associazioni economiche;
- è organica, ovvero tesa a ridisegnare quanto si sta già facendo dentro un quadro che contempli le articolazioni dei temi di sviluppo di una visione di medio periodo.
Su questo ultimo punto, alcune esemplificazioni per una possibile agenda:
- nella fase in cui si impostano le scelte riguardanti la PP.AA. (dalla politica di spesa a quella del personale), vanno considerati il ruolo e le funzioni garantite da queste imprese;
- va affrontata la questione della regolazione dei rapporti tra PP.AA. e ETS evitando derive subdole di sostituzione dei fornitori a puri fini di riduzione di spesa;
- le cooperative sociali vanno considerate un interlocutore per altri settori a domanda crescente solo apparentemente distanti dal loro ambito di attività consolidato, come nel caso del turismo accessibile e assistito, rivolto a persone anziane, disabili e ai loro familiari;
- esse vanno inoltre considerate in un’ottica di emersione e qualificazione del lavoro informale[26] in ambito di cura domiciliare, anche rimettendo in gioco le risorse trasferite dallo Stato in varie forme quali l’indennità di accompagnamento (Campedelli 2018);
- i problemi che si incontrano quando le cooperative sociali si cimentano con una domanda privata pagante (Fazzi 2025) necessitano di una strategia comune;
- il fabbisogno di risorse umane qualificate necessita la messa a fuoco, tra i molti, di due punti nevralgici: la programmazione (professionale e universitaria) e i contenuti (p.e. in tema di digitalizzazione delle prestazioni e dei servizi) della formazione delle figure professionali future;
- i percorsi per la digitalizzazione delle imprese sociali a partire dall’impatto che l’Intelligenza artificiale potrà avere su di esse, non solo rispetto alla digitalizzazione nella gestione amministrativa, ma anche e soprattutto con riferimento alle prestazioni erogate.
4.4 In sintesi
In questo capitolo si è cercato di proporre, seppure come mera esemplificazione del percorso sino ad ora sviluppato, un esempio di come “pensare per scenari” - in particolare con riferimento al welfare, alle politiche e all’economia – porti alla luce elementi rilevanti per definire il contesto in cui la cooperazione sociale opera e le sue trasformazioni:
- l’involuzione del welfare, che obbliga la cooperazione sociale a posizionarsi entro un “welfare che mentre cura e controlla, discrimina”, con tutte le complessità connesse all’essere al contempo un soggetto portatore di istanze ideali e un soggetto economico che assicura la remunerazione dei propri lavoratori, sottoposti peraltro essi stessi ad una mutazione di aspettative e di istanze rispetto al passato;
- la contraddizione tra l’enfasi sulla sussidiarietà e sul ruolo di interesse generale del Terzo settore e i molteplici casi di politiche disattente e ostili;
- la contraddizione tra le indicazioni da parte di molti soggetti (di rappresentanza, di ricerca, ecc.) di policy sulle cooperative sociali e l’assenza di una vera e propria politica industriale che la promuova, considerandola come asset del paese e avviando pertanto a tal fine una interlocuzione tra istituzioni e cooperative sociali finalizzata a delineare percorsi di sviluppo di medio periodo.
Guardando all’Europa
C’è infine un quarto elemento che merita un approfondimento specifico ed è quello che considera il futuro della cooperazione sociale correlato alla implementazione del Piano d’azione europeo per l’economia sociale, un piano decennale approvato nel 2021 relativo ad un l’ecosistema[27] composto da cooperative, società di mutuo soccorso, associazioni, fondazioni e imprese sociali (Salvatori, Scarpat e Schiavone 2022). Il piano è frutto di un lungo percorso. È del 1989 la comunicazione al Consiglio europeo dal titolo Le imprese dell’economia sociale e la realizzazione del mercato europeo senza frontiere, in cui la Commissione sostiene la necessità di creare la base giuridica europea per le cooperative, le associazioni e le mutue e la successiva l’istituzione dell’Unità Economia Sociale presso la Direzione generale XXIII della Commissione. Nel 2009 il Parlamento europeo adotta la Relazione sull’economia sociale, nella quale la si riconosceva come partner sociale per la realizzazione degli obiettivi della strategia di Lisbona l’economia sociale. Nel 2011 la Social Business Initiative (SBI), rappresenta il primo vero e proprio piano d’azione per sviluppare l’economia sociale, seguito appunto dieci anni dopo dal citato Social Economy Action Plan (Salvatori 2022). Nel 2023 la proposta di Raccomandazione (Fondazione Terzjus ETS 2024) del Consiglio dell’Unione Europea elaborata dalla Commissione – coerente con gli orientamenti dell’Oil[28], delle Nazioni Unite[29] e dell’Ocse[30] - invita gli Stati membri per mettere in atto strategie e politiche proprie e flessibili riguardanti l’economia sociale con riferimento (Bertulessi 2024)[31].
In Europa, l’economia sociale conta oltre 4,3 milioni di organizzazioni o imprese, con almeno 11,5 milioni di occupati, il 6,3% della popolazione occupata nell’Ue. Circa un terzo sono impiegate nel settore della sanità e dell’assistenza sociale. A seguire, 702 mila nell’istruzione e 622 mila nel settore delle arti, cultura e intrattenimento. Considerando solo 19 Stati membri Ue, il fatturato aggregato raggiunge i 912,9 miliardi di euro (European Commission 2024).
In Italia, secondo i dati riferiti al 2021-2022[32], siamo in presenza di 400 mila organizzazioni con oltre 1,5 milioni di occupati e 4,7 milioni di volontari. Nei settori della assistenza e sanità, abbiamo 47mila organizzazioni con 540mila occupati. Le cooperative sociali qui considerate, circa 15mila (3,7% del totale delle organizzazioni censite), occupano 473 mila persone (31% del totale).
Da una parte l’approvazione del piano rappresenta un passaggio di grande rilievo di legittimazione dell’economia sociale, cui è stata riconosciuta la “capacità risolutiva degli attori di mercato tradizionali; e dall’altro [di mitigare] la solitudine dei poteri pubblici, che hanno grande forza decisionale ma scarso consenso. L’economia sociale nasce quindi come un progetto dal carattere politico forte, più o meno esplicito, e va a occuparsi di un problema altrettanto politico che è quello della costruzione del consenso attorno alle strategie di sviluppo.” (Salvatori 2025 a).
Dall’altra, più osservatori ritengono che il percorso del Piano sia entrato in una fase critica. Il trasferimento, in seno alla nuova Commissione Europea, dalla Direzione generale Grow (Mercato interno, dell’industria, dell’imprenditoria e delle PMI) alla Direzione generale Empl (Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione) dell'unità dedicata all'economia sociale, recepito con grande preoccupazione da molte organizzazioni coinvolte[33], apre interrogativi non indifferenti relativamente al rischio di perdita delle competenze istituzionali acquisite nell’arco di un decennio e al declassamento, nel sistema delle politiche di sviluppo comunitarie, del contributo di questo ecosistema[34].
A questo si aggiungono i segnali di insofferenza e di delegittimazione provenienti da altre istituzioni europee nei confronti del mondo delle organizzazioni della società civile, in buona parte sovrapponibili a quelle dell’economia sociale[35]. Inoltre, la rimodulazione della politica finanziaria, recentemente indicata dalla Commissione, evidenzia nuove priorità di spesa e sottovaluta le politiche di coesione e, quindi, degli attori chiamati ad attuarle (Salvatori 2025 b).
In questo scenario, le politiche nazionali hanno reagito diversamente. Paesi come la Spagna[36] da tempo hanno sviluppato una propria strategia per l’economia sociale[37]; in Italia solo nei mesi scorsi si è costituito un tavolo di lavoro presso il MEF i cui lavori non hanno ancora portato, alla data di pubblicazione di questo articolo, ad esiti compiuti, anche se vi è da notare come vi siano amministrazioni locali - Bologna[38], Milano[39], Torino[40], Provincia Autonoma di Trento[41] - che non hanno atteso tale documento ed hanno già elaborato o stanno elaborando propri piani locali[42], così come attori del Terzo Settore che stanno co-programmando possibili implementazioni[43].
Conclusioni
Malgrado la sua lunga storia, malgrado la capacità di superare le successive fasi di crisi che hanno interessato il nostro Paese, la cooperazione sociale deve oggi guardarsi dal rischio del “pensiero corto”: di una tendenza a lavorare sull’immanente, sui problemi dell’oggi, senza elaborare un pensiero compiuto sulle transizioni in cui è immersa. Ripercorrendo i capitoli di questo saggio:
- nel capitolo 2 si sono richiamate le caratteristiche della cooperazione sociale e della sua evoluzione, evidenziando gli elementi che rafforzano e quelli che rendono fragile la capacità di adattamento, resilienza e innovazione della cooperazione sociale;
- nel capitolo 3 si è contestualizzato tutto ciò nell’ambito delle molteplici transizioni in corso, tra loro interrelate, proponendo uno schema metodologico di lavoro basato sulla formulazione di scenari nei quali individuare i punti di discontinuità e le possibili evoluzioni della cooperazione sociale;
- nel capitolo 4 si sono sviluppate a titolo esemplificativo, tre questioni derivanti dalla combinazione degli scenari negli ambiti del welfare, delle politiche e dell’economia, e cioè l’evoluzione del welfare, le ambivalenze dell’enfasi sulla sussidiarietà, l’urgenza di una politica industriale per la cooperazione sociale;
- nel capitolo 5 ci si è aperti alla considerazione dello scenario europeo e dei suoi riflessi a livello nazionale, considerando da una parte la significativa progressiva legittimazione dell’economia sociale, dall’altra alcuni segnali preoccupanti circa l’accantonamento di tale tematica a livello comunitario.
Il passaggio successivo, lasciato a chi vorrà raccogliere lo sforzo di questo contributo, è sviluppare nel merito una strategia per la cooperazione sociale che tenga conto di tutto ciò, proiettandosi nei prossimi decenni, con la capacità di mettere a frutto le potenzialità e di contrastare le criticità degli scenari qui abbozzati.
DOI 10.7425/IS.2025.03.02
Bibliografia
Ansalone G., 2025, La guerra e una nuova politica industriale, Affarinternazionali, 5 agosto 2025, https://www.affarinternazionali.it/la-guerra-e-una-nuova-politica-industriale/.
Aresu A., 2025, La frontiera infinita, Aspenia, n.2, 2025.
Ascoli U. e Campedelli M. 2021, Insostuibilità, riconoscenza, integrazione funzionale: la parabola del Terzo Settore nella pandemia, Politiche sociali/Social Policies, VII,2,2021, maggio agosto, Bologna, Il Mulino.
Bauman Z., 2020, Retrotopie, Laterza, Bari-Roma.
Barbetta G., Canino P., Cima S. e Gallo B., 2021, L’Impatto del Covid-19 sugli enti di Terzo settore. Prime stime sui dati delle candidature al Bando LETS GO!, Collana “Quaderni dell’Osservatorio” n. 35, Anno 2021, Fondazione Cariplo, Milano.
Blangiardo G.C., Brugnoli A., Fattore M., Maggino F. e Vittadini G., (a cura di), 2022, Sussidiarietà e ... sviluppo sociale. Rapporto sulla sussidiarietà 2021/2022, Milano, Fondazione Sussidiarietà.
Bianchi P., 2012, Politica industriale, Dizionario di economia e finanza, Fondazione Treccani, https://www.treccani.it/enciclopedia/politica-industriale_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/.
Bertulessi S., 2024, Una raccomandazione per sfruttare il potenziale dell'economia sociale, Impresa sociale 1/2024.
Bobba L. e Sepio G., 2025, Terzo settore, occupati in crescita ma redditi bassi, Il Sole 24 Ore, 17 luglio, pag. 23.
Borgomeo C., 2013, L’equivoco del Sud. Sviluppo e coesione sociale, Roma-Bari, Laterza.
Borgomeo C., 2022, Sud. Il capitale che serve, Milano, Vita e Pensiero.
Borzaga C., Calzaroni M., Fontanari E. e Lori M., 2022, L’economia sociale in Italia: dimensioni ed evoluzione, Impresa sociale 2/2022.
Borzaga C. e Salvatori G., 2024, La cooperazione in Italia tra realtà e narrazioni, Vita e Pensiero, 1, 2024.
Borzaga C. e Tallarini G., 2021, Social Enterprises and COVID-19: Navigating between Difficulty and Resilience, JEOD - Vol. 10, Issue 1 (2021).
Campedelli M., 2018, La governance dei fondi sanitari integrativi: un ruolo per le Regioni?, Milano, Franco Angeli.
Campedelli M., 2021, «I poveri li avete sempre con voi» (Mt. 26,11) - Un inquadramento concettuale e metodologico del welfare religioso cattolico, in M. Campedelli, G. Marcello, R. Marinaro, F. Marsico e S. Tanzarella (a cura di), Dentro il welfare che cambia. 50 anni di Caritas, al servizio dei poveri e della chiesa, Vol. 1, Prospettive teologico pastorali del ministero della carità, pp. 17-322, https://archivio.caritas.it/ home_page/area_stampa/00009527_Rapporto_Dentro_il_Welfare_che_cambia.
Campedelli M., Carrozza P. e Pepino L., 2010, (a cura di), Diritto di wefare. Manuale di cittadinanza e istituzioni sociali, Bologna, Il Mulino.
Campedelli M., Marcello G. e Tarantino C., 2025, (a cura di), “Perseguitare i gruppi impotenti”. Sul welfare controintuitivo, Politiche sociali/Social policies, XI, 3/2025, settembre-dicembre, Bologna, Il Mulino, in corso di pubblicazione.
CGM – Consorzio Nazionale Gino Mattarelli, 2024, Direzioni. Intelligenze collettive per una nuova economia sociale: position paper della XV Convention CGM,PandoraRivista, 5 giugno 2024, https://www.pandorarivista.it/articoli/direzioni-position-paper-della-xv-convention-cgm/.
Consiglio Direttivo della Scuola di Giornalismo Lelio Basso (a cura di), 2025, Fuori classe. Vent’anni di scuola di giornalismo Lelio Basso, Milano, Altraeconomia edizioni.
Costa M. and Delbono F. (2023), Regional resilience and the role of cooperative firms, Social Enterprise Journal, Vol. 19 No. 5, pp. 435-458. https://doi.org/10.1108/SEJ-07-2022-0064.
Costa M.., Delbono F. e Caselli G., 2021, What do cooperative firms maximize, if at all? Evidence from Emilia-Romagna in the pre-Covid decade, AnnPublicCoopEcon.2021;1–27. wileyonlinelibrary.com/journal/apce.
Delvecchio M., Lega F., Longo F., 2010, La sanità futura. Come cambieranno gli utenti, le istituzioni, i servizi e le tecnologie, Milano, Università Bocconi Editore.
Dell’Acqua P. 2022, Il lavoro e la cura. Dall’ergoterapia alla cittadinanza, in Nuova Secondaria – n. 2, ottobre 2022, anno XL.
European Commission: European Innovation Council and SMEs Executive Agency, CIRIEC, Euricse, Spatial Foresight, Carini, C. et al., Benchmarking the socio-economic performance of the EU social economy – Improving the socio-economic knowledge of the proximity and social economy ecosystem, Publications Office of the European Union, 2024, https://data.europa.eu/doi/10.2826/880860.
Fazzi L.,2022, Il welfare mix, in C. Gori (a cura di) Le politiche del welfare locale, Mondadori, Milano.
Fazzi L., 2024, Lavorare stanca: chi va e chi resta nelle cooperative sociali?, Impresa sociale 2/2024.
Fazzi L., 2025, La mercatizzazione strisciante. Ibridazione, Terzo settore e welfare locale in Italia, Politiche sociali/Social policies, XI, 3/2025, settembre-dicembre, Bologna, Il Mulino, in corso di pubblicazione.
Ferrera M., 1996, The “Southern model” of welfare in social Europe, in Journal of European Social Policy, 6, 1, pp.82-107.
Filippini M., (a cura di), 2014, Politica e discipline della cooperazione, Scienza e Politica, XXVI, n. 50, 2014.
Fondazione Terzjus ETS (a cura di), 2024, Verso un diritto europeo del Terzo settore. 1° Rapporto sul quadro giuridico dell’Economia sociale in Europa, Napoli, Editoriale Scientifica.
Fondo Sviluppo, 2024, I soci lavoratori nelle cooperative (2014-2023), Studi & Ricerche 270, novembre 2024, https://fondosviluppo.it/Portals/0/Studi%20e%20Ricerche/Studi%20&%20Ricerche%20n.%20270%20Novembre%202024.pdf.
FDD Forum-Disuguaglianze Diversità e IrisNetwork, 2021, Quale ruolo dell’impresa sociale nel potenziamento e democratizzazione dell’offerta di servizi di welfare, https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/wp-content/uploads/2021/03/Doc-ForumDD_IrisNetwork.x72864.pdf.
Frediani E., 2021, La co-progettazione dei servizi sociali. Un itinerario amministrativo, Torino, Giappichelli.
FTS – Forum Terzo Settore - e Openpolis, 2025, Il Pnrr a un anno dalla conclusione. Il punto del Terzo settore, in www.pnrr.forumterzosettore.it.
Gori L., 2020, Inquadramento generale, in Gori L. e Monceri F., Collaborare, non competere. Co-programmazione, co-progettazione, convenzioni nel Codice del Terzo settore, I Quaderni Quadrimestrale n. 85 giugno 2020, Firenze, Cesvot.
Gro D. e Sepio G., 2025, Enti del Terzo settore, passaggio morbido per la non commercialità, in Il Sole 24 Ore, sabato 19 luglio 2025, pag. 23.
Ican - International Campain to Abolish Nuclear Weapons, 2025, Hidden costs: nuclear weapons spending in 2024. Report, icanw.org.
IPSOS, 2024, UP Umanapersone. E-commerce e servizi sociosanitari. Risultati dell’indagine, dicembre 2024, in corso di pubblicazione sul sito www.umanapersone.it.
Laville J.L., 2025, Cooperatives: A Historical and Theoretical Perspective, JEOD, Vol. 14 (2025).
Maino F., Rizzini C.L., Fanelli A.S., Florio R. e Legante G., 2025, L’economia sociale in Italia. Traiettorie, criticità e prospettive secondo esperti ed esperte, Percorsi di Secondo Welfare, https://www.secondowelfare.it/expert-survey/economia-sociale-in-italia/.
Marocchi G., 2020, L’impresa sociale fa politica?, Impresa sociale 1/2020.
Marocchi G., 2023, Molte delle cose che credevamo sull’inserimento lavorativo sono false. E, quindi, quali sfide ci aspettano per il futuro, Impresa sociale 1/2023.
Marocchi G., 2024, Le cooperative sociali, tra dati e narrazioni, Working Paper n. 134 | 24, Trento, Euricse.
Marocchi G., 2025, La sentenza che Carlo Borzaga avrebbe amato, Forum di Impresa sociale, https://www.rivistaimpresasociale.it/forum/articolo/la-sentenza-che-carlo-borzaga-avrebbe-amato.
Massaro A., 2024, La risposta punitiva a disagio giovanile, povertà educativa e criminalità minorile: profili penalistici del c.d. Decreto Caivano, in Processo Penale e Giustizia, fascicolo 2/2024, Torino, Giappichelli.
Morniroli A. e Scancarella G., 2025, Non facciamo del bene. Inchiesta sul Lavoro sociale tra agire politico e funzione pubblica, Roma, Donzelli.
Natoli S., 2015, Il buon uso del mondo. Agire nell’età del rischio, Milano, Mondadori.
Nazioni Unite, 2024, Promoting the social and solidarity economy for sustainable development. Note by General Secretary, General Assembly, N. York, 23 september 2024.
Novarino M, 2020, Il Terzo settore e l'impresa sociale nella cultura politica del Paese, in Dossier Impresa sociale e democrazia, 30 marzo 2020, Impresa sociale, https://www.rivistaimpresasociale.it/forum/articolo/terzo-settore-e-cultura-politica.
Salvatori G., 2022, Imprese sociali, economia sociale e le politiche dell’Unione Europea, in Bobba L., Fici A., Gagliardi C. (a cura di).
Salvatori G., 2025 a, L’economia sociale tra Europa e Italia, intervista a cura di Daniele Molteni, PandoraRivista, 14 giugno 2025, https://www.pandorarivista.it/articoli/l-economia-sociale-tra-europa-e-italia-intervista-a-gianluca-salvatori/.
Salvatori G., Scarpat F. e Schiavone A., 2022, La rilevanza dell’economia sociale in Italia, in Blangiardo e A.ii, 2022.
SIPRI, 2025, Trends in world military expenditure 2024, SIPRI Fact Sheet April 2025, curato da X.Liang, N.Tian, D.Lopes da Silva, L.Scarazzato, Z.Karim, J.G.Ricard, https://doi.org/10.55163/AVEC8366.
UP Umanapersone, 2023, Per una politica industriale dell’impresa sociale, Impresa Sociale 3/2023.
UPB Ufficio Parlamentare di Bilancio, 2024, Rapporto sulla politica di bilancio 2024, 7 giugno 2024, Roma, https://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2024/06/Rapporto_2024_pol_bil.pdf.
Venturi P. e Baldazzini, 2022, Il Lavoro come opera. Aspirazioni ed aspettative dei giovani cooperatori sociali nei principali risultati dell’indagine Aiccon, S h o r t p a p e r 2 5 / 2 0 2 2, Bologna-Forlì, AICCON https://www.aiccon.it/pubblicazione/il-lavoro-come-opera/.
Venturi P. e Zandonai F., 2014, Ibridi organizzativi. L’innovazione sociale generata dal Consorzio CGM, Bologna, Il Mulino.
Vesco A. e Belloni G. (a cura di), 2024, L’assedio del sociale. Il Terzo settore tra criminalità, mercato e politica, Sesto San Giovanni (Mi), Mimesis.
Wilkinson L.,1995, How To Build Scenarios, Wired, november 1, 1995, https://www.wired.com/1995/11/how-to-build-scenarios/.
[1] Fazzi (2024,62) definisce tale processo come una “ibridazione alla rovescia”.
[2] Una dimostrazione di tale stato di cose, ad esempio, è riscontrabile nella polemica sui medici “gettonisti”, in cui non si fa differenza tra essi e le cooperative di sanitari convenzionate con il SSN, cfr. IlSole24Ore dell’11 agosto 2025 - https://www.ilsole24ore.com/art/gettonisti-e-cooperative-ecco-perche-serve-chiarezza-ruolo-terzo-settore-AH0M2p8B
[3] Ricollegandoci a quanto detto in premessa, basti pensare a: la managerializzazione e l’adozione di approcci gestionali di tipo aziendalistico; l’ibridizzazione con profit e public e, recentemente, con la finanza di investimento; lo sviluppo di modelli a rete, a forma di holding e/o di distretto sociale; le ricorrenti modifiche/riconfigurazioni nei rapporti con la pubblica amministrazione; ecc.
[4] Sulla resilienza del modello cooperativo considerato nel suo insieme cfr. Borzaga e Tallarini 2021; Costa, Delbono e Caselli 2021; Costa e Delbono 2023; Salvatori, Scarpat e Schiavone 2022.
[5] Di grande efficacia la raccolta collettanea di inchieste sociali di un gruppo di allievi della Scuola di giornalismo Lelio Basso (Consiglio Direttivo della Scuola di Giornalismo Lelio Basso, a cura di, 2025).
[6] Su alcuni aspetti di tale questione, la rivista Impresa Sociale ha dedicato un Dossier – Impresa sociale e democrazia - nel numero 1/2020, cfr. https://www.rivistaimpresasociale.it/dossier/impresa-sociale-e-democrazia
[7] Non è questa la sede per analizzare studi di caso. Gli esempi concreti, raccolti dalla cronaca, non mancano. Tra essi, esempi significativi solo le scelte adottate dal Comune di Monfalcone e da quello di Montevarchi (Ar), solo per citare quelli più conosciuti.
[8]Significativo l’andamento dell’impegno volontario, cfr. https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/07/REPORT_Il-volontariato-in-Italia_anno-2023.pdf
[9] Seguendo la riflessione di Salvatore Natoli, per cui il lavoro è sempre stato un mix variabile di costrizione e creazione (Natoli 2015), le nuove generazioni, con realismo, cercano di fare i conti con la prima dimensione per valorizzare il più possibile la seconda. In merito alla situazione interna al mondo della cooperazione cfr. il focus di Impresa Sociale, n.2/2024, su Lavorare nel sociale, https://www.rivistaimpresasociale.it/rivista/numero/rivista-num-2-2024
[10] Come racconta un giovane ex operatore sociale: “Me ne sono andato perché oramai il mio lavoro era solo rifare i letti e pulire i vecchietti. Senza possibilità di fare nulla di nuovo, di provare a costruire con loro una socialità diversa. Anzi, schiacciato dalle mansioni in un’ottica aziendale. In questo quadro i 1200 euro al mese del mio stipendio erano davvero troppo pochi. Oggi guadagno di più lavorando in un bar di quartiere. Peraltro, quando finisco ho la testa libera e non mi porto a casa la tristezza che mi veniva nel vedere le persone trattate come merce.” Nelle sue parole c’è tutto: rendono chiara perfettamente la necessità di motivazione, democraticità …. e di trovare altri modi (e non altre metriche) per valutare il lavoro sociale.” (Morniroli e Scancarello 2025, 85).
[11] Tra le altre: n. 75 del 1992, n. 500 del 1993, n. 300 del 2003, n. 309 del 2013, n. 185 del 2018, n. 131 del 2020.
[12] Da ultima, la vicenda di una cooperativa sociale impegnata nella accoglienza di profughi e richiedenti asilo, raccontata sulla piattaforma del mensile Vita da A. Moretti il 13 agosto 2025. Cfr. https://www.vita.it/idee/la-burocrazia-kafkiana-che-soffoca-il-terzo-settore-sulla-pelle-dei-lavoratori-del-sociale/
[13] Per un approfondimento sulla situazione toscana, cfr. la tesi di laurea di Tommaso Gabelli, relatrice la professoressa Elena Gori dell’Università di Firenze, dal titolo “Settore no-profit: prospettive, approcci manageriali eimplicazioni dei ritardi nei pagamenti, AA 2023-24 https://umanapersone.it/site/wp-content/uploads/2024/07/Tesi-Tommaso-Gabelli.pdf
[14] È del luglio 2025, promosso da oltre 65 ETS, l’appello rivolto al Presidente del Consiglio in merito a tale problema. Cfr. https://www.vita.it/tag/5-per-mille-ma-per-davvero/
[15] Cfr. https://www.welforum.it/cosa-prevede-la-legge-di-bilancio-2025-su-politiche-sociali-e-terzo-settore/
[16] Cfr. https://www.vita.it/tag/iva/
[17]Cfr. https://www.forumterzosettore.it/files/2025/04/lettera_anbsc_cnel_mimit_8aprile25.pdf
[18] La cronaca è ricchissima di esempi. Basti pensare al cd Decreto Piantedosi (Decreto Legge n.1, 2 gennaio 2023) emanato pochissimi mesi dopo l’insediamento del Governo Meloni, su cui si è espressa ridimensionando il suo carattere punitivo, la Consulta con la sentenza 101/2025 dell’8 luglio 2025; cfr. https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20250708132247.pdf. O al cd scandalo Paragon, in cui, tra altri, attivisti di Mediterranea Saving Humans sono stati controllati dai servizi segreti italiani attraverso spyware forniti da una società israeliana, poi ritiratasi per la mancanza di risposte da parte del Governo italiano in merito a tale uso, cfr. Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, resoconto della seduta del 4 giugno 2025. https://documenti.camera.it/_dati/leg19/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/034/004/INTERO.pdf
[19] Cfr. https://cir-rifugiati.org/2023/05/12/dl-decreto-cutro-e-legge-cosa-cambia-in-materia-di-procedure-di-riconoscimento-della-protezione-internazionale-e-il-trattenimento-dei-richiedenti-asilo/
[20] Cfr. https://lavialibera.it/it-schede-2146-giustizia_minorile_corte_costituzionale_valuta_decreto_caivano_su_stop_messa_alla_prova
[21] Cfr. l’audizione di Antonio Sangermano, Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con focus sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza, da parte della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, seduta n. 20 del 2 luglio 2024, https://documenti.camera.it/leg19/resoconti/commissioni/stenografici/html/36/indag/c36_condizione_minori/2024/07/02/indice_stenografico.0020.html
[22] Cfr.: https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1354643.pdf?_1668849043688; https://www.welforum.it/fuoridalcoro/riforma-non-autosufficienza-tradimenti-e-rinvii/
[23] Cfr. https://lavoce.info/archives/107460/assistenza-agli-anziani-una-riforma-svuotata/
[24]A partire, peraltro, anche dalle ultime sentenze in ordine di tempo della Corte costituzionale. Cfr.il commento di G. Marocchi sulla sentenza 116 del 2025 https://www.rivistaimpresasociale.it/forum/articolo/la-sentenza-che-carlo-borzaga-avrebbe-amato
[25] Cfr. https://www.welforum.it/meno-badanti-e-il-tramonto-del-welfare-low-cost/
[26] Cfr. https://www.secondowelfare.it/primo-welfare/per-una-riforma-che-riforma-la-sperimentazione-della-dote-di-cura/
[27] Esso è rappresentato da Social Economy Europe, un organismo di coordinamento delle rappresentanze nazionali e di supporto alle istituzioni europee, Cfr. https://www.socialeconomy.eu.org/the-social-economy/
[28] https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/publication/wcms_864920.pdf
[29] Cfr. https://docs.un.org/en/A/RES/77/281
[30] https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=ocse%2C+economia+sociale&ie=UTF-8&oe=UTF-8
[31] https://www.rivistaimpresasociale.it/rivista/articolo/sfruttare-il-potenziale-dell-economia-sociale-la-raccomandazione-del-consiglio
[32] Per i dati in dettaglio cfr. Euricse https://euricse.eu/it/economia-sociale-italia/. Per un approfondimento cfr. Borzaga C., Calzaroni M., Fontanari E. e Lori M., L’economia sociale in Italia: dimensioni ed evoluzione, Impresa sociale, n.2, 2022
[33] Cfr. https://www.socialeconomy.eu.org/2025/04/30/the-implications-of-dg-grow-abandoning-the-social-economy-at-a-critical-juncture/
[34] Tenuto anche conto dell’indebolimento, con la nuova Commissione Van der Leyen, della strategia sociale della Unione, cfr. https://www.secondowelfare.it/primo-welfare/europa-sociale-unione-europea-nuova-commissione-politiche-sociali/
[35] Cfr. https://euromedrights.org/publication/unprecedented-attacks-on-ngos-in-the-eu-we-call-on-all-democratic-forces-to-act-for-a-strong-and-independent-civil-society/
[36] Cfr. https://www.mites.gob.es/EconomiaSocial/es/index.html
[37] Oltre alla Spagna, altri paesi che hanno normato e stanno attuando piani specifici per l’economia sociale e/o per le imprese sociali, abbiamo il Portogallo, la Francia, la Grecia, la Polonia, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria, cfr. European Commission 2024, 37 e ss.gg.
[38] Cfr. https://economiasocialebologna.it
[39] Cfr. https://economiaelavoro.comune.milano.it/index.php/news/tag/economia-sociale
[40] Cfr. https://www.torinosocialimpact.it/attivita/il-piano-metropolitano-di-torino-per-leconomia-sociale-a-partire-dalle-strategie-europee-e-nazionali/
[41] Cfr. https://www.economiasolidaletrentina.it/centro-economia-solidale/
[42] Per una rassegna cfr. https://www.pandorarivista.it/?s=economia+sociale
[43] Il 25 luglio 2025, Fondazione Terzjus ETS e Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) hanno siglato un Protocollo d’Intesa che mira a sostenere e valorizzare il Terzo settore attraverso l’attivazione di strumenti innovativi di finanza sociale, la promozione del volontariato d’impresa e la creazione di un Osservatorio dedicato al monitoraggio del Piano Nazionale per l’Economia Sociale. Cfr. https://terzjus.it/articoli/fondazione-terzjus-e-cdp-protocollo-intesa-terzo-settore/


